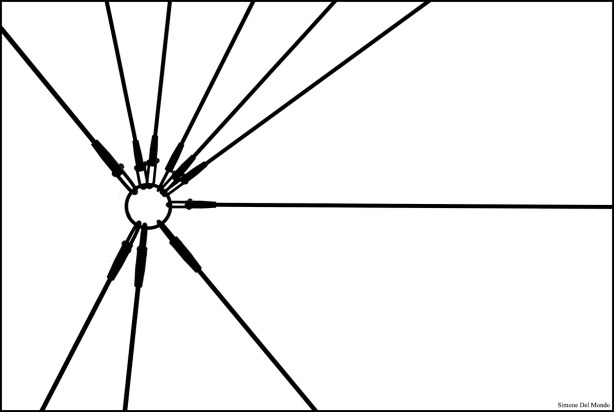Un suonatore di violino è l’ottavo antenato di Jovanotti. Sogna di diventare un virtuoso del suo strumento, ma incontra un amore malato per il quale rinuncia al suo sogno e si chiude in un mondo di gelosia e tristezza. Quando oramai la strada che porta al suo desiderio è preclusa (un sentiero non più calpestato si copre, negli anni, di rovi e cespugli) se ne va anche la donna da lui amata, e lo lascia proprio per un uomo che è diventato un violinista… Morale? “Mi insegnò che rinunciare all’ambizione è sbagliato, che poi la dea si vendica se c’hai rinunciato”. Come fare, allora, a non pensare a George Gray, uno dei morti di Spoon River, di cui Edgar Lee Masters “trascrive” gli epitaffi? Si parte da un’immagine: una barca ferma in un porto con le vele ammainate. Visto che a parlare è una persona che ha concluso la propria esistenza, viene da pensare che quella barca sia arrivata alla fine del suo viaggio. Invece no: “In realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita”. E lo spazio del rimpianto si fa largo: “Perché l’amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno; il dolore bussò alla mia porta, e io ebbi paura; l’ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti.” Penso che a volte si confonda l’ambizione con l’arrivismo, la sana coltivazione di un desiderio con la voglia di avere ed essere sempre e comunque più di quel che si ha e si è. Vedo qui l’ambizione come un modo di vivere appieno la possibilità che viene data all’uomo con la vita; l’epitaffio si conclude così: “Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita. E adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino, dovunque spingano la barca. Dare un senso alla vita può condurre a follia ma una vita senza senso è la tortura dell’inquietudine e del vano desiderio – è una barca che anela al mare eppure lo teme.”
Un suonatore di violino è l’ottavo antenato di Jovanotti. Sogna di diventare un virtuoso del suo strumento, ma incontra un amore malato per il quale rinuncia al suo sogno e si chiude in un mondo di gelosia e tristezza. Quando oramai la strada che porta al suo desiderio è preclusa (un sentiero non più calpestato si copre, negli anni, di rovi e cespugli) se ne va anche la donna da lui amata, e lo lascia proprio per un uomo che è diventato un violinista… Morale? “Mi insegnò che rinunciare all’ambizione è sbagliato, che poi la dea si vendica se c’hai rinunciato”. Come fare, allora, a non pensare a George Gray, uno dei morti di Spoon River, di cui Edgar Lee Masters “trascrive” gli epitaffi? Si parte da un’immagine: una barca ferma in un porto con le vele ammainate. Visto che a parlare è una persona che ha concluso la propria esistenza, viene da pensare che quella barca sia arrivata alla fine del suo viaggio. Invece no: “In realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita”. E lo spazio del rimpianto si fa largo: “Perché l’amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno; il dolore bussò alla mia porta, e io ebbi paura; l’ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti.” Penso che a volte si confonda l’ambizione con l’arrivismo, la sana coltivazione di un desiderio con la voglia di avere ed essere sempre e comunque più di quel che si ha e si è. Vedo qui l’ambizione come un modo di vivere appieno la possibilità che viene data all’uomo con la vita; l’epitaffio si conclude così: “Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita. E adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino, dovunque spingano la barca. Dare un senso alla vita può condurre a follia ma una vita senza senso è la tortura dell’inquietudine e del vano desiderio – è una barca che anela al mare eppure lo teme.”
Lo zio di un mio trisnonno suonava il violino,
il suo sogno era di essere un grande virtuoso.
Poi si innamorò di una che gli cambiò il destino,
lasciò perdere il violino divenne triste e geloso.
Dopo un sacco di anni che stavano insieme,
quando aveva rinunciato al suo sogno di artista,
lei se ne andò via con i profumi e le creme
e si mise con uno che faceva il violinista.
Mi insegnò che rinunciare all’ambizione è sbagliato,
che poi la dea si vendica se c’hai rinunciato.