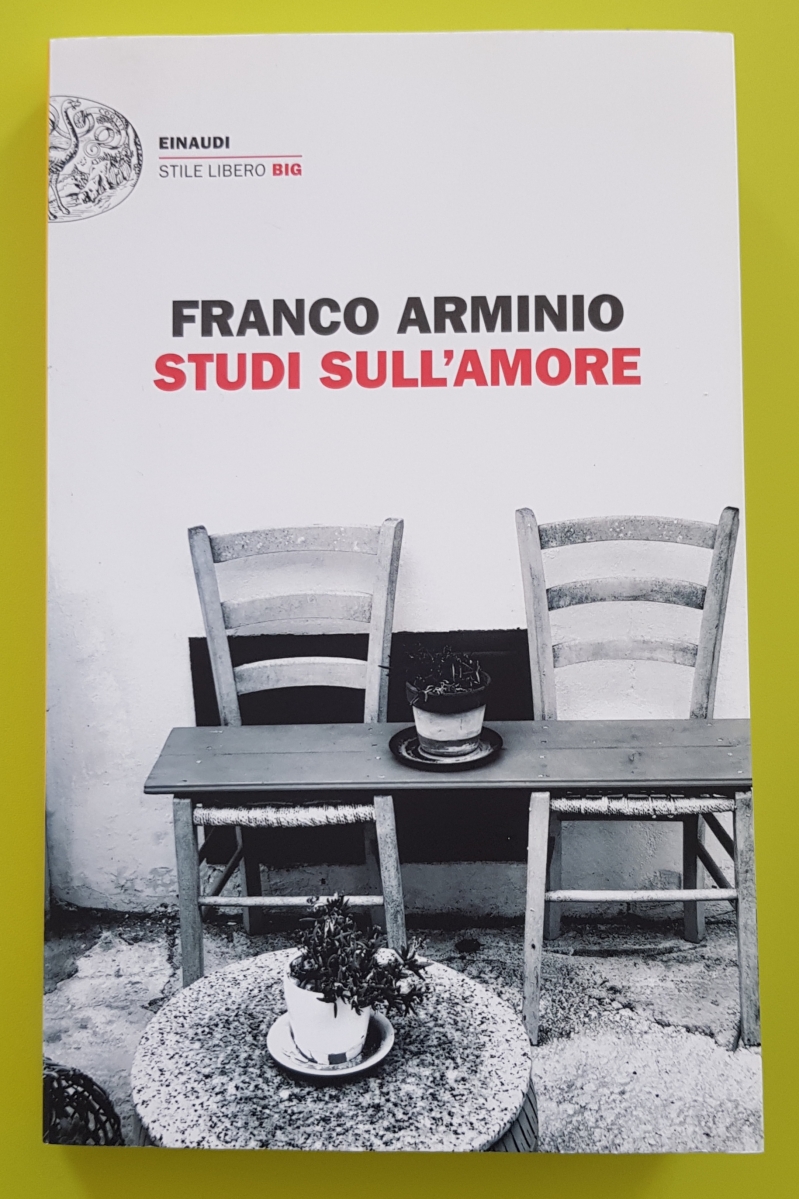“Questa è l’ultima gemma e questo mi dispiace molto in quanto pensare che l’anno prossimo non avrò più un momento così bello, intimo e profondo mi rattrista parecchio e quindi voglio subito lasciare un messaggio a chi leggerà questa gemma: godetevi ogni anno questo momento e portate veramente qualcosa di significativo per voi perché è veramente un bel momento, non sprecatelo.
Questa gemma è iniziata molto tempo fa, l’ho iniziata a scrivere a luglio del 2023, prima del concerto di Blanco del 20 luglio, poi l’ho lasciata in sospeso per un po’, l’ho ripresa a scrivere verso fine agosto e poi l’ho conclusa pochi giorni prima di presentarla in classe.
I temi erano vari e non sapevo di cosa parlare, se della mia famiglia, se dell’amore e dell’amicizia, se del valore della vita o dei problemi di essa… alla fine ho deciso di parlare un po’ di me stesso con l’intento di lasciarvi un messaggio e ho deciso di portare 2 canzoni, con la speranza attraverso questa gemma di lasciare un messaggio almeno a qualcuno e di far riflettere.
La prima si intitola Mezz’ora di sole di Blanco e riporterò qua di seguito una parte del testo, non tutto, che poi commenterò.
“Mi sento rinato
Sono figlio del tempo
Sono in quel parco, nel 2018
Sporco di fango, mi volevo ammazzare”
Mi sento rinato nel senso che in questo percorso delle superiori mi sento cresciuto e maturato e mi reputo una persona migliore, soprattutto rispetto al 2018 che Blanco cita, anno in cui i miei genitori si sono lasciati ed è stato un periodo veramente brutto per me, in cui ho pensato veramente di volermi ammazzare in quanto ero piccolo e pensavo di essere io il problema. Alla fine però questa separazione è servita in quanto ora sia i miei genitori che io stiamo bene. Inoltre Blanco si definisce figlio del tempo, e in un certo senso anche io. C’è un aspetto positivo ossia il fatto che mi lascio trasportare dal tempo e mi vivo la vita così come va (Blanco in una sua canzone dice “Vada come vada, la vita è un’autostrada”), invece l’aspetto negativo è che il tempo scorre e non me ne rendo conto. Questo lasciar trascorrere ti porta sempre a non preoccuparti, a dire che c’è tempo, che sono giovane e ho una vita davanti (grande cazzata). La vita è molto breve e non si può sempre rimandare e lasciarsi trasportare.
“E ti porto con me
Dove il cielo si fa buio
Dove BLANCO è poi cresciuto
Dove tutto è maledetto, eh, eh
E ti porto con me
Perché ho paura da solo
Perché violenti il mio sfogo
Però ne ho troppo bisogno, oh”
Questo pezzo di canzone è dedicato alla gemma, nel senso che attraverso essa vi porto con me, nella mia parte più intima e personale “dove il cielo si fa buio e dove sono cresciuto” e inoltre la gemma “violenta il mio sfogo” anche se poi mi rendo conto che forse esporre questi problemi non serve a nulla se non a sfogarmi, serve appunto a liberarmi per quella “mezz’ora” in classe però poi una volta finito tutto devo fare i conti con me stesso e rendermi conto che questi problemi ci sono ancora.
“Dammi mezz’ora di sole
A peso morto nel mare, tra le, tra le onde
Mezz’ora di sole, chiuso in questa prigione
Da-dammi libertà, ah”
Questa canzone è una richiesta di libertà, che io al momento, nonostante sia maggiorenne e dunque certe scelte possa compierle da solo, non mi sento di avere; non mi sento libero da me stesso e dalle scelte che faccio e dunque mi sento chiuso come in una prigione.
“Ho toccato il fondale
Senza mai respirare
Strillando in labiale mentre andavo giù
Fanculo a questo dolore
La gente non lo capisce”
Questo ultimo pezzo della canzone invece è sempre collegato all’episodio che ho raccontato all’inizio, ed è vero che la gente non capisce ancora il dolore che ho provato e quanto io “abbia toccato il fondale” più volte nel corso della mia vita, ma questo è anche dovuto al fatto che sono una persona molto riservata, che non condivide molto della sua vita e mi faccio conoscere veramente solo da poche persone.
Infine trovo il video della canzone molto simbolico in quanto vedo il faro del video come una prigione, da dove lui è scappato per avere solo mezz’ora di sole, per sentirsi un momento libero, però poi ci rendiamo conto che non si può scappare dai nostri problemi e bisogna affrontarli e risolverli e dunque verso la fine del video torna verso la prigione per probabilmente chiudere i conti con se stesso e con il passato.
Poi ho deciso di portare una seconda canzone che si intitola Essere me ed è di Villabanks e Tananai.
Prima di analizzare parte del testo (non tutto) ci tenevo solo a dire che per me questa canzone è qualcosa di veramente speciale e profondo, con un testo molto bello e maturo che fa riflettere e piangere.
“Perché stare qua mi chiedevo a cosa serve
Sicuramente a un cazzo se scordo le cose belle”
Spesso tendiamo a trascurare i momenti belli della vita, soprattutto quando abbiamo dei momenti no, ma è proprio in quei momenti che dobbiamo avere la forza, in mezzo a tutto quel nero, di tirare fuori le cose belle che ci circondano per uscirne fuori e stare meglio. Credo che i momenti no ci servano a crescere e a maturare come persone, però non si può sempre stare male e come dice Villa, non serve a nulla chiedersi a cosa serve la vita se ci dimentichiamo il vero valore di essa e le cose belle.
“Ho dato un senso alla mia vita, miro a qualcosa d’eterno
Me ne fotto d’avere un Range Rover
E spero mi capisca almeno la mia generazione
Credo lo vogliano anche loro un mondo migliore
E se lo creano con ogni singola azione
Molti sono persi
È facile farsi tentare dal male”
Questa parte di testo forse è un po’ scollegata dal resto della canzone e dal suo significato principale e anche dal tema un po’ variegato che io vorrei portare con questa gemma, però come ho detto all’inizio, mi sento di dover dare un messaggio alla mia generazione e vorrei dirvi di costruirvi da soli il vostro futuro, con le vostre mani, anche se cadrete e vi farete male, alzatevi e andate avanti mirando a qualcosa che possa durare in eterno, lo so che è difficile. Createvi il vostro mondo con ogni singola azione e non fatevi tentare da ciò che vi potrebbe allontanare dal vostro obiettivo principale. Infine mirate a qualcosa di veramente significativo e non a un semplice “Range Rover” che è qualcosa di effimero, che non vi serve, ed è solo uno strumento per apparire e per farvi vedere, ma così farete vedere quello che non siete veramente, farete vedere la vostra maschera e non il vostro “io interiore”.
“Quando ero piccolo non sapevi chi ero
Perso nel sentiero perché in fondo anch’io non lo sapevo
Non mi sono permesso di essere fragile, vulnerabile
Di essere me”
Spesso quando siamo piccoli siamo immaturi e non ci rendiamo conto di chi eravamo. Io a 14 anni ero perso nel sentiero e ora che ci ripenso mi sentivo piccolo, non capivo molte cose. Però allo stesso tempo sono stato sempre me stesso, nonostante tutto, sia per le cose giuste che per quelle sbagliate.
“Non cercarti mai dentro gli occhi che
Che non sono i tuoi, non cercarti in me
Ci vedremo poi dentro ville che
Sognavamo che avremmo avuto da grandi
E so che ce le avremo (te lo giuro)
Quelle certezze che avrebbero reso la vita più facile
Meno piena di domande (perché?)Un giorno ce ne andremo (lontano)
E lasceremo dietro solo tante pagine
Di testi che fan piangere (no)
Ringrazio il cielo (il cielo)
Che fai parte della mia esistenza
Non so stare in tua assenza
Anche se in fondo è quello il senso
Dare tutto, tutto se stesso”
Questa è la parte finale della canzone ed è anche quella più triste, più malinconica, che fa piangere.
Parte dicendo che non bisogna mai cercarsi dentro gli occhi degli altri, perché sì, nella vita non si può stare soli ed è vero, abbiamo bisogno per forza di qualcuno al nostro fianco, che sia un amico o fidanzato… ma bisogna sempre avere le spalle larghe perché nella vita ho imparato che non si sa mai… e i miei genitori ne sono stati la prova… alla fine non esiste un per sempre e quindi non bisogna mai fare affidamento sugli altri al 100%, ma bisogna anche imparare ad essere forti da soli ove dovesse andare male e ci dovessimo ritrovare a rialzarci da soli senza nessuno. Infine credo che le ultime frasi non abbiano bisogno di spiegazione… la vita non è sempre facile e a tutti farebbe comodo avere quelle certezze soprattutto sul futuro che ci renderebbero tutto più facile, però la vita è una sfida e va vissuta e ci sono momenti sì e momenti no.
Per concludere volevo ringraziare il prof. Del Mondo per avermi dato durante questi 5 anni l’opportunità di aprirmi in questa maniera così profonda con la classe e con “gli altri” che leggono.
Porterò sempre con me questo bel ricordo della gemma che mi ha fatto in un certo senso riflettere molto su vari aspetti della vita e di me stesso e posso dire di essere cresciuto anche grazie ad essa”.
(G. classe quinta).