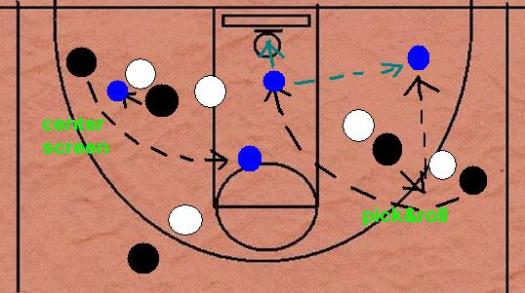In seconda e in terza stiamo iniziando a parlare dell’Ebraismo. Una delle cose che è emersa è la presenza di componenti non solo tradizionaliste. Per chi desidera approfondire la questione questo è un ricchissimo articolo della rivista Confronti che parla proprio di una nuova comunità nata a Roma da pochissimo tempo (questa la loro pagina facebook). L’articolo e le interviste sono di Daniela Mazzarella.

“L’umorismo ebraico ha fama mondiale e la comunità Beth Hillel sembra esserne ricca, con la sua sede in via dei Salumi e il suo rabbino che di cognome fa Di Gesù. Ma invece la nascita di questa nuova realtà rappresenta un evento molto serio e importante per l’ebraismo italiano. Beth Hillel è infatti la prima comunità «progressive» della capitale e il 1° marzo 2014 – 29 Adar 5774 si è presentata al pubblico con una giornata di preghiera, di approfondimento e di festa.
La sua storia ha origine qualche anno fa parallelamente a un crescente disagio di chi si ritrovava sempre meno nelle tesi di fondo della comunità ortodossa romana. Beth Hillel nasce infatti dall’incontro tra un gruppo di preghiera, costituito principalmente da ebrei non appartenenti alla comunità ortodossa che si incontravano nelle loro case, e un gruppo di ebrei iscritti alla comunità di Roma che sentivano però l’esigenza di offrire maggiori opportunità a coloro che non avevano una serena collocazione comunitaria.
Le riunioni dei due gruppi sono state sempre più strutturate e regolari, fino ad arrivare alla decisione di costituire la neonata comunità. Beth Hillel, che è legata alla World Union for Progressive Judaism, si presenta come un’associazione con il suo statuto e un Consiglio direttivo pro tempore che scadrà al momento delle elezioni formali dei suoi organi da parte dell’assemblea dei membri.
Ad oggi Beth Hillel offre servizi religiosi per le festività principali e, in forma solenne per almeno uno Shabbat al mese, ha la presenza di rav Antonio Di Gesù, che giunge da Gerusalemme per seguire la nuova comunità della capitale. Beth Hillel svolgerà anche attività culturali ed educative e vuole cercare di essere una comunità alternativa a quella ortodossa e non in conflitto con essa, nella speranza di creare una realtà ebraica più accogliente e inclusiva.
I membri di Beth Hillel sono convinti infatti che la presenza di una sola comunità con un fondamento ideologico unico possa allontanare chi non si sente coinvolto pienamente, non solo dalle pratiche religiose ma dalla Comunità stessa, e sono spinti dalla speranza che un approccio pluralistico all’ebraismo possa essere un elemento determinante per permettere a tutte le anime ebraiche di affermarsi con serenità.
Perché la comunità Beth Hillel non è fatta da ebrei diversi, ma esprime diversi modi di essere ebrei.
Conciliare tradizione e accoglienza
intervista a Daniela Gean, uno dei membri fondatori della comunità riformata di Roma, Beth Hillel.
Lei è nata in Libia e cresciuta in una famiglia ebrea ortodossa. Come ha vissuto la sua ortodossia?
Sì, sono nata in Libia e vengo da una famiglia ortodossa. Sono stata addirittura molto più religiosa dei miei stessi genitori, dall’età di quattordici anni fino ai venti. Poi ho vissuto per quasi tre anni in Israele e posso dire che proprio lì ho ridimensionato la mia ortodossia. Nel primo periodo sono rimasta sempre osservante, poi piano piano proprio gli amici israeliani mi hanno fatto venire dei dubbi. Penso che l’ebraismo – per la concatenazione di tante azioni che devi fare e per tutti i suoi comandamenti – ha un meccanismo per cui se parti da zero e cominci a essere religioso lo sarai sempre di più, ma nel momento in cui lasci succede la stessa cosa: lasci sempre di più. È un passaggio graduale ma ineluttabile. Per esempio durante Shabbat inizi a viaggiare, poi da lì a poco accendi anche il fuoco e cominci a fare tutta una serie di cose. È così che quando sono tornata in Italia avevo già abbandonato tantissime cose e dopo qualche anno ho lasciato anche la kasherut (regole alimentari della religione ebraica, stabilite dalla Torah, ndr).
Quindi la rigidità dei comandamenti è la principale origine del suo allontanamento dall’ortodossia?
No, questi per me sono più che altro dettagli. Il punto che non mi convinceva più dell’ortodossia era una specie di autismo emotivo, cioè quella cosa per cui anche delle persone dotte, preparate, che ti possono leggere e citare il Talmud alla perfezione, nel momento in cui gli chiedi quell’empatia, quella solidarietà, quella cosa spesso fondamentale nei momenti di sconforto o dolore, si rivelano incapaci di offrirtela. Non dico che non ci sia nessuno, ma sono pochissimi. Forse alla base di questo problema ci può essere anche la riservatezza, ma io penso che più spesso ci sia un’ansia di farsi vedere dotti e preparati che schiaccia la capacità di mostrare un sentimento, cosa che può essere vista proprio come una debolezza o un qualcosa che va a viziare il giudizio che invece deve essere sempre lucido. Ho vissuto dei momenti davvero brutti in cui ho visto persone in difficoltà davanti a rabbini incapaci di avvicinarsi al dolore. Ho visto questa incapacità e mi sono chiesta se sia inevitabile davvero, se ci sia davvero questa impossibilità di conciliare l’erudizione – che è e deve rimanere fondamentale per noi Popolo del Libro – con l’accoglienza.
Come ha conosciuto Beth Hillel e quali sono le ragioni che l’hanno spinta a farne parte?
Ho conosciuto la comunità Beth Hillel per caso. Io la cercavo ma non la conoscevo. Casualmente un’amica me ne ha parlato il giorno di Rosh hashanà e così il giorno dopo ci sono andata. Devo dire che è stato un amore immediato. Entrare e trovare la canzone giusta, cantata tutti insieme, e trovare finalmente gli uomini seduti vicino alle donne. E questa cosa delle donne per me è stata davvero determinante. Qualche mese prima avevo celebrato il Bar mitzvah con mio figlio Simone e l’abbiamo fatto ovviamente in una sinagoga ebraica ortodossa. Mio marito non è credente, quindi non ha accompagnato il figlio e io ho di fatto lasciato questo ragazzo da solo perché non potevo sedermi vicino a lui; mio figlio. Con un padre che per una questione ideologica non ha voluto partecipare attivamente e io che mi trovavo materialmente parlando dietro alle sbarre, questo ragazzo è rimasto da solo. Materialmente e spiritualmente solo. Teoricamente i rabbini avrebbero potuto avvicinarsi a lui, ma non è successo nemmeno quello. Quando vivi queste cose ti chiedi come sia possibile che accadano in una comunità religiosa. Questo ragazzo, questo bambino, ha vissuto un passaggio importantissimo senza nessuno con cui condividerlo; e io, se fossi stata in una sinagoga riformata, mi sarei potuta sedere vicino a lui, avrei potuto leggere insieme a lui, salire al Sefer insieme a lui. Ma questo non mi è stato possibile perché sono donna. Nella mia vita la «questione donna» è stata sempre centrale nel mio rapporto con l’ebraismo. Da sempre. Anche quando ero ortodossa avevo molte perplessità rispetto ad alcune nostre regole e al ruolo dato alla donna.
Per esempio?
C’era una benedizione che non facevo mai. So che gli ortodossi potranno dire che ero io a non capirne il senso profondo, ma a me è sembrata sempre molto chiara. Gli uomini dicono «Ti ringrazio Dio mio che non mi hai fatto donna» e le donne recitano «Ti ringrazio mio Dio che mi hai fatto così come sono». Proprio così, non che «non mi hai fatto uomo», che mi hai fatto «così come sono». Io quella benedizione non l’ho mai detta. Avevo quattordici, quindici, sedici anni, muovevo le labbra, ma non l’ho mai pronunciata. Sì, direi proprio che l’assoluta parità tra uomini e donne che esiste nelle comunità riformate è un elemento fondamentale nella mia adesione a Beth Hillel.
Tra le persone che frequentano regolarmente Beth Hillel ci sono iscritti alla comunità ortodossa di Roma?
Tutti quelli che sono nati ortodossi sono iscritti alla comunità ortodossa e non hanno intenzione di lasciarla. Noi speriamo di avere un rapporto di collaborazione, incontro e dialogo con la comunità ortodossa di Roma e siamo fiduciosi. Conoscendo rav Riccardo Di Segni, crediamo di poter trovare in lui disponibilità e desiderio di confronto.
In questo periodo avete avuto contatti con l’Unione delle comunità ebraiche? E, se sì, cosa chiedete all’Ucei?
Noi desideriamo avere anche con l’Ucei un rapporto costruttivo, tanto che nel nostro statuto abbiamo proprio scritto di aspirare a entrare nell’Unione. Siamo nati da poco e ancora i nostri rapporti verso l’esterno sono tutti da costruire. Di certo però non ci mancano energie e passione.
Riavvicinare gli ebrei all’ebraismo
intervista a Federico D’Agostino, tra i membri fondatori della comunità, uno dei protagonisti del gruppo di preghiera che ha preceduto la nascita di Beth Hillel.
Lei nasce in una famiglia non ebrea; come è arrivato alla scelta di avvicinarsi all’ebraismo?
Non si è trattato di una scelta, che presuppone confronti fra alternative: qui non c’era nulla da decidere, solo accettare un dato di fatto. Nel momento in cui ho messo per la prima volta piede in Israele, da semplice turista, ho percepito di essere a casa. Tutto mi sembrava familiare, comprese le cose fastidiose o irritanti. Tornato in Italia, mi sono iscritto a un corso di ebraico, e ho scoperto che lo imparavo molto in fretta. Le nuove cose che apprendevo mi parevano disseppellite dai recessi della memoria. Ne ho parlato con il mio compagno di vita e di viaggio: ce la sentiamo di rinunciare a salumi e crostacei? Abbiamo scritto a un rabbino, rav Cipriani. Ci ha detto «no». Per più di un anno sempre «no». Poi «nì». Alla fine ha acconsentito a prenderci come studenti.
Da quali aspetti di questa religione è stato particolarmente colpito e perché la scelta di una comunità «progressive»?
Un passaggio della Ghemarà (assieme alla Mishnà forma il Talmud, la raccolta di insegnamenti dei Maestri dell’ebraismo, ndr) mi ha sempre colpito: «lo studio della Torah vale tutti i precetti», e cioè lo studio è il primo dovere religioso di ogni ebreo. E vorrei aggiungere, di ogni ebrea. Non te lo aspetteresti da una religione così concentrata sulle azioni rituali, che come una ragnatela avvolgono l’intera giornata dell’ebreo osservante. Eppure senza lo studio creativo dei Testi sacri – e per estensione di tutto lo scibile – non faremmo nemmeno la metà del nostro dovere. Questa combinazione originale di obbedienza a un codice di comportamento minuziosamente dettagliato e forte incentivo al rischio dell’interpretazione creativa e personale, è per me il genio dell’ebraismo. Certo, sui modi di interpretare e sul margine di innovazione consentito ci dividiamo. Per l’ortodossia una famiglia composta da due uomini è difficile, se non impossibile, da digerire. Può essere accettata, persino discretamente integrata nella comunità, se sei nato ebreo, ma non si può pretendere che un tribunale ortodosso converta una famiglia omosessuale, come nel nostro caso. Per fortuna, non esiste solo l’ortodossia. Anzi, nel mondo gli ortodossi sono una minoranza.
Immagino che tra i soci fondatori di Beth Hillel ci siano profonde differenze; mi può dire invece qual è, secondo lei, l’elemento più aggregante?
Ci sono differenze – e profonde – fra religiosi e laici, fra liberali e tradizionalisti, fra destra e sinistra: come in ogni comunità, direi. Per non far impazzire la maionese occorre disponibilità al compromesso da parte di tutti, e la volontà di mettere fra parentesi le questioni più controverse, almeno fin quando non saremo più saldamente strutturati. Ci uniscono la stima reciproca e la convinzione di essere tutti in perfetta buonafede in questa impresa storica: costruire una casa ebraica per tutti quegli ebrei che per varie ragioni sono (o si sono) esclusi dalla comunità ortodossa. Credo che questa serenità e apertura si percepisca molto chiaramente nei nostri incontri e sia la cosa che più affascina la gente.
Che futuro vede per questa comunità e quali gli ostacoli maggiori da superare?
Di ostacoli ne vedo parecchi, per lo più di ordine politico, ma me ne interessa uno in particolare, che non è politico ma culturale, ed è comune a noi e agli ortodossi: l’estraniazione degli ebrei romani. Solo una piccola percentuale di loro frequenta la comunità e ancora meno la sinagoga: in altre parole, si stanno assimilando. Se Beth Hillel riuscirà a ricondurre una parte di loro in seno all’ebraismo – sia pure un ebraismo un po’ diverso – avremo avuto successo. Altrimenti, ci avremo provato.”
 Tra poche ore inizia un nuovo anno scolastico. A me… a voi… ai miei colleghi (grazie a Silvia che mi ha fatto scoprire questo capolavoro)… e a chi a scuola ci lavora con amore e dedizione…
Tra poche ore inizia un nuovo anno scolastico. A me… a voi… ai miei colleghi (grazie a Silvia che mi ha fatto scoprire questo capolavoro)… e a chi a scuola ci lavora con amore e dedizione…