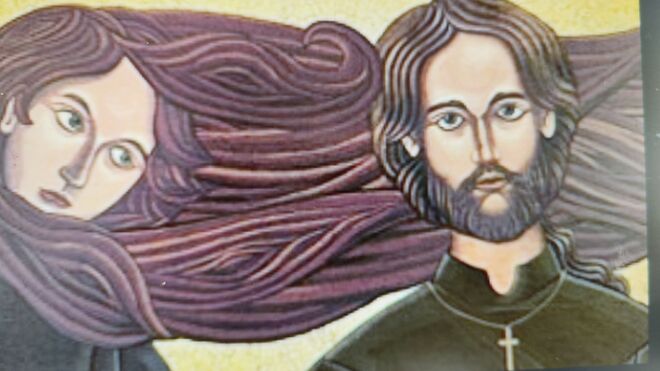Da un po’ di tempo sto cercando di leggere articoli e pubblicazioni sul modo di vivere la fede e di intendere la religione negli Stati Uniti d’America. A incidere su questa scelta vi sono vari fattori: l’elezione di un papa proveniente da quello stato, il fatto che spesso ciò che avviene oltreoceano arriva dalle nostre parti, la presenza sempre più frequente di linguaggio e simboli religiosi nella politica, il fenomeno della polarizzazione delle posizioni. Oggi pubblica un articolo piuttosto lungo, preso da Pandora Rivista. Esso indaga il ruolo del Cristianesimo come forza teologico-politica capace di frenare il caos nelle società occidentali contemporanee, riprendendo il concetto paolino di Katechon. Analizza l’influenza di figure come Donald Trump, J.D. Vance e soprattutto Peter Thiel, ideologo della Silicon Valley e teorico di un cristianesimo politico che unisce capitalismo, sovranismo e visione escatologica. Nei suoi scritti, Thiel propone una reinterpretazione del “senso comune” e del potere come freno all’entropia sociale (definibile in pochissime parole come tendenza di una società al disordine, alla disgregazione e alla perdita di coesione interna), ponendo il Cristianesimo come ultimo baluardo contro la dissoluzione dell’Occidente e le minacce percepite, in particolare l’Islam e il globalismo liberale. Disclaimer: come al solito, a meno che non lo dichiari, sul blog non riporto soltanto idee alle quali aderisco, ma sono interessato a ospitare punti di vista differenti, utili ad approfondire varie tematiche. Specificato questo, ecco il testo scritto da Benedetta Lazzeri ed Elia Scapini.
“Diciamocelo, non annoia mai il dibattito sui fondamenti primi delle società occidentali, con l’irrisolta questione se le moderne democrazie liberali possano veramente legittimarsi o se, in fin dei conti, poggino su presupposti che non sono in grado di darsi. Un tema stimolante, questo, soprattutto perché chiama in causa la questione della religiosità, in generale, e della religione cristiana in particolare, nel suo rapporto con le società contemporanee, sollevando la domanda se, in fondo, l’aver relegato le religioni allo spazio del privato sia stato veramente un buon affare o se non si sia scelto di liquidare, assieme al Cristianesimo, anche una realtà in grado di opporsi all’entropia intrinseca alle dinamiche umane e di potere, qualcosa che sappia resistere al caos e alla disgregazione. Nel gergo teologico politico, questa forza resistente ha un nome specifico: Katechon. Un termine complesso, che ci arriva dal Nuovo Testamento – 2 Tessalonicesi 2,6-7 – e che, dalla prima Modernità alla prima metà del Novecento, ha abitato le pagine più raffinate della trattatistica politica che, ora come allora, era mossa da una domanda fondamentale: su quali basi si costruiscano le nostre istituzioni e se ci sia, nelle loro fondamenta, una forza che faccia da deterrente, da freno. Una questione che diviene sempre più urgente man mano che le religioni, le ideologie e i simboli perdono la loro forza spirituale e morale sulla comunità.
Ma più del dubbio se abbiamo fatto e stiamo facendo bene, se le nostre scelte di democrazia e liberalismo ci beneficeranno sul lungo periodo o se invece non siamo parte di un macro trend che nel suo complesso è in declino, più di ogni rimpianto e rimorso, siamo incuriositi dalle proposte, dalle nuove teorie e letture, da tutte quelle voci che propongono convintamente di indicare strade nuove, che lo siano realmente o apparentemente.
A colorare il dibattito con un senso di fallimento e sconfitta ci hanno pensato, fra gli altri, Donald Trump e J. D. Vance e che la loro proposta intersechi i motivi del Cristianesimo non fa certo dubbio: abbiamo sentito parlare di elezione divina e abbiamo visto ministri di governo riuniti in preghiera. Non solo, J. D. Vance, convertito al Cristianesimo dalla lettura di Agostino, ha addirittura proposto l’applicazione geopolitica del principio dell’ordo amoris di Tommaso d’Aquino, mostrandone l’interno accordo con lo slogan America First: ci sono cose che vengono prima e cose che vengono dopo, e le cose che vengono prima esigono una dedizione maggiore, con buona pace di tutto il resto. In questo senso, per quanto possano sembrare bizzarri, i riferimenti e le citazioni teologiche che arrivano dalla Casa Bianca andrebbero prese molto sul serio, e non per un’improbabile consapevolezza nascosta dietro di esse, quanto perché queste parole sono la prova della cogenza di una teoria che Carl Schmitt sostenne quasi un secolo fa: tutte le società contemporanee e occidentali si basano su concetti teologici secolarizzati.
Che il Cristianesimo abbia un ruolo fondamentale nel dibattito politico mondiale non è cosa nuova; se si riavvolge il nastro della storia, anche solo di due o tre anni, si vedranno apparire, in fila, momenti fondamentali della contemporaneità più recente in cui il Cristianesimo e i suoi principali simboli si sono fatti carico di messaggi e gesti dalla portata politica non trascurabile, come, per esempio, l’incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Donald Trump fuori dalla Basilica di San Pietro, in Vaticano. Il problema, tuttavia, andrebbe posto in modo più preciso e scientifico, domandandosi innanzitutto, che ruolo abbia il Cristianesimo nell’orientamento delle politiche degli Stati sovrani, su tutti, in quella degli Stati Uniti di Donald Trump. Una domanda che apre la strada ad altre questioni cruciali, ad esempio, quella su quanto siano ancora pregnanti i simboli religiosi (seppur secolarizzati) all’interno delle società occidentali; su quale rapporto intercorra tra il Cristianesimo professato dai trumpiani e il dio-denaro – l’unica vera guida delle politiche della Casa Bianca e della Silicon Valley – e, ancora, se il il Cristianesimo possa essere la forza in grado di tenere a freno il caos che sta sconvolgendo gli ordini mondiali.
C’è un’altra figura fondamentale, seppur infinitamente meno nota dei Trump e dei Vance, che potrebbe aiutarci a rispondere a queste domande; un uomo che tira le fila del dibattito geopolitico mondiale e che ha influenzato (e continua a influenzare) profondamente l’establishment nordamericano. Classe 1967, patrimonio personale di 8 miliardi di dollari, Peter Thiel nasce a Francoforte da famiglia tedesca poi naturalizzata statunitense. Appassionato sin da piccolo di fantascienza, studia filosofia nella prestigiosa sede di Stanford, dove segue i corsi di René Girard e acquisisce una specializzazione in legge. Prima di approdare in California e di diventare uno dei capostipiti della Silicon Valley, Thiel lavora come avvocato e trader. Nel 1999 fonda PayPal che, un anno più tardi, si fonde con X.com di Elon Musk prima di essere venduta a eBay (nel 2002) per 1,5 miliardi di dollari. È solo nel 2003 che l’ambizioso capostipite della PayPal Mafia fonda Palantir Technologies – il nome della società, che deriva dalle “pietre veggenti” della saga fantasy Il Signore degli Anelli di Tolkien, ci dice qualcosa sull’eccentrica personalità di Thiel –, compagnia di software specializzata nell’analisi e nella gestione dei dati complessi, utilizzata, tra le altre, da agenzie governative quali CIA e FBI. Dichiaratamente gay, balbuziente, colto e infinitamente meno scenografico dell’allievo Musk, è stato proprio Thiel a sdoganare, nel 2016, l’appoggio della Silicon Valley e delle Big Tech a Donald Trump; una vicinanza che, soprattutto nelle ultime elezioni, si è dimostrata essenziale alla leadership del Tycoon. Minimalista, austero e con una cultura più alta della media dei suoi sodali e colleghi, Peter Thiel è un ideologo efficace, forse non di altissimo livello, talvolta tranchant nel tagliare lo spazio politico mondiale in categorie riduttive (seppur schmittiane) come il bipolarismo amico-nemico, ma sicuramente capace di orientare il sentimento politico e geopolitico della Silicon Valley e dello Studio Ovale.
Ma ideologo di cosa? Qual è il pensiero, lo schema, che si nasconde dietro la retorica ultrareazionaria e nazionalista di Trump e Vance? Quale ragionamento può giustificare la totale sottomissione dello spazio politico al potere economico che sembra tenere in piedi l’asse che lega la Casa Bianca e la Silicon Valley e, soprattutto, come entra il Cristianesimo in questa equazione? Sono questioni complicate, come complicato è lo scenario che le genera; tuttavia, nella confusione generale del momento, Peter Thiel sembra poter fornire delle prime risposte. A differenza di coloro cui si accompagna, Thiel ha più volte tentato di dare ragione delle proprie idee e i suoi primi scritti politicamente orientati risalgono agli anni dell’università a Stanford. Un particolare, questo, non da poco, considerando che la forma scritta ci fornisce non solo una via d’accesso diretta e interna all’ideologia del magnate, ma ci dà anche la possibilità di interpretare e commentare da fuori un pensiero che, dal 2017 a oggi, sembra essersi rafforzato nel suo peso politico specifico.
Già nel lontano 2003 il breve saggio (circa 25 pagine) Il momento straussiano raccoglieva gran parte di quella che, negli anni a venire, sarebbe diventata la sua visione politica. Nel libro, le riflessioni del magnate della Silicon Valley vengono liricamente introdotte da un estratto in versi di Locksley Hall di Alfred Tennyson; parole, quelle del poeta inglese, che con il senno di poi risuonano più potenti e rivelatrici che mai. Il passo racconta una visione del futuro dai tratti escatologici: in questa preveggenza profetica, l’uomo può spingere il proprio sguardo fino al limite del possibile e lì vede la meraviglia del progresso. Un avanzamento tecnico del mondo che, continua Tennyson, porta con sé guerra e distruzione, almeno fino all’istituzione – che va di pari passo con il crollo di ogni potere politico specifico – di un Parlamento dell’umanità, di una Federazione del mondo, guidata solo da una saggezza condivisa che tiene a bada persino i popoli più irrequieti e i regni più instabili. In altre parole, Thiel non santifica il progresso sfrenato e senza limiti, bensì sembra inserirlo in una sorta di movimento triadico hegeliano, durante il quale, a due fasi diametralmente opposte e inconciliabili, se ne aggiunge una di ricomprensione delle due nella conciliazione del common sense. Questo senso comune tanto idealizzato è, pare ovvio, il Katechon paolino, è una forza frenante che ha una direzione e un fine, è, insomma, un concetto teologico secolarizzato.
Rispetto alla visione poetica di Tennyson, non è difficile individuare la fase in cui si trovano a vivere gli Stati contemporanei. Il mondo è in fiamme, la globalizzazione del commercio senza barriere è in crisi e, con essa, la pace e l’unità che si diceva fossero seguite alla separazione della Guerra Fredda. Ciò che manca – questo sembra dirci Thiel – è appunto il common sense cui Tennyson fa riferimento nei suoi versi, lo stesso che appare ciclicamente nelle dichiarazioni che provengono dalla Casa Bianca. E poco importa se il modo in cui il poeta inglese intende l’espressione poco (o niente) ha a che fare con il “buon senso” trumpianamente inteso; è proprio questa l’accezione cui pensa la giovanissima speaker della Casa Bianca Karoline Leavitt quando per comunicare le risoluzioni operate dal governo le descrive come ovvie e scontate proprio perché conformi con il senso comune della maggioranza degli elettori.
Se per Tennyson, infatti, il senso comune è sinonimo di un “sentire collettivo”, della ragionevole concordia condivisa da un gruppo di persone che ha il sapore di un’élite razionale mossa dalla fiducia nell’ordine globale della giustizia, con Trump – e forse anche con Thiel – ci troviamo di fronte a un senso comune che non richiede nessuno sforzo di ragione ma che dà per buona l’opinione immediata e urgente dei più, senza trascurare (anzi) le comuni (appunto!) frustrazioni e delusioni. La ripresa che Peter Thiel fa di questa espressione ci mette davanti a uno dei punti essenziali del dibattito contemporaneo: il senso comune ci porta tutti a evitare aghi e vaccini, il senso comune darà ragione a chi suggerisce esservi un legame vincolante fra somaticità biologico-genitale e rappresentazione genderizzata dell’orientamento sessuale, il senso comune non vede ragione nello sforzo economico e bellico in guerre oltreoceano e, cosa più importante, il common sense diviene incomprensibilmente verità assoluta. È stato questo, in fondo, il principale richiamo di Vance all’Europa, quando, armato di gesso e bacchetta, ha ricordato ai nostri politici come fare il loro mestiere: obbedire al senso comune, a quello che la pancia del popolo chiede a gran voce, anche qualora il buon senso sembri spingere in una direzione diversa.
In altre parole, esiste una teologia anche in politica, un discorso attorno a quelli che devono essere i principi primi e ultimi delle società, ed esistono agenti politici in grado di orientare la scena del mondo senza lasciarsi influenzare da quelle che, alla luce di questi ragionamenti, non sono che visioni parziali, frammentarie del reale. Sono stati proprio i Thiel e i Musk a orientare la scelta della Vicepresidenza su J. D. Vance – decisione che ha scontentato l’ala più moderata dei magnati vicini a Trump – ed è stato Thiel a fornire una parte dei presupposti teorici della campagna trumpiana contro le istanze inclusive e la cultura woke. Risale addirittura a trent’anni fa un libro poco noto del proprietario di Palantir – meno famoso del già citato The Straussian Moment e molto meno noto del vendutissimo Da zero a uno – dal titolo più che eloquente: The Diversity Myth. Scritto quando Thiel si trovava ancora tra i banchi della Stanford University, il libro attacca duramente le prime voci woke, accusandole di avallare un atteggiamento “semplicemente anti-occidentale” senza alcun proposito se non quello di distruggere l’Occidente e tutte le sue forme.
In effetti, l’idea che la società occidentale esista anche in virtù delle sue espressioni sociali, culturali e politiche non è di per sé errata, né può essere sovrapposta alle istanze nazionaliste e suprematiste che formano il sostrato ideologico che ha dato forma, tra le altre cose, al governo Trump. L’ultranazionalismo intransigente che muove la California delle tech affonda le sue radici in idee molto più raffinate e colte; per comprenderle – e per tentare di capire il valore religioso a queste associato – può essere utile tornare alle pagine iniziali de Il momento straussiano. Un’idea sulla piega che prendono le pagine del saggio l’ha già data l’introduzione, con l’immagine di un’umanità impelagata in un regno di mezzo fatto di guerra e distruzione.
L’intero testo è permeato da un senso di minaccia da parte di un oscuro nemico che presto si capisce essere – neanche a farlo apposta – l’Islam; un Islam genericamente inteso, senza nessuna distinzione territoriale o politica, ma che porta con sé l’oscura minaccia della distruzione religiosa e culturale del mondo occidentale e democratico. Ogni politica di integrazione e adattamento al nuovo ordine dell’Occidente, dopo l’11 settembre, è andata sgretolandosi. Le democrazie liberali hanno visto aumentare le ondate di violenza e odio, il tutto mentre i partiti di sinistra e i movimenti inclusivi strizzavano l’occhio a pensieri e religioni alternative. A ciò si è aggiunta la depauperazione degli Stati occidentali, con enormi flussi di denaro che, invece di favorire (come da programma) le economie dei Paesi in via di sviluppo, andavano a stanziarsi nei ricchi conti svizzeri di ignoti dittatori del terzo mondo. È probabilmente questa puntuale decostruzione delle basi su cui poggia il mondo contemporaneo a portare Thiel a riflettere – ancora prima che sulla distruzione dell’identità religiosa e nazionale – su quale sia la natura più profonda dell’essere umano. Così, in modo apparentemente gratuito, lo scritto schmittiano di Thiel si trasforma in quella che solo a un occhio inesperto potrebbe sembrare una speculazione filosofica e che è, in realtà, il tentativo di basare l’agire politico dei decision maker cristiani occidentali su premesse razionali. Che cosa ha a che fare il turbocapitalismo condito di un richiamo alla trascendenza delle forme politiche con l’esistenza umana in genere?
Secondo Peter Thiel, molto. La natura umana ha alla base una violenza cieca e incontrollabile – la stessa che era al centro dei testi del maestro putativo di Thiel, Girard –, una brutalità che può essere mitigata solamente dalla ragione. L’Islam è il portatore contemporaneo di questa bruta violenza senza intelletto, di un odio irrisolvibile e impermeabile a quella cultura del dialogo e della coscienza introdotta, in Occidente, dall’Illuminismo.
Mettere la violenza alla base della natura umana, al di là dei risvolti islamofobi che la teoria acquisisce in queste pagine, non apporta alcuna novità al dibattito politico contemporaneo, come non è nuova la disillusione verso l’ottimistica visione illuminista secondo cui tutti gli agenti politici, assieme, sarebbero in grado di sedersi a un tavolo e stipulare un patto sociale sulla base del quale avviare una convivenza pacifica e duratura. Quello che stupisce – non per originalità, quanto per l’eccessiva semplificazione – è l’individuazione del nemico non tanto nel rivale (economicamente o politicamente inteso), quanto nel diverso; insomma, il nemico come l’islamico di bianco bendato di monicelliana memoria: “l’antico periglio che vien dallo mare”!
È una strana commistione tra il Leviatano e il binomio schmittiano amico-nemico il mostro a due teste che sembra orientare le idee di Thiel, secondo il quale la scelta della sovranità dovrebbe ricadere solamente su colui che si dimostri in grado di individuare il nemico e sia deciso a combatterlo fino ad annientarlo, nel rispetto e nella salvaguardia del mondo occidentale e delle sue forme. Quella cui siamo davanti nelle pagine de Il momento straussiano è la rischiosa sintesi tra un neoliberismo estremo e un autoritarismo dai caratteri escatologici, quasi che la decisione del più forte sia resa tale da una volontà Altra che arriverà a dimostrarne la futura necessità. Thiel ha quello che a Musk manca e quello che al Tycoon (che lo sappia o no) serve: una visione teologica del reale. Dove “teologico” indica una precisa visione occidentale e cristianocentrica secondo la quale un intelletto più alto e potente debba indirizzare la realtà verso le sue forme proprie, tenendo a freno le istanze particolari. Forse è proprio quella del freno, del Katechon, l’idea che sta alla base di Palantir, l’azienda fondata dal miliardario che ufficialmente si occupa di raccolta e protezione di dati ma della quale, nello specifico, non si sa quasi nulla. Rimandando, ancora una volta, all’idea di un ente di controllo superiore e ineffabile.
Un’inchiesta di Wired, che ha anche coinvolto ex dipendenti come fonti, ha spiegato che la piattaforma non venderebbe solo software ma anche «l’idea di soluzioni senza attriti a problemi complessi», non solo, dopo aver collaborato con l’ICE (Immigration and Customs Enforcement), con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e con le forze armate israeliane, questa primavera Palantir ha firmato un accordo con la NATO che gli permetterà – attraverso un sistema di intelligenza artificiale acquistato dall’Alleanza – di avere accesso a tutti i dati raccolti e annotati dei Paesi membri. Alla base sia di Palantir che delle riflessioni del saggio, c’è uno schema preciso che prevede, evidentemente – e lo stesso Thiel non lo ha nascosto – un’idea di fortificazione dell’Occidente e, con esso, delle sue forme politiche e religiose. D’altra parte, e questo Thiel lo dice chiaramente ne Il momento straussiano, la prerogativa principale dello statista occidentale e cristiano è proprio quella di sapere introdurre nella comunità un potere che frena. C’è un problema, tuttavia, che lo stesso magnate riconosce: l’apertura incontrollata dei mercati e degli scambi (anche culturali) porta necessariamente allo scontro, l’umanità non si fonda su alcun principio positivo di unione o concordanza e l’incontro ha sempre in sé il germe della contrapposizione. Il Cristianesimo – quello della Casa Bianca, che si leva al grido di Dio, Patria e Famiglia – è l’unico freno possibile alla deflagrazione, l’unico baluardo del vecchio mondo in dissolvenza in grado di fare la guida in tempi di distruzione e caos. Thiel sembra aver risposto a ciascuna delle domande che ci eravamo posti in partenza, tranne una: che ne facciamo, quindi, del neoliberismo sfrenato che lo ha creato?”