Ieri siamo andati con i bimbi a vedere uno dei tanti villaggi della zucca che stanno fiorendo in questo periodo. C’era anche un piccolo labirinto fatto con dei pallet messi in verticale. Mariasole vi si è infilata immediatamente seguita da Fra: ovviamente mi sono accodato per procedere alle spalle del piccolo che ben presto ha perso le orme della veloce sorella. Ma non ha perso la speranza: ha iniziato a sbirciare tra le assi dei pallet e a chiamare “Tata” ad alta voce, senza fermarsi, continuando a procedere, come se un invisibile filo lo legasse a Mariasole. E in poco tempo è uscito dal labirinto anche lui. Mi è tornato in mente tutto questo leggendo un articolo di suor Maria Gloria Riva su Avvenire.
“Non tutti ricordano che l’unico Giubileo del XIX secolo fu quello del 1825, celebrato – esattamente 200 anni fa – da un Papa di nome Leone, però XII. I giubilei successivi, indetti da Pio IX nel 1850 e nel 1875, non ebbero luogo a causa dei disordini politici che accompagnarono l’unità d’Italia, ma anche per il serpeggiare di guerre e depressioni economiche in tutta Europa. Non è difficile comprendere come la parola speranza in tali contesti culturali fosse ritenuta vacua e prima di fondamento. Il filosofo Nietzsche riteneva la speranza non una virtù, ma un sentimento negativo che spinge ad impegnare le proprie energie entro inutili sforzi. I pittori, in quel periodo, presero a dipingere la speranza separata dalle altre due virtù, fede e carità, attingendo volentieri all’immagine biblica suggerita dal Salmo 137 (1-3): Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia, i nostri oppressori: «Cantateci i canti di Sion!».
L’umanità, prigioniera delle Babilonie di ogni tempo, è incapace di salmodiare i canti della speranza. Così il clima culturale di quegli anni non fu tanto diverso dal nostro, dove guerre e depressione economica, miraggi espansionistici e giochi di potere, minano la fiducia assottigliando sempre più il filo della speranza.
A questo filo si aggrappò l’artista inglese George Frederic Watts quando nel 1886 dipinse la sua Hope. Il soggetto, cui l’artista dedicò varie versioni, conobbe una grande popolarità e, nella sua forza simbolica, parla ancora a noi oggi. L’espressione filo della speranza è collegata al mito di Arianna che consegnò all’amato Teseo, avventuratosi nel labirinto per uccidere il Minotauro, un gomitolo, il cui filo lo avrebbe ricondotto all’uscita. In realtà anche il termine biblico speranza, in ebraico Hatiqvà, contiene l’immagine di una corda (qav) tesa fra due poli. Ed è proprio entro questi due universi culturali, l’ambiente biblico e quello greco, cui Watts attinge per dipingere la speranza. La donna, nella posa della notte michelangiolesca, è bendata. La cetra con la quale cantare i canti di speranza è rimasta con una sola corda. Tutto appare perduto, oscuro difficile. Acque e nubi minacciose minano il globo terrestre e ogni pronostico positivo appare futile. La corda tesa però, l’ultimo filo della speranza, ben si accorda con una piccola stella che brilla in alto, appena visibile, attestando agli scoraggiati di ogni tempo e latitudine, che sorge sempre, oltre le nostre cecità, la stella della speranza.
A questo filo si aggrappa anche un artista contemporaneo, Viviani Vanni, che in una litografia dedicata al mito di Arianna, lega la corda tesa non ai canti di Sion, ma ad una mela. Il filo attraversa un’altra mela che, significativamente, rappresenta il grande labirinto del mondo internettiano. La mela, lo sappiamo, ci riporta a quella nostalgia delle origini, a quella sapienza capace di penetrare la realtà regalata ai due progenitori e irrimediabilmente persa dopo il peccato. Così per Vanni questa sapienza si riannoda grazie al mondo del Web, tuttavia la grossolana fattura della corda e il verismo della mela ci ricordano che anche nell’era dell’intelligenza artificiale è sempre necessario l’uomo, l’uomo con i suoi interrogativi ancestrali e con il suo percorso umano. Insomma, contrariamente alle filosofie nietzschane, la speranza è l’insopprimibile nostalgia dell’uomo che, senza dimenticare l’immanenza della storia, tende all’infinito. Cosa dice dunque a noi un Giubileo, come quello del primo quarto del XXI secolo, dedicato alla speranza? Cosa può fare l’uomo, sempre più piccolo in un mondo globalizzato, ad affrontare sfide che appaiono ben più grandi di Babilonia e dell’antico Minotauro?
La Chiesa, i Papi ci vengono incontro con la loro risposta semplice e super partes. Dal 2000 ad oggi la bambina da nulla della speranza, come la definisce Peguy, possiede un tesoro dentro un fazzoletto. Se Peguy si riferiva alla Veronica del Calvario, che ben prima delle tecniche fotografiche fissa nel tempo il volto del Cristo Eterno, il suo fazzoletto ci porta anche a realtà più quotidiane.
Seicento anni fa, nel 1425, Tommaso di Ser Giovanni di Mòne, detto Masaccio, dipinse nella Cappella Brancacci una stupenda, quanto drammatica, fuga dei progenitori dall’Eden. Qui viene immortalata la porta chiusa del Paradiso e non certo a caso: fu proprio nel 1425 che papa Martino V aprì, per la prima volta, la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano. Così Masaccio pone i progenitori, scacciati dal paradiso, tra una porta chiusa e una scena di speranza. La scena è nota come il tributo e ritrae il Salvatore al centro della scena mentre, davanti all’esattore delle tasse, indica a Pietro il vicino mar di Tiberiade. Pietro, su comando di Gesù, apre la bocca a un pesce e vi trova la moneta da consegnare al Tribuno. Così, anche il fazzoletto da nulla di Pietro custodisce una grande speranza. Il pesce che reca a Pietro l’importo delle tasse è simbolo di Cristo che ha già pagato per la liberazione dell’uomo. «Chi è sottoposto a tassazione: i figli o gli schiavi?» chiese Gesù. Poiché i figli ne sono esenti ecco – dice Cristo – io ho già pagato per tutti. Questo è il senso del Giubileo e la grande speranza anche per l’uomo contemporaneo. C’è uno che ci considera figli e ha già pagato il prezzo del nostro riscatto. Non c’è disperazione per chi entra nella Chiesa dove la porta del Paradiso è stata riaperta, la tassa della colpa pagata e le braccia della misericordia allargate per l’eternità.
In tal senso è efficacissimo il confronto, nell’arte di Giotto, fra speranza e disperazione. Nell’impianto iconografico della Cappella degli Scrovegni, Giotto pone la personificazione della Speranza, di fronte a quella della Disperazione. La Speranza, ritratta in uno slancio leggero ed elegante, possiede ali candide e, per quanto i piedi poggino a terra, è colta in volo. Il volto, rivolto in alto, è orientato verso un punto che va oltre il visibile. Le mani protese, infatti stanno ricevendo da Dio una corona di gloria. Non così invece la Disperazione. Il peso del suo pessimismo e dei pensieri cupi sembra trascinarla sempre più in basso. Mentre i suoi piedi poggiano a terra, il suo collo è stretto nella morsa di una corda degli impiccati. Un demonio le ha rubato il cuore e le mani sono chiuse a pugni stretti. L’orizzonte di chi dispera è quello della mediocrità e del proprio io. In un tale orizzonte ogni visione profetica è impensabile. Al contrario, l’orizzonte dello speranzoso è sempre fuori di sé, tiene conto di un più in là e le sue mani aperte sono pronte non solo a dare, ma anche a ricevere la novità di una salvezza che può venire solo dall’alto. L’arte, in pieno accordo con i Giubilei di ogni tempo, ci racconta così la speranza: uno sprone ad andare oltre sé stessi, un invito a confidare: c’è sempre un filo che resta teso nella vita e una stella che brilla oltre le nostre oscurità quotidiane.”




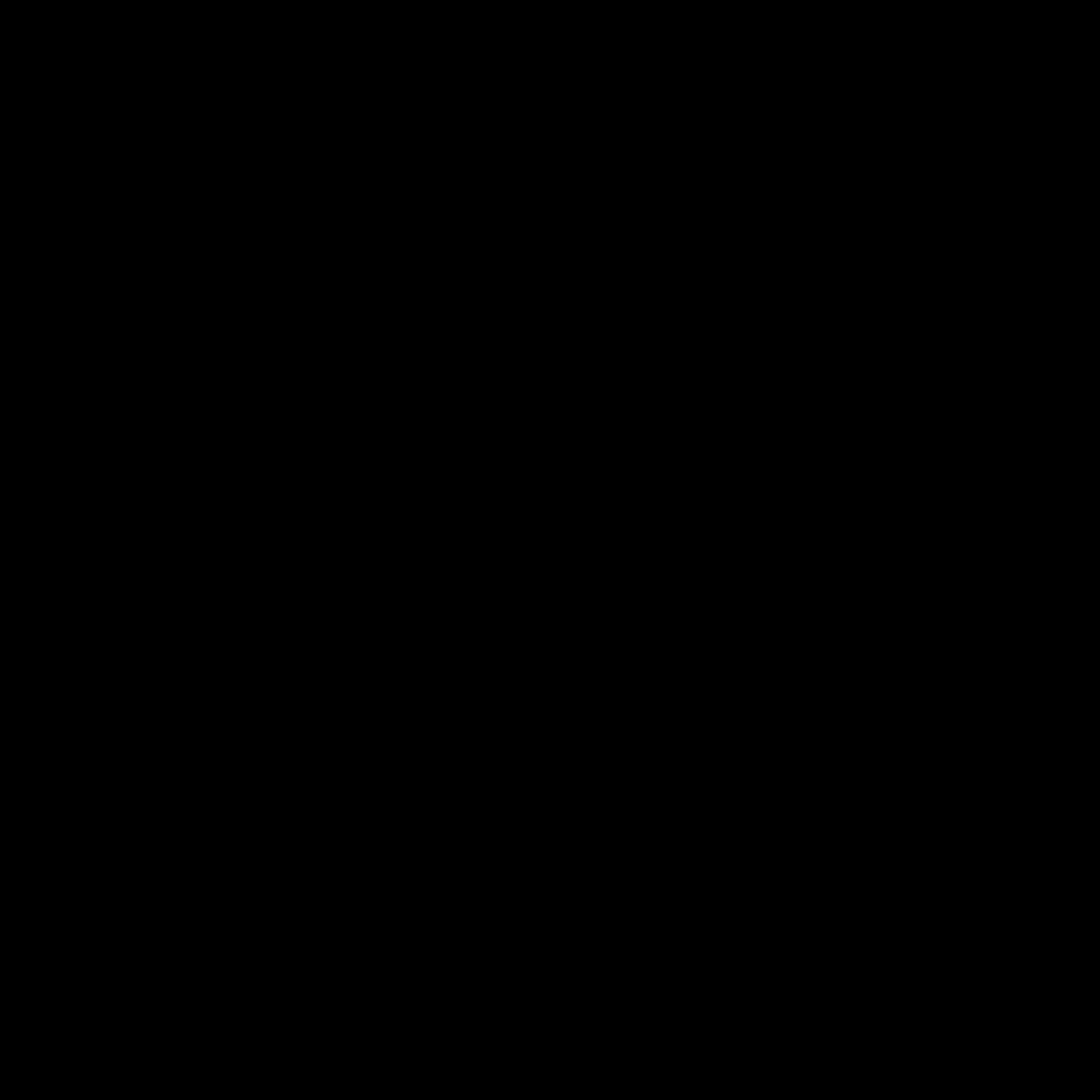


 arrivati a parlare di Thirteen reasons why: titolo di un fortunato libro negli Usa (Tredici in Italia), nonché di una ancora più fortunata serie televisiva che spopola tra i ragazzi e che, sollecitato da loro e interessato a capire dove cercano le parole e le immagini per raccontarsi, ho guardato nelle ultime settimane.
arrivati a parlare di Thirteen reasons why: titolo di un fortunato libro negli Usa (Tredici in Italia), nonché di una ancora più fortunata serie televisiva che spopola tra i ragazzi e che, sollecitato da loro e interessato a capire dove cercano le parole e le immagini per raccontarsi, ho guardato nelle ultime settimane.
