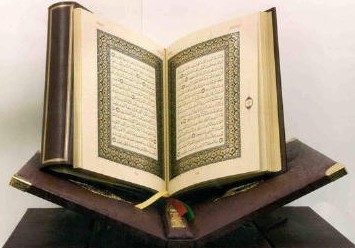 Pubblico un articolo interessante e curioso di Samim Akgönül preso da Osservatorio Iraq. L’articolo è originariamente apparso su OrientXXI.
Pubblico un articolo interessante e curioso di Samim Akgönül preso da Osservatorio Iraq. L’articolo è originariamente apparso su OrientXXI.
«Si può essere marxista e musulmano? Sì, affermano i membri del movimento Anti-Kapitalist Müslümanlar (musulmani anticapitalisti) che vedono nell’islam uno dei pilastri del loro impegno. Nel suo nome, si oppongono al Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) al potere.
La questione è antica nel cristianesimo: Cristo e gli apostoli possedevano beni di loro proprietà? Nel suo romanzo Il nome della rosa, Umberto Eco mette in scena dei monaci che discutono per decidere se Gesù era proprietario della tunica che portava al momento della sua crocifissione. Questa domanda può sembrare assurda, ma esprime il divario tra due visioni d’organizzazione della società: quella di individui che interagiscono più o meno liberamente, e quella di una comunità in cui l’individuo può esistere solo come parte di un gruppo. Tutte le religioni e tutte le ideologie, del resto, sono fondate sull’idea di comunità. Nella Lettera ai Galati 3:28, Paolo di Tarso afferma: “Non c’è più né ebreo né greco, non c’è più né schiavo né libero, non c’è più né uomo né donna; poiché tutti voi siete uno in Gesù Cristo”.
Gli risponde la sura 7 Al-Araf, versetto 158: “O uomini! Io sono per voi tutti il messaggero di Allah, al quale appartiene la sovranità dei cieli e della terra”.
Il carattere collettivo dei beni era stato poco considerato nell’islam popolare turco. Quest’ultimo è stato relegato in secondo piano dalla fondazione della Repubblica nel 1923, od oppresso poiché considerato simbolo di arretratezza. È stato sostituito da un islam normativo centralizzato e soprattutto nazionalizzato, trasformato in strumento di costruzione nazionale sotto il controllo rigoroso dello Stato. Ma da quando l’islam politico è al potere, e soprattutto dopo l’emergere di una generazione di musulmani intellettuali urbani, l’islam politico ha perso il suo carattere monolitico e si è dotato di diverse tendenze opposte. Uno degli esempi più sorprendenti di questa molteplicità è l’emergere di un gruppo di giovani musulmani che si oppongono duramente al partito al potere, il Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP), principale rappresentante dell’islam politico in Turchia. Questi musulmani anticapitalisti  rimproverano al potere islamista di essere più capitalista… che islamico. L’Anti-Kapitalist Müslümanlar è organizzato attorno alla figura di İhsan Eliaçık, un intellettuale iconoclasta che ha dedicato la sua vita alla necessaria “rinascita islamica”. Diventato scrittore ed editore dopo l’abbandono dei suoi studi di teologia, ha redatto una ventina di libri sull’idea di un islam sociale e solidale. E la sua casa editrice Inșa Kültürevi (“casa culturale di costruzione”), installata in uno dei quartieri più “islamisti” di Istanbul, Fatih, è diventata la piattaforma intellettuale “dell’islam rivoluzionario”, titolo di uno dei lavori di Eliaçık. I musulmani anticapitalisti sono spesso giovani provenienti dalle fasce popolari, politicizzati all’università, vicini alle idee marxiste ma che continuano a definirsi musulmani. La conciliazione tra un’appartenenza marxista ed un’appartenenza musulmana convinta avviene attraverso una serie di principi islamici interpretati come fondamenta di una posizione solidale, sociale, socialista e soprattutto anticapitalista.
rimproverano al potere islamista di essere più capitalista… che islamico. L’Anti-Kapitalist Müslümanlar è organizzato attorno alla figura di İhsan Eliaçık, un intellettuale iconoclasta che ha dedicato la sua vita alla necessaria “rinascita islamica”. Diventato scrittore ed editore dopo l’abbandono dei suoi studi di teologia, ha redatto una ventina di libri sull’idea di un islam sociale e solidale. E la sua casa editrice Inșa Kültürevi (“casa culturale di costruzione”), installata in uno dei quartieri più “islamisti” di Istanbul, Fatih, è diventata la piattaforma intellettuale “dell’islam rivoluzionario”, titolo di uno dei lavori di Eliaçık. I musulmani anticapitalisti sono spesso giovani provenienti dalle fasce popolari, politicizzati all’università, vicini alle idee marxiste ma che continuano a definirsi musulmani. La conciliazione tra un’appartenenza marxista ed un’appartenenza musulmana convinta avviene attraverso una serie di principi islamici interpretati come fondamenta di una posizione solidale, sociale, socialista e soprattutto anticapitalista.
Come fonti, due pilastri: il Corano ed Il Capitale. Ad esempio, il versetto 39 della sura An-Najm, (“la stella”) recita: “e in verità, l’uomo non ottiene che (il frutto) dei suoi sforzi” viene interpretato come un versetto favorevole ai proletari.
O anche, il versetto 7 della sura 59 Al-Hasr (“l’esodo”) – “(i beni) degli abitanti delle città, che Allah ha concesso senza combattere al Suo Messaggero, appartengono ad Allah, al Messaggero, ai parenti stretti, agli orfani, ai bisognosi e al viaggiatore in emergenza, affinché ciò non circoli solo tra i ricchi” – è, secondo i musulmani anticapitalisti, la prova della necessità della condivisione.
Questo gruppo non si oppone soltanto al capitalismo del AKP. E’ d’accordo su molti punti con gli altri movimenti politici della sinistra socialista e/o liberale. La sua presenza nel movimento di Gezi del giugno 2013 era evidente, soprattutto durante le preghiere del venerdì nel centro della “comune di Gezi” o quando hanno organizzato “le rotture del digiuno” (Yeryüzü iftarı), in strada, decisamente in contrasto con il fasto degli iftar dei politici e dell’alta borghesia. I musulmani anticapitalisti sono anche multiculturalisti, al contrario dei nazionalisti turchi. Difendono una Turchia diversa, basandosi sulla sura 30 Ar-Rum (“i Romani”), versetto 22: “E tra i suoi segni è la creazione dei cieli e della terra e la varietà delle vostre lingue e dei vostri colori”.
Contemporaneamente, optano per una soluzione pacifica della questione curda, dilemma principale della società turca dalla fondazione della Repubblica.
Infine, una particolarità considerevole dei musulmani anticapitalisti, rispetto ad altri movimenti generati dal panorama islamista, è il loro approccio umanistico alle questioni di genere e di sessualità. Forniscono un certo sostegno – timido ed indiretto – ai diritti delle donne e della comunità LGBT (lesbiche gay bisex transessuali). Ad esempio nel 2013, in occasione del processo degli assassini di un giovane omosessuale a Diyarbakir da parte di suo padre e dei suoi due zii avvenuto nel febbraio 2012, i musulmani anticapitalisti hanno dichiarato pubblicamente il loro sostegno alla condanna, poiché secondo il Corano “assassinare una persona è assassinare tutta l’umanità” e “il sistema capitalista crea oppressori che escludono ogni differenza, comprese le tendenze sessuali”.
Così, benché questo gruppo resti ancora marginale per numero dei militanti, il suo atteggiamento è pragmatico e destinato ad intensificare la sua presa. Si tratta di una discussione allo stesso tempo interna al mondo musulmano ma anche globale, parte di una critica sociale che supera di gran lunga la disputa religiosa.»
Lontano?
 Un racconto sull’amicizia preso dalla tradizione islamica e contenuto nel libro “La saggezza del mistico cammello” di Franco Ometto.
Un racconto sull’amicizia preso dalla tradizione islamica e contenuto nel libro “La saggezza del mistico cammello” di Franco Ometto.
«Un dervisc racconta che camminando nel deserto, vide un uomo con una veste rappezzata, un bastone in mano e una ciotola.
Gli chiese. “Da dove vieni?”.
Quello rispose: “Dall’Andalusia”.
“Dove vai?”.
“In Cina”.
“A quale scopo?”.
“A visitare un amico”.
“Ma è lontano!”.
“Sì, è lontano per un debole, sfinito, ma per un amante è molto vicino!”.»
Perché?
Pubblico un breve racconto (la lunghezza è un’apparenza, le battute sono molto brevi) dello scrittore egiziano Nagib Mahfuz, nobel per la letteratura nel 1988. Un dialogo tra padre e figlia dal titolo “Il paradiso dei bambini”. La conoscenza e l’amore su ogni cosa.
“- papà…
– dimmi.
– io e Nadia stiamo sempre insieme.
– certo, tesoro: è la tua amica…
– in classe, in cortile, anche alla ricreazione.
– bene! Nadia è una bambina bella e bene educata.
– nell’ora di religione però io vado in un’aula e lei in un’altra.
Lanciai un’occhiata alla mamma e la vidi sorridere mentre era intenta a cucire. Sorrisi anch’io dicendo:
– ma è solo nell’ora di religione…
– e perché?
– perché tu hai una religione e Nadia un’altra.
– come?
– tu sei musulmana e Nadia è cristiana.
– perché, papà?
– sei ancora piccola. Un giorno capirai.
– no. Io sono grande!
– ma no che sei piccola, tesoro!
– e perché sono musulmana?
Dovevo essere disponibile e accorto e soprattutto non tradire i nuovi sistemi educativi alla prima difficoltà.
– il tuo papà è musulmano e la tua mamma è musulmana, per questo anche tu sei musulmana.
– e Nadia?
– i suoi genitori sono cristiani, perciò è cristiana pure lei.
– forse è perché il suo papà porta gli occhiali…?
– non c’entrano gli occhiali. E’ che anche suo nonno era cristiano… dissi, deciso a risalire le generazioni senza smetterla finché non si fosse stancata e avesse finito per cambiare argomento. Ma ella riprese:
– chi è meglio?
Riflettei un poco, poi risposi:
– la musulmana è buona e anche la cristiana è buona.
– una dev’essere migliore per forza.
– son buone tutt’e due.
– e se mi faccio cristiana per stare sempre con Nadia…?
– non si può, amore. Ognuno deve restare come il suo papà e la sua mamma.
– e perché?
Ecco qua la tirannia dei nuovi metodi educativi!
– non vuoi proprio aspettare quando sarai grande?
– no, papà.
– bene. Lo sai cos’è la moda? A uno piace una moda, all’altro un’altra. Essere musulmani è l’ultima moda, per questo devi rimanere musulmana.
– allora quella di Nadia è una moda vecchia!
Benedette tu e la tua Nadia! Nonostante la mia prudenza mi ero sbagliato e avevo finito col mettermi in un bel pasticcio.
– e´ una questione di gusti… però ognuno deve restare come i suoi genitori.
– dirò a Nadia che la sua è una moda vecchia e che la mia è nuova.
– tutte le religioni sono buone – mi affrettai a dire – chi è musulmano adora Dio e chi è cristiano anche.
– ma perché lei lo adora in un posto e io in un altro?
– perché da una parte lo si fa in un modo e dall’altra in un altro modo.
– e perché?
– lo saprai l’anno prossimo, o quello dopo. Per ora basta che tu sappia che sia i musulmani sia i cristiani adorano Dio.
– e chi è Dio, papà?
Restai sorpreso. Riflettevo, mentre prendevo tempo.
– cosa ti ha detto la maestra?
– ci ha letto una sura del Corano e ci ha insegnato le preghiere. Però chi è Dio non lo so.
Ci pensai su ancora, nascondendo un sorriso.
– è il creatore di tutte le cose.
– di tutte?
– di tutte.
– e che vuol dire creatore?
– vuol dire che è lui che ha fatto ogni cosa.
– e come ha fatto?
– con la sua grande potenza…
– e dove vive?
– ovunque nel mondo.
– e prima del mondo?
– lassù.
– in cielo?
– sì.
– lo voglio vedere.
– non si può.
– nemmeno in tv?
– nemmeno.
– nessuno lo può vedere?
– nessuno.
– e tu come lo sai che è lassù?
– lo so.
– chi te l’ha detto?
– i profeti.
– i profeti?
– sì, come Muhammad.
– e lui come ha fatto a saperlo?
– aveva una forza speciale.
– una forza speciale negli occhi?
– sì.
– e perché?
– è Dio che lo ha creato così.
– perché?
Mi dominai e risposi:
– egli è libero di fare ciò che vuole.
– e quando lo ha visto com’era?
– grande, forte, potente…
– come te, allora.
Trattenni una risata:
– nessuno gli è simile.
– e perché vive lassù?
– la terra non basta a contenerlo, ma egli vede ogni cosa.
Si distrasse per poco, poi riprese:
– ma Nadia dice che ha vissuto sulla terra.
– è perché vede ogni luogo, così è come se vivesse dappertutto.
– Nadia ha detto che lo hanno ucciso.
– no, amore mio, hanno creduto di averlo ucciso, ma egli è vivo e non muore mai.
– e il nonno, è vivo anche lui?
– no, il nonno non c’è più.
– lo hanno ucciso?
– no. E’ morto da solo.
– e come è morto?
– si è ammalato ed è morto.
– allora la mia sorellina che è malata morirà anche lei?
Mi adombrai e prevenni la reazione della mamma affrettandomi a dire:
– ma no, guarirà!
– e allora il nonno perché è morto?
– il nonno si è ammalato da grande.
– anche tu ti sei ammalato da grande. Perché non sei morto?
Questa volta la mamma la rimproverò ed ella restò smarrita a guardare ora l’uno ora l’altra.
– moriamo quando lo vuole Iddio.
– e perché Dio vuole che moriamo?
– egli è libero di fare ciò che vuole.
– la morte è bella?
– oh no, tesoro.
– e perché dio vuole una cosa brutta?
– e´ bella quando è lui a volerla.
– ma tu hai detto che è brutta.
– mi sono sbagliato, amore.
– perché la mamma si è arrabbiata quando ho detto che tu muori?
– perché ancora Dio non lo ha voluto.
– e perché lo vuole, papà?
– è lui che ci fa nascere e fa che ce ne andiamo.
– e perché?
– vuole che facciamo delle cose belle prima di andarcene.
– e perché non restiamo?
– non ci sarebbe spazio per la gente se tutti restassero.
– così lasciamo tutte le cose belle.
– andiamo dove ci sono cose migliori.
– dove?
– lassù.
– da Dio?
– sì.
– e lo vedremo?
– sì.
– e sarà bello?
– certo.
– allora dobbiamo andare.
– ma non abbiamo ancora fatto tante belle cose…
– il nonno le ha fatte?
– sì.
– che cosa ha fatto?
– ha costruito una casa e ha coltivato un giardino.
– e cosa aveva fatto Totò, il mio cuginetto?
Mi rattristai per un istante, poi volsi uno sguardo commosso alla mamma e risposi:
– anche lui ha costruito una piccola casa prima di andarsene.
– il figlio dei vicini invece mi picchia e non fa niente di bello.
– è proprio un ragazzaccio.
– allora non morirà.
– solo quando Dio lo vorrà.
– anche se non farà nessuna bella cosa?
– tutti si muore. Chi fa cose buone va dal Signore e chi le fa cattive va all’inferno.
Lei sospirò e tacque.
Avvertii quanto la cosa fosse stata impegnativa, ma non sapevo dire se avessi risposto bene o male. La fila dei perché aveva risvegliato domande celate dentro me. La piccola non lasciò passare molto tempo prima di sbottare:
– voglio stare sempre con Nadia.
Guardai verso di lei con aria interrogativa.
– anche nell’ora di religione!
Scoppiai a ridere. Anche la mamma rideva. Soggiunsi sbadigliando:
– non me lo immaginavo che si potesse parlare di cose simili a questo modo.
Intervenne la mamma con aria consolatrice:
– la bimba crescerà e un giorno potrai spiegarle tutte le cose che sai a riguardo.
Mi girai allora alterato verso di lei per capire fino a che punto avesse parlato sul serio o se piuttosto mi prendesse in giro. Ma già aveva ripreso il suo lavoro di cucito.”
(da “Il bambino nell’Islam”, in Aa.Vv. Il bambino nelle religioni, Editrice Ancora, Milano 1992)
Tra fede, finanza e moschee
 Dal sito di Nigrizia prendo questo forte e discusso articolo di Mostafa El Ayoubi pubblicato sul numero di gennaio.
Dal sito di Nigrizia prendo questo forte e discusso articolo di Mostafa El Ayoubi pubblicato sul numero di gennaio.
“Finanza e fede. È il binomio sul quale si basa gran parte della politica estera del Qatar, specie quella che riguarda l’Europa. Sul versante finanziario dispone di ingenti investimenti in diversi settori: bancario, immobiliare, del calcio ecc. In Europa il mondo politico e quello economico-finanziario lo considerano un grande partner da corteggiare. Quanto alla variabile fede, il Qatar ha un’alleanza strutturale con i Fratelli musulmani (Fm) molto ramificati in Europa. Il piccolo emirato, che sogna un pan-islamismo sotto il suo controllo, considera i Fm uno strumento per estendere il suo potere sulla sfera religiosa. Persa di recente la sua influenza sul mondo arabo a favore del gigante saudita, il Qatar sta concentrando la sua crociata finanziaria e religiosa altrove. In Africa i “missionari” del Qatar sono al lavoro: dal Niger al Senegal, attraverso la rete di moschee, sono in sensibile espansione attraverso ingenti “donazioni” che fanno gola ad organizzazioni islamiche e governanti locali. Ma è verso il vecchio continente che la strategia espansionistica del Qatar sembra più orientata. Lo scopo è di estendere la sua egemonia sull’islam in Europa. Attraverso il finanziamento per la costruzione delle moschee, il Qatar sta spiazzando i tradizionali paesi dai quali proviene l’immigrazione islamica in Europa: Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Pakistan, Turchia ecc. E investe logicamente nei luoghi di culto sotto controllo dei Fm. In Francia svariati milioni di euro sono stati investiti nella realizzazione di nuove moschee, attraverso la Qatar Charity. Questa ong “caritativa” ha contribuito economicamente alla costruzione di diverse moschee: quelle di Nantes e Mulhouse, e quella di Marsiglia (ancora da realizzare). In Irlanda, il Consiglio municipale ha autorizzato la costruzione di una moschea – finanziata in parte dal Qatar – nella periferia di Dublino, città dove risiede l’European Council for fatwa and Research di cui al-Qaradawi (ideologo dei Fm) è il massimo esponente. Gli sceicchi del Qatar corteggiano i musulmani anche in Germania: a Monaco è prevista, con il loro contributo, la realizzazione di una moschea su 6000 mq con tanto di minareto, biblioteca, palestra, ristoranti, sala congressi e altro. In Italia, dal dicembre 2012 all’ottobre 2013, sono state inaugurate tre grandi moschee con ingenti contributi della Qatar Charity: la prima a Catania, la seconda a Ravenna e l’ultima a Colle di Val d’Elsa (Siena).
In passato non sono mancate aspre polemiche sulle moschee in Europa, sul ruolo dei finanziamenti stranieri e sul controllo finanziario e ideologico che i donatori esercitano sui musulmani. Oggi invece su questi finanziamenti si mantiene un profilo basso: i politici non ne fanno più un oggetto di propaganda e i media ne parlano poco, perché il Qatar è un paese amico con il quale si fanno molti affari. Il problema però è che l’ingerenza del Qatar (e altre petro-monarchie) negli affari della “diaspora” islamica in Europa nuoce alla sua integrazione e all’evoluzione di un islam europeo. Con il suo denaro il Qatar, oltre a comprare la coscienza di tanti musulmani in Europa, dispone anche del consenso di realtà politiche e culturali che si considerano attente alle questioni della libertà religiosa e dei diritti umani. Eppure si sa bene che attraverso le sue “donazioni” il Qatar – con l’ausilio dei Fm – diffonde la sua visione arcaica e approssimativa della religione islamica, che considera il dialogo interreligioso come uno strumento di proselitismo e di conversione. Nel “filantropo” Qatar, milioni di immigrati sono trattati come degli schiavi. Ad oggi sono morti decine di immigrati utilizzati nella costruzione degli impianti per i mondiali del 2022. E il razzismo nei confronti dei lavoratori immigrati dovrebbe far riflettere molto i musulmani in Europa – in gran parte di origine immigrata – sull’insidiosa carità dei principi qatarioti. È meglio una sala di preghiera piccola e dignitosa di una sontuosa moschea costruita con il contributo di uomini (ricchi) che ancora oggi schiavizzano i loro simili!”
Per lui è tutto
Ho intenzione di proporre sul blog alcuni scritti provenienti dalle diverse tradizioni religiose. Alcuni saranno tratti dai libri che ho a casa, altri da siti che di volta in volta segnalerò. Inizio con un delicato racconto della tradizione islamica sufi, preso qui.
L’acqua del paradiso
Nel corso della loro vita da nomadi, Harith il Beduino e sua moglie Nafìsa erano soliti piantare la loro logora tenda dove potevano trovare qualche palma da dattero, qualche ramoscello rinsecchito per il loro cammello, o uno stagno di acqua salmastra.
Erano anni che facevano questa vita e ogni giorno Harith compiva gli stessi gesti: con la trappola prendeva i topi del deserto per via della loro pelle, e con le fibre di palma intrecciava corde che vendeva alle carovane di passaggio.
 Un giorno, tuttavia, una nuova sorgente sgorgò dalle sabbie del deserto. Harith si portò l’acqua alle labbra e gli sembrò l’acqua del paradiso. Quell’acqua, che noi avremmo trovato terribilmente salata, era infatti molto meno torbida di quella che era abituato a bere. “Devo assolutamente farla assaggiare a qualcuno che sappia apprezzarla”, si disse Harith.
Un giorno, tuttavia, una nuova sorgente sgorgò dalle sabbie del deserto. Harith si portò l’acqua alle labbra e gli sembrò l’acqua del paradiso. Quell’acqua, che noi avremmo trovato terribilmente salata, era infatti molto meno torbida di quella che era abituato a bere. “Devo assolutamente farla assaggiare a qualcuno che sappia apprezzarla”, si disse Harith.
Si incamminò quindi sulla strada per la città di Bagdad e per il palazzo di Harun El-Rashid, fermandosi solo per sgranocchiare qualche dattero. Portava con sé due otri pieni d’acqua: uno per sé e l’altro per il califfo.
Alcuni giorni dopo raggiunse Bagdad e andò direttamente a palazzo. Le guardie ascoltarono la sua storia e, non potendo fare altrimenti – era questa l’usanza – lo ammisero all’udienza pubblica tenuta dal califfo.
“Comandante dei credenti”, disse Harith, “sono un povero beduino e conosco tutte le acque del deserto, benché sappia ben poco di altre cose. Ho appena scoperto quest’Acqua del Paradiso e ho subito pensato di portarvela perché, in verità, è un regalo degno di voi”.
Harun il Sincero assaggiò l’acqua e, dato che capiva i suoi sudditi, ordinò alle guardie di far accomodare il beduino e di trattenerlo finché non avrebbe fatto conoscere la sua decisione. Poi chiamò il capitano delle guardie e gli disse: “Ciò che per noi è niente, per lui è tutto. Al calar della notte conducetelo fuori dal palazzo. Non lasciate che veda il possente Tigri; scortatelo fino alla sua tenda senza permettergli mai di bere acqua dolce. Poi dategli mille monete d’oro con i miei ringraziamenti per i suoi servigi. Ditegli che lo nomino guardiano dell’Acqua del Paradiso e che dovrà offrirne da bere a mio nome a tutti i viaggiatori”.
Questo racconto s’intitola anche: “La storia dei due mondi”. Risale ad Abu El-Atahiyya, della tribù degli Aniu, contemporaneo di Harun El-Rashid e fondatore dei dervisci Maskhara, ‘Gaudenti’, in Occidente sono conosciuti col nome di ‘Mascara’ e hanno adepti in Spagna, Francia e in altri paesi. El-Atahiyya è stato chiamato “il padre della poesia araba sacra”. Morì néll’828.
Tra arte e uomo
Un consiglio: leggete le brevi parole in corsivo che posto subito qui sotto. Se vi interessa sapere di cosa si tratta andate oltre, altrimenti possono bastare quelle. Sono le parole di una lettera ricevuta dal giornalista Marco Aime da parte di Asco Ousmane, un suo amico del Mali. L’articolo appare su Nigrizia di dicembre, a cui sono abbonato da anni; non l’ho trovato in rete per cui nel caso violassi leggi di copyright è sufficiente segnalarmelo e rimuoverò immediatamente il post.
Caro amico,
volevo dirti che il mio silenzio non è un oblio, ma è perché tutti i cavi delle comunicazioni sono stati danneggiati dai ribelli. Sono tre mesi che la rete telefonica non funziona. Nessuno qui è ormai sicuro, la popolazione vive nel panico totale. La psicosi è diventata la regina madre della città, ma sono riuscito a mandare mia moglie e i miei figli a Bamako. Io sono rimasto a Timbuctù per cercare di salvare il lavoro.
La città si è svuotata, due terzi della popolazione è fuggita e l’esercito ci ha abbandonato alla nostra triste sorte. Non c’è stata resistenza: i militari hanno abbandonato caserme, armi e divise per vestirsi come i civili e nascondersi nelle case della gente. Le tre regioni del nord in 72 ore sono cadute in mano a gruppi di islamisti, l’Mnla è diventato il padrone della città. Quelli dell’Mnla si sono installati all’aeroporto, Ansar Dine nella caserma. Questi vogliono instaurare la shari‘a. Il velo alle donne è diventato obbligatorio, anche per le bambine, i bar sono stati saccheggiati, le banche svuotate, tutti i servizi bloccati.
È la crisi totale, Marco. Con la presenza di questi islamisti non ci saranno più scuole, tranne quella coranica. Un uomo non può più acquistare nulla da una donna e viceversa, non si può più giocare a carte o suonare, né fumare per la strada. Una donna non può camminare con un uomo per strada, se non è suo marito. È la disperazione.
 La Patisserie Asco, piccolo ristorante all’aperto all’ingresso di Timbuctù, era un punto di riferimento per molti abitanti della città. Soprattutto per una certa intellighenzia. Seduti ai tavolini, all’ombra delle acacie, incontravi insegnanti, magistrati, amministratori, che spesso discutevano di politica e di molte altre cose, con Asco che partecipava attivamente a ogni discussione. Distrutto. Il locale è stato distrutto come tutti gli altri. Quando ricevetti questa mail, mi vennero le lacrime agli occhi nel pensare al dolore di tanta gente, di molti amici che a Timbuctù come a Kidal, a Gao e in molti altri villaggi stavano provando a causa della guerra.
La Patisserie Asco, piccolo ristorante all’aperto all’ingresso di Timbuctù, era un punto di riferimento per molti abitanti della città. Soprattutto per una certa intellighenzia. Seduti ai tavolini, all’ombra delle acacie, incontravi insegnanti, magistrati, amministratori, che spesso discutevano di politica e di molte altre cose, con Asco che partecipava attivamente a ogni discussione. Distrutto. Il locale è stato distrutto come tutti gli altri. Quando ricevetti questa mail, mi vennero le lacrime agli occhi nel pensare al dolore di tanta gente, di molti amici che a Timbuctù come a Kidal, a Gao e in molti altri villaggi stavano provando a causa della guerra.
I racconti che sono arrivati da altri conoscenti, parlavano di mani amputate pubblicamente sulla piazza del mercato, donne stuprate davanti ai figli e ai mariti, uomini fucilati pubblicamente. In una mail successiva, Asco mi raccontava di avere mandato nella capitale moglie e figli anche perché ha una bambina di dodici anni e i jihadisti pretendevano di scegliere come spose le ragazzine che ritenevano più carine.
Timbuctù il cui suolo, secondo il cronista tunisino del XVII secolo es Sadi, non era mai stato toccato dagli idoli pagani, aveva saputo mantenere per secoli una tradizione di tolleranza e di apertura. Islamica fin dalla sua fondazione, nel XII secolo, Timbuctù è stata popolata da una borghesia commerciale, aperta al mondo, curiosa, che ha saputo fondere i caratteri del mondo arabo con quelli della tradizione africana ed è contro i segni di questa tradizione di tolleranza, che si è scagliata la furia iconoclasta dei jihadisti, che hanno distrutto tre storici mausolei: quelli di Sidi Mahmoud, di Sidi Moctar e di Alpha Moya. Sanda Ould Boumama, portavoce del gruppo, dopo aver annunciato altre distruzioni, ha dichiarato che costruire tombe è contrario all’Islam e pertanto proibito. Questi episodi hanno immediatamente acceso l’attenzione dei media, che avevano fino a quel momento appena accennato alle violenze perpetuate sulla popolazione. Nel gennaio del 2013 le truppe francesi entrano a Timbuctù, mettendo in fuga i jihadisti che la occupavano dall’ottobre dell’anno precedente. Immediatamente ha fatto il giro del mondo la notizia che costoro avevano dato alle fiamme migliaia di antichi manoscritti conservati nel Centro Ahmed Baba. Testimonianze scritte della secolare tradizione culturale di Timbuctù. Per fortuna (se di fortuna si può parlare in questo frangente) i responsabili delle biblioteche hanno messo in salvo la maggior parte dei manoscritti, prevedendo l’accanimento degli islamisti.
Ciò che accomuna questi tragici fatti (era accaduto lo stesso per i Buddha di Bamayan) è la loro capacità di smuovere l’opinione pubblica, molto di più di quanto riescano a fare azioni simili perpetuate sugli individui. Le statue, i manoscritti, i monumenti. Questi manufatti, di indubbio pregio e valore storico, sembrano colpirci più della sorte delle persone. Perché ci commuoviamo in maniera più intensa davanti a un monumento danneggiato che di fronte alle tragedie umane? Che il delirio iconoclasta degli “studenti islamici” fosse un segno di barbarie è fuor di dubbio, ma non è certo stata l’espressione peggiore del loro fanatismo. Ci siamo però accorti della loro furia solo quando hanno violato il sacro tempio dell’arte, quasi che sentissimo più vicina a noi questa realtà piuttosto che quella umana. Percepiamo l’arte come un universale, come un qualcosa che ci appartiene. Perché? La cultura occidentale contemporanea, grazie anche alle politiche dell’Unesco, ci ha portati a pensare all’arte e alla natura come universali, come parte di un patrimonio appartenente a tutti: il patrimonio dell’umanità. Non riusciamo invece ad abbandonare l’idea che gli esseri umani siano in qualche modo marchiati da una nazionalità, da una cittadinanza, da un legame con un territorio che, se non è il nostro, li rende automaticamente stranieri. Nascita e nazione sembrano diventati un binomio indissolubile, sul quale costruire le nostre identità. Quando c’è un incidente o una guerra si sente parlare dei “nostri” morti, quelli degli altri contano meno. Natura e arte ci emozionano e ci uniscono, perché, percepite come universali, diventano anche extra territoriali. L’umanità ci rende diversi e talvolta nemici. Attraverso l’arte abbiamo materializzato la storia, rendendola visibile e pertanto utile a conservare la memoria. Accade poi che con il tempo questi oggetti di venerazione siano via via svuotati e ridotti a simulacri di un valore universale e assoluto. Abbiamo divinizzato l’arte al punto di ritenerla al di sopra delle parti, sovrumana.
Potremmo riflettere su questi temi, magari rileggendo ancora una volta questi versi del grande poeta israeliano Yehuda Amichai:
«Un giorno sedevo sui gradini dell’entrata della Torre di Davide.
Avevo appoggiato le mie due borse della spesa di fianco a me.
Un gruppo di turisti circondava la sua guida e io divenni il loro punto di riferimento.
“Vedete quell’uomo con le borse della spesa? Proprio a destra della sua testa c’è un arco di epoca romana. Appena a destra della sua testa”. “Ma si sposta! Si sposta!” . Io mi dicevo: la redenzione verrà solo quando la loro guida dirà loro: “Vedete quell’arco di epoca romana? Non è importante: ma lì vicino in basso, un po’ a sinistra, c’è un uomo seduto, che ha comprato frutta e verdura per la sua famiglia”».
Quale stagione?
Pubblico un articolo molto interessante di Luca Geronico. Rivolgendo uno sguardo al recente passato della cosiddetta primavera araba, e in particolare all’Egitto, il giornalista prova a gettare una fugace occhiata all’immediato futuro.
“«L’islam è la soluzione». «Al-islam huwa al-hall». Come un mantra per i Fratelli Musulmani d’Egitto che dal 1928, anno della loro fondazione a Ismailiyya, è stato ripetuto quasi compulsivamente dal Nilo a Sinai: mormorato negli anni della repressione sotto Nasser, sussurrato in quelli di ambiguo fiancheggiamento a Sadat come nell’ultimo trentennio sotto Mubarak, l’ultimo faraone. Parola d’ordine, e per questo semplificazione brutale, della lunga dissidenza della rinascita islamica contro i regimi autocratici di tutto il Medio Oriente. Tuttavia la folla oceanica di piazza Tahrir (Libertà), icona di una rivolta popolare repentina quanto imprevista, resta ancora tutta da decifrare. Chi erano quelle centinaia di migliaia che l’11 febbraio del 2011 festeggiarono fra canti e balli la caduta di Mubarak? Chi erano, invece, quelle centinaia di migliaia che alla fine di giugno del 2013 ottennero, spalleggiati dall’esercito, la deposizione di Mohamed Morsi, il primo presidente della fratellanza? Sedici mesi che hanno sconvolto l’Egitto e fatto carta straccia delle più recenti “dottrine del mondo arabo”.
La prima piazza Tahrir, quella contro Mubarak, venne frettolosamente salutata come l’imprevista vittoria di una società post-islamica al grido di slogan secolari, «pane, libertà, giustizia», agitati dai social network. Quella piazza sancì la crisi del modello che «aveva consentito ai regimi in carica» alleati e sorretti dall’Occidente, «di sopravvivere oltre la fine della guerra fredda e degli anni dell’emergenza della lotta al terrorismo  transnazionale», afferma Giovanni Sale in Islam contro islam (Jaca Book, pp. 166, euro 14). Rivolta prettamente politica dunque, e non solo “del pane”, nata da un moto laico e spontaneo. Nel giro di pochi mesi, tuttavia, l’islam politico, inizialmente defilato ma ben radicato nel profondo Egitto, ritornò prepotentemente sulla scena: i Fratelli Musulmani vinsero le prime elezioni libere, come in Tunisia il partito islamico di al-Nahda guidò il dopo Ben Alì. Ma nel giro di pochi mesi, cogliendo ancora di sorpresa le opinioni pubbliche occidentali, l’Egitto che aveva scacciato l’ultimo faraone, liquidava pure Mohamed Morsi: 22 milioni di firme e una piazza Tahrir nuovamente straripante determinarono il 3 luglio di quest’anno un rocambolesco avvicendamento al vertice dello Stato, con l’esercito, di nuovo, nel ruolo di garante. Per alcuni un intervento di salvaguardia contro il tentativo di instaurare uno stato basato sulla sharia; un vero colpo di Stato consumato nel silenzio di Usa e Ue, per altri. Di certo un guado pericolosissimo, che l’Egitto, con il resto del mondo arabo, non ha ancora attraversato.
transnazionale», afferma Giovanni Sale in Islam contro islam (Jaca Book, pp. 166, euro 14). Rivolta prettamente politica dunque, e non solo “del pane”, nata da un moto laico e spontaneo. Nel giro di pochi mesi, tuttavia, l’islam politico, inizialmente defilato ma ben radicato nel profondo Egitto, ritornò prepotentemente sulla scena: i Fratelli Musulmani vinsero le prime elezioni libere, come in Tunisia il partito islamico di al-Nahda guidò il dopo Ben Alì. Ma nel giro di pochi mesi, cogliendo ancora di sorpresa le opinioni pubbliche occidentali, l’Egitto che aveva scacciato l’ultimo faraone, liquidava pure Mohamed Morsi: 22 milioni di firme e una piazza Tahrir nuovamente straripante determinarono il 3 luglio di quest’anno un rocambolesco avvicendamento al vertice dello Stato, con l’esercito, di nuovo, nel ruolo di garante. Per alcuni un intervento di salvaguardia contro il tentativo di instaurare uno stato basato sulla sharia; un vero colpo di Stato consumato nel silenzio di Usa e Ue, per altri. Di certo un guado pericolosissimo, che l’Egitto, con il resto del mondo arabo, non ha ancora attraversato.
Ma è corretto decretare, con il fallimento di Morsi anche quello dell’islam politico? Più in generale: una religione dal valore anche politico come l’islam può rapportarsi alla democrazia nata in Occidente? Nell’agile miscellanea L’autunno delle primavere arabe a cura di Roberto Tottoli (La scuola, pp. 90, euro 8,50) Massimo Campanini, molto esperto della fratellanza, ribadisce che nel pensiero politico islamico contemporaneo esistono «tentativi di elaborazione dottrinale che potrebbero individuare un comune terreno con la democrazia». Il dibattito sui concetti di shura (consultazione) e di dawla madaniyya (stato civile) potrebbe giungere alla legittimazione dal basso del potere sovrano. Concetti, osserva Campanini, ancora «incerti e imprecisi» mentre i Fratelli Musulmani nel biennio 2012-’13 si sono trasformati da movimento a partito politico. La sfida e l’opportunità è di giungere a un partito islamico moderno superando l’automatismo dogmatico per cui «La soluzione è l’islam» e accettando il dibattito con le forze liberali e laiche. Se questo è il tormento dell’Egitto, stato simbolo del mondo arabo, nell’Africa subsahariana (in Mali e Nigeria in particolare) il vuoto di potere e le ripercussioni della guerra di Libia hanno dato nuova linfa a uno jihadismo fondamentalista di recente costituzione in quelle terre tribali e desertiche. Un’emergenza che rimanda all’altro buco nero mediorientale: la tragedia della Siria già destabilizzante per Iraq e Libano. Una situazione che sta trasformando la tradizionale condizione di dhimmitudine (sottomissione) della minoranza cristiana in Medio Oriente in impossibilità di sopravvivenza. Nuovi equilibri e sistemi politici da sperimentare, ma che saranno tanto più nefasti se alla fine – dopo tanta “brezza di primavera” e tanto dolore innocente di popoli – si constaterà il fallimento di qualsiasi esperimento democratico. Per questo Giovanni Sale addita come fondamentali per l’evoluzione di tutta la sponda sud del Mediterraneo le elezioni politiche del marzo 2014 annunciate pochi giorni fa dal governo ad interim del Cairo. Lo spettro, ammonisce Sale, è una nuova guerra civile come in Algeria nel 1991-92: in tal caso un nuovo inverno arabo avrà soppiantato il dilemma se il presente sia una primavera non sbocciata o un lungo autunno che non finisce mai.”
Il drappo nero
Si è da poco concluso il periodo clou del pellegrinaggio a La Mecca (Hajj), tra il 13 e il 18 ottobre. Scrivo per far conoscere uno degli aspetti forse meno conosciuti: ogni  anno la kiswa, il drappo nero che ricopre la Kaaba, viene calato e sostituito con uno nuovo (di notevole valore e peso: si tratta di quattro teli di circa 13 m per 13 m, di seta nera, con scritte e versetti coranici decorati in oro, dal peso complessivo di circa 670 kg). I pellegrini sperano di essere tra quei fortunati che riceveranno una striscetta del vecchio drappo che nell’occasione viene sminuzzato. Nel video qui sotto la sostituzione di quest’anno. Aggiungo anche che da quest’anno è stato installato un nuovo percorso sopraelevato per permettere anche ai fedeli con disabilità, di percorrere i canonici 7 giri intorno alla Kaaba.
anno la kiswa, il drappo nero che ricopre la Kaaba, viene calato e sostituito con uno nuovo (di notevole valore e peso: si tratta di quattro teli di circa 13 m per 13 m, di seta nera, con scritte e versetti coranici decorati in oro, dal peso complessivo di circa 670 kg). I pellegrini sperano di essere tra quei fortunati che riceveranno una striscetta del vecchio drappo che nell’occasione viene sminuzzato. Nel video qui sotto la sostituzione di quest’anno. Aggiungo anche che da quest’anno è stato installato un nuovo percorso sopraelevato per permettere anche ai fedeli con disabilità, di percorrere i canonici 7 giri intorno alla Kaaba.
Ramadan a Gerusalemme est
Morire di apostasia
In terza stiamo parlando di pena di morte. Una delle tante cose che colpiscono è senza dubbio l’esistenza in taluni paesi, come l’Arabia Saudita, della pena capitale per apostasia. Su Il Sussidiario c’è un’intervista recente di Pietro Vernizzi a Massimo Introvigne.
“Il 64% dei musulmani in Egitto e in Pakistan sono convinti del fatto che chi si converte  dall’islam al cristianesimo vada punito con la morte. E’ quanto emerge da un rapporto del Pew Research Center, uno dei più importanti istituti di ricerca al mondo sulle religioni. A balzare agli occhi sono le differenze all’interno del mondo islamico. Se il 78% dei cittadini dell’Afghanistan è convinto che vada applicata la pena di morte per chi si converte, solo il 16% dei musulmani tunisini e il 13% di quelli libanesi è convinto della stessa cosa. Un’opinione che si riduce radicalmente tra i musulmani dei Paesi europei: il 2% in Bosnia e Turchia e l’1% in Albania. Ilsussidiario.net ha intervistato Massimo Introvigne.
dall’islam al cristianesimo vada punito con la morte. E’ quanto emerge da un rapporto del Pew Research Center, uno dei più importanti istituti di ricerca al mondo sulle religioni. A balzare agli occhi sono le differenze all’interno del mondo islamico. Se il 78% dei cittadini dell’Afghanistan è convinto che vada applicata la pena di morte per chi si converte, solo il 16% dei musulmani tunisini e il 13% di quelli libanesi è convinto della stessa cosa. Un’opinione che si riduce radicalmente tra i musulmani dei Paesi europei: il 2% in Bosnia e Turchia e l’1% in Albania. Ilsussidiario.net ha intervistato Massimo Introvigne.
Da questa ricerca emergono enormi differenze tra Paesi come Egitto e Turchia. Significa che non esiste un solo islam, ma molti islam differenti?
Le differenze sono state determinate dalla tradizione giuridica di queste nazioni. In Paesi come la Turchia, la Tunisia o l’Albania sono secoli che la pena di morte per apostasia, che pure è prevista secondo l’interpretazione della maggioranza delle scuole giuridiche del diritto islamico, non è più applicata e non è neppure all’ordine del giorno. Mentre in Egitto è notizia di pochi giorni fa che anche autorità giuridiche importanti si sono pronunciate a favore del ritorno alla pena di morte. E’ quanto sta succedendo anche in altri Paesi musulmani.
La pena di morte per l’apostasia è caratteristica soltanto dell’islam?
Questo è un grande punto di differenza tra una parte molto significativa del mondo musulmano e le altre religioni, perché effettivamente il diritto di cambiare religione, consacrato nelle carte internazionali dei diritti, per l’islam non esiste. In quest’ottica si ha diritto soltanto di convertirsi alla religione musulmana, ma non dall’islam a un’altra religione. Quest’ultimo è considerato un crimine, ed è la ragione per cui molti Paesi musulmani non hanno mai firmato neanche la Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo del 1948. Quest’ultima comporta infatti il diritto di cambiare religione, che la tradizione islamica non può riconoscere. Scavando all’interno delle scuole giuridiche e delle interpretazioni, soprattutto in Turchia, si può arrivare a costruire qualcosa di simile alla libertà religiosa. E’ però molto difficile, perché nella tradizione giuridica islamica la libertà di cambiare religione non c’è.
Questi dati smentiscono chi afferma che la tradizione egiziana dell’Università di Al-Azhar sarebbe più tollerante rispetto a quella di altri Paesi come l’Arabia Saudita?
Il Pew Research Center non fornisce il dato sull’Arabia Saudita, che sarebbe stato forse pari al 90%, riflettendo così la legislazione vigente. Non c’è dubbio che in Egitto, anche in seguito alle vicende politiche della Primavera araba, qualcosa sia cambiato e ci sia stato uno spostamento verso posizioni di tipo fondamentalista. Tra l’altro quest’ultime posizioni erano già diffuse prima. A proposito di sondaggi di opinione fatti all’epoca di Mubarak, bisogna sempre chiedersi se esprimessero realmente le opinioni della maggioranza degli egiziani o se fossero manipolati dal regime. Sta di fatto che ora che è caduta la dittatura le opinioni che si manifestano sono molto meno tolleranti.
La seconda Sura del Corano afferma che non deve esserci “nessuna costrizione nella religione”. E’ in contraddizione con la pena di morte per chi commette apostasia?
Questa non deve essere interpretata in modo sbagliato. Con queste parole il Corano si riferisce non a chi è musulmano: nell’interpretazione che ne danno quasi tutte le scuole giuridiche, vuol dire che i cristiani e gli ebrei non devono essere costretti a diventare musulmani. L’islam tradizionale insegna che i cristiani e gli ebrei devono essere esclusi dalle posizioni di governo, ma che non ci deve essere nessuna costrizione perché qualcuno si converta. Questa tutto sommato è una regola a cui tra alti e bassi l’islam tradizionale si è sempre attenuto. Ciò non significa però che ci sia un diritto di chi è già musulmano a cambiare religione: questa non è una scelta religiosa ma un crimine di apostasia che deve essere punito.”
Tra estremismi e fondamentalismi
Il giornalista Mostafa El Ayoubi su Nigrizia di maggio scrive della situazione degli estremismi religiosi in Egitto.
 “L’ascesa al potere degli islamisti in Egitto, dopo la rivoluzione del 25 gennaio 2011, preoccupa molto la comunità cristiana in questo paese, la cui scena politica è dominata dal movimento islamista dei Fratelli musulmani (Fm). Di fatto tutti i poteri (giudiziario, legislativo ed esecutivo) sono concentrati nelle mani di Mohammed Morsi, il primo presidente eletto democraticamente dopo decenni di dittatura militare. Morsi è membro del movimento dei Fm, il quale ambisce a “reislamizzare” le istituzioni e la società civile. Le frange estremiste della confraternita dei Fm e quelle del movimento salafita, suo alleato, sono molto ostili ai copti: li considerano dei miscredenti ai quali lo stato deve impedire di costruire chiese e deve reintrodurre per loro lo statuto di dhimmi (cittadini non musulmani sottomessi con l’obbligo di pagare la jizya, una tassa prescritta dalla legge islamica).
“L’ascesa al potere degli islamisti in Egitto, dopo la rivoluzione del 25 gennaio 2011, preoccupa molto la comunità cristiana in questo paese, la cui scena politica è dominata dal movimento islamista dei Fratelli musulmani (Fm). Di fatto tutti i poteri (giudiziario, legislativo ed esecutivo) sono concentrati nelle mani di Mohammed Morsi, il primo presidente eletto democraticamente dopo decenni di dittatura militare. Morsi è membro del movimento dei Fm, il quale ambisce a “reislamizzare” le istituzioni e la società civile. Le frange estremiste della confraternita dei Fm e quelle del movimento salafita, suo alleato, sono molto ostili ai copti: li considerano dei miscredenti ai quali lo stato deve impedire di costruire chiese e deve reintrodurre per loro lo statuto di dhimmi (cittadini non musulmani sottomessi con l’obbligo di pagare la jizya, una tassa prescritta dalla legge islamica).
In passato, anche sotto i regimi militari, cosiddetti laici, la vita dei copti non è sempre stata facile. Spesso sono stati strumentalizzati, specie nel trentennio Mubarak, per canalizzare la rabbia popolare verso lo scontro interconfessionale tra cristiani e musulmani, con lo scopo di sviare l’attenzione degli egiziani dai problemi della giustizia sociale, della libertà e della corruzione da un lato, e giustificare lo stato di polizia e la repressione dall’altro. Oggi, sotto il regime islamista, la questione copta continua a essere strumentalizzata. A quasi un anno dall’elezione di Morsi e a sei mesi da quella del nuovo patriarca copto ortodosso Tawadros II, nulla è stato fatto riguardo al processo di riconciliazione tra musulmani e copti. Gli episodi di violenza che all’inizio di aprile scorso hanno coinvolto cristiani, musulmani e forze dell’ordine, ripropongono le stesse dinamiche dei tempi passati in maniera ancora più drammatica; ne sono la dimostrazione gli scontri sanguinosi nel recinto della cattedrale di San Marco al Cairo, avvenuti il 7 aprile durante la celebrazione dei funerali di quattro copti rimasti uccisi due giorni prima in uno scontro con i musulmani. L’attacco alla cattedrale, luogo simbolo dei copti ortodossi, è stato considerato un atto gravissimo «senza precedenti» nella storia dell’Egitto dal patriarca Tawadros II, che ha esplicitamente chiamato in causa Morsi: «Ha promesso di fare di tutto per proteggere la cattedrale ma non è quello che noi vediamo». Un lancio della France Presse del 9 aprile ha parlato di «immagini diffuse da varie tivù che mostravano la polizia sparare lacrimogeni in direzione della cattedrale». Accuse gravi che denotano una tensione tra i vertici della Chiesa copta e lo stato. L’elezione di un islamista come raïs della repubblica post rivoluzionaria ha accentuato il sentimento di insicurezza e di marginalizzazione degli 8 milioni di copti.
La Chiesa copta imputa a Morsi di aver imposto agli egiziani una costituzione che favorisce gli islamisti nel loro intento di istituire l’islam come unica fonte della legislazione. Per questo, i copti si sono ritirati dalla commissione incaricata di redigere la nuova costituzione. È utile ricordare che questa è stata approvata nel dicembre 2012 con il sì del 63,8% della popolazione, ma con un tasso di partecipazione inferiore al 33%. Nonostante abbia dichiarato di voler essere il «presidente di tutti» e abbia condannato la violazione della sacralità della cattedrale di San Marco, Morsi (e i Fm) nutre risentimenti nei riguardi della comunità copta. Alle presidenziali i copti hanno votato in maggioranza per Ahmed Shafik, ex ministro di Mubarak, e al referendum sulla costituzione hanno votato “no”. Occorre inoltre rammentare che il precedente patriarca, Shenuda III, era a favore del passaggio del potere al figlio di Mubarak.
Le frange estremiste degli islamisti, non nutrono solo risentimento nei confronti della comunità copta e di altri cristiani. La massiccia diffusione dei canali tivù via satellite ha favorito il proliferare di telepredicatori jihadisti che seminano odio nei confronti dei copti, che considerano «infedeli», e di tutti coloro che non condividono la loro dottrina. E un estremismo tira l’altro. Anche dalla parte cristiana, vi sono frange intransigenti che attraverso le tivù diffondono all’interno della loro comunità impulsi islamofobi e fomentano lo scontro interconfessionale. Due giorni prima della violenza alla cattedrale, ragazzi copti hanno disegnato una croce sulla facciata di un istituto islamico nella città Al-khoussous: un pretesto servito su un piatto d’argento ai fanatici dell’altra sponda per replicare. Di fronte a questa nuova escalation di scontri tra musulmani e cristiani, il nuovo regime accusa fouloul a-nidam (i resti del vecchio regime) di strumentalizzare il discorso interconfessionale per mettere in difficoltà gli islamisti al potere e provocare il caos.”
Intanto a Washington un imam…
Leggo su Libero un articolo di Enrica Ventura del 19 aprile:
 “Si chiama Daayiee Abdullah, è un imam dichiaratamente gay, forse l’unico al mondo, che vive a Washington e sposa le coppie omosex musulmane. Ieri si è presentato al pubblico con la presentazione di un documentario «Sono gay e musulmano» proiettato nell’Equality Center della città statunitense in occasione di una serata organizzata dall’associazione per i diritti dei gay Human rights campaign. «Penso che siamo all’inizio di un movimento per un islam più inclusivo in America», ha detto presentandosi al pubblico «così se volete un matrimonio tra persone dello stesso sesso io sono disponibile». E se i matrimoni fra persone dello stesso sesso sono un tema caldo nelle polemiche politiche negli stessi Stati Uniti (se ne sta occupando la Corte suprema) e in Francia (dove la legge voluta dal presidente François Hollande è vicina all’approvazione), in molti Stati dell’islam l’omosessualità viene addirittura punita con la pena di morte, ad esempio in Arabia saudita o in Sudan. Afroamericano convertito all’islam, Abdullah guida la moschea progressista «Luce della Riforma». Per il momento i matrimoni da lui celebrati sono stati fatti nella massima discrezione: lui stesso ha sempre chiesto di non pubblicare foto su Internet e di non fare troppa pubblicità alla cerimonia. Gli altri imam americani gli hanno già dichiarato la guerra e su Internet lo definiscono «deviato e perverso», un «trafficante di idee proibite in islam». In alcuni Paesi musulmani però l’apertura a quel mondo sta facendo dei progressi: sono infatti sette, su 23mila, i candidati transgender alle elezioni parlamentari che si terranno l’11 maggio in Pakistan. Una rappresentanza dei circa 500mila eunuchi pakistani che ha però la forza di una rivoluzione nel sistema politico locale. Perché è la prima volta che, come indipendenti, si presentano alle urne i rappresentanti di omosessuali, transessuali, travestiti, ermafroditi, uomini castrati. Eunuchi, appunto, che secondo la tradizione vengono chiamati a ballare ai matrimoni o alle celebrazioni per la nascita di un figlio secondo la credenza che chi è nato sfortunato porterà fortuna. «La gente non crede che possiamo essere corrotti perché non abbiamo né figli, né famiglia», dice la candidata indipendente Sanam Faqeer. «Non abbiamo bisogno di rubare soldi come fanno altri politici».”
“Si chiama Daayiee Abdullah, è un imam dichiaratamente gay, forse l’unico al mondo, che vive a Washington e sposa le coppie omosex musulmane. Ieri si è presentato al pubblico con la presentazione di un documentario «Sono gay e musulmano» proiettato nell’Equality Center della città statunitense in occasione di una serata organizzata dall’associazione per i diritti dei gay Human rights campaign. «Penso che siamo all’inizio di un movimento per un islam più inclusivo in America», ha detto presentandosi al pubblico «così se volete un matrimonio tra persone dello stesso sesso io sono disponibile». E se i matrimoni fra persone dello stesso sesso sono un tema caldo nelle polemiche politiche negli stessi Stati Uniti (se ne sta occupando la Corte suprema) e in Francia (dove la legge voluta dal presidente François Hollande è vicina all’approvazione), in molti Stati dell’islam l’omosessualità viene addirittura punita con la pena di morte, ad esempio in Arabia saudita o in Sudan. Afroamericano convertito all’islam, Abdullah guida la moschea progressista «Luce della Riforma». Per il momento i matrimoni da lui celebrati sono stati fatti nella massima discrezione: lui stesso ha sempre chiesto di non pubblicare foto su Internet e di non fare troppa pubblicità alla cerimonia. Gli altri imam americani gli hanno già dichiarato la guerra e su Internet lo definiscono «deviato e perverso», un «trafficante di idee proibite in islam». In alcuni Paesi musulmani però l’apertura a quel mondo sta facendo dei progressi: sono infatti sette, su 23mila, i candidati transgender alle elezioni parlamentari che si terranno l’11 maggio in Pakistan. Una rappresentanza dei circa 500mila eunuchi pakistani che ha però la forza di una rivoluzione nel sistema politico locale. Perché è la prima volta che, come indipendenti, si presentano alle urne i rappresentanti di omosessuali, transessuali, travestiti, ermafroditi, uomini castrati. Eunuchi, appunto, che secondo la tradizione vengono chiamati a ballare ai matrimoni o alle celebrazioni per la nascita di un figlio secondo la credenza che chi è nato sfortunato porterà fortuna. «La gente non crede che possiamo essere corrotti perché non abbiamo né figli, né famiglia», dice la candidata indipendente Sanam Faqeer. «Non abbiamo bisogno di rubare soldi come fanno altri politici».”
Fessure di dialogo
Stamattina si è tenuta, in piazza San Pietro l’udienza generale del papa. Subito dopo Bergoglio ha incontrato l’ambasciatore saudita in Italia Salh Mohammad Al Ghamdi, che ha consegnato al papa un messaggio del re Abdullah. Il giornalista Giacomo Galeazzi su Vatican Insider fa il punto della situazione sull’Arabia Saudita per quanto riguarda le libertà religiose e i diritti delle donne.
“Il Regno wahhabita continua ad essere indicato da tutti gli osservatori internazionali  come un «Paese di particolare preoccupazione» per la persistenza di violazioni gravi della libertà religiosa, nei fatti e nelle disposizioni legislative. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le dichiarazioni in cui responsabili sauditi hanno affermato la possibilità per i lavoratori non musulmani di celebrare il proprio culto in privato. Tuttavia, la nozione di “privato” rimane vaga. Il governo ha affermato che, finché le riunioni dei non musulmani avessero riguardato piccoli gruppi riuniti in case private, nessun organo della sicurezza sarebbe intervenuto. Questa posizione, sebbene ufficiale, viene comunque violata, dato che continuano a verificarsi casi in cui la polizia religiosa fa irruzione in abitazioni private in cui si svolgono simili riunioni di preghiera. Altro motivo di preoccupazione per i cristiani (come per tutti i non musulmani residenti nel Regno) è l’eccessivo lasso di tempo (settimane) necessario per l’espatrio delle salme di lavoratori stranieri deceduti. L’Arabia Saudita non autorizza la sepoltura nei propri territori di non musulmani e su tale questione ha richiamato l’attenzione una delegazione americana in visita nel Paese. Il rapporto Acs documenta diversi casi di arresto di fedeli cristiani; in alcuni casi, la notizia non sarebbe stata diffusa, per garantire il buon esito delle trattative per il loro rilascio che venivano stabilite tra governo saudita e il Paese di provenienza degli arrestati. Nel gennaio 2012, re Abdullah ha sollevato dall’incarico il capo della polizia religiosa Abdul-Aziz Humayen, sostituendolo con Abdul-Latif bin Abdul-Aziz Al Sheikh, appartenente alla famiglia degli Al Sheikh che guida l’establishment wahhabita. Non sono state fornite indicazioni sulle ragioni del cambio, anche se è utile segnalare che, nel 2009, il predecessore di Al Sheikh era stato scelto per riformare la polizia religiosa. Aveva assunto consulenti, incontrato gruppi per i diritti umani ed esperti d’immagine per migliorare la reputazione della polizia dopo episodi che avevano indignato l’opinione pubblica saudita. Gli agenti della polizia religiosa vegliano sull’applicazione delle leggi che regolano la sfera civile, religiosa e sessuale nel Paese. Tra i loro compiti c’è quello di verificare che i negozi siano chiusi durante la preghiera, fermare le coppie non sposate e le donne non coperte dalla testa ai piedi assicurandosi anche che esse non guidino automobili. Vita dura anche per gli sciiti e gli ismaeliti, così come per i blogger portatori di idee pseudo-rivoluzionarie.
come un «Paese di particolare preoccupazione» per la persistenza di violazioni gravi della libertà religiosa, nei fatti e nelle disposizioni legislative. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le dichiarazioni in cui responsabili sauditi hanno affermato la possibilità per i lavoratori non musulmani di celebrare il proprio culto in privato. Tuttavia, la nozione di “privato” rimane vaga. Il governo ha affermato che, finché le riunioni dei non musulmani avessero riguardato piccoli gruppi riuniti in case private, nessun organo della sicurezza sarebbe intervenuto. Questa posizione, sebbene ufficiale, viene comunque violata, dato che continuano a verificarsi casi in cui la polizia religiosa fa irruzione in abitazioni private in cui si svolgono simili riunioni di preghiera. Altro motivo di preoccupazione per i cristiani (come per tutti i non musulmani residenti nel Regno) è l’eccessivo lasso di tempo (settimane) necessario per l’espatrio delle salme di lavoratori stranieri deceduti. L’Arabia Saudita non autorizza la sepoltura nei propri territori di non musulmani e su tale questione ha richiamato l’attenzione una delegazione americana in visita nel Paese. Il rapporto Acs documenta diversi casi di arresto di fedeli cristiani; in alcuni casi, la notizia non sarebbe stata diffusa, per garantire il buon esito delle trattative per il loro rilascio che venivano stabilite tra governo saudita e il Paese di provenienza degli arrestati. Nel gennaio 2012, re Abdullah ha sollevato dall’incarico il capo della polizia religiosa Abdul-Aziz Humayen, sostituendolo con Abdul-Latif bin Abdul-Aziz Al Sheikh, appartenente alla famiglia degli Al Sheikh che guida l’establishment wahhabita. Non sono state fornite indicazioni sulle ragioni del cambio, anche se è utile segnalare che, nel 2009, il predecessore di Al Sheikh era stato scelto per riformare la polizia religiosa. Aveva assunto consulenti, incontrato gruppi per i diritti umani ed esperti d’immagine per migliorare la reputazione della polizia dopo episodi che avevano indignato l’opinione pubblica saudita. Gli agenti della polizia religiosa vegliano sull’applicazione delle leggi che regolano la sfera civile, religiosa e sessuale nel Paese. Tra i loro compiti c’è quello di verificare che i negozi siano chiusi durante la preghiera, fermare le coppie non sposate e le donne non coperte dalla testa ai piedi assicurandosi anche che esse non guidino automobili. Vita dura anche per gli sciiti e gli ismaeliti, così come per i blogger portatori di idee pseudo-rivoluzionarie.
Passo positivo l’istituzione per iniziativa del sovrano, in collaborazione con Austria e Spagna, di un Centro internazionale per il dialogo inter-religioso e inter-culturale. In Arabia Saudita per i cristiani non è possibile alcun culto pubblico. La situazione è particolarmente pesante soprattutto per l’altra metà del cielo. Muri divisori nei negozi per separare donne e uomini: è l’ultima forma di segregazione imposta nel regno saudita per “proteggere” commesse e clienti dagli sguardi maschili. La misura verrà applicata nei negozi in cui sono impiegati commessi di sesso diverso. Le barriere dovranno essere alte almeno 1,60 metri. Le donne possono lavorare solo in luoghi di sole donne oppure nella vendita di biancheria intima e cosmetici. Questi ultimi due settori di lavoro sono stati approvati nel giugno 2011, quando il governo impose che i commessi (in gran parte uomini di origine asiatica) fossero sostituiti con donne saudite. Un provvedimento che aprì 44mila nuove posizioni di lavoro per donne saudite (il tasso di inoccupazione femminile è del 36%, solo il 7% della popolazione occupata nel privato è composta da donne). Fu una decisione sollecitata dalle stesse saudite che si dicevano a disagio nell’acquistare biancheria intima e cosmetici dagli uomini. Ma l’arrivo di tante donne nei luoghi di lavoro misti – ad esempio i centri commerciali – aveva sollevato problemi diversi, non ultimi molti casi di molestie. La misura adottata per eliminare il problema è, come spesso è capitato nel Paese, drastica e orientata alla segregazione: i muri. Il cammino di emancipazione delle donne saudite è ancora allo stato embrionale. All’inizio dell’anno alle donne è stato permesso di partecipare al Consiglio consultiva della Shura, e 30 donne ne sono entrate a far parte – anche se per partecipare devono usare ingressi separati. Note ormai le campagne per il diritto di guida (soprattutto grazie alla popolare campagna di disobbedienza civile di Manal al Sharif divenuta popolare sui social network come #womentodrive), mentre il Regno del Golfo è uno dei pochi paesi al mondo che nega il suffragio universale. Le donne devono avere il permesso degli uomini per lavorare, viaggiare o aprire un conto corrente bancario.”
Nella pratica
Un articolo dello scorso 23 gennaio: me l’ero perso. E’ di Riccardo Bruno, l’ho preso dal Corriere.
“Il giovane parroco attende la fine dei versi del Corano. Poi si sfila le scarpe, sale sul tappeto accanto alla bara e inizia la sua preghiera. «Papà mi ha insegnato che esiste un solo Dio, che siamo tutti fratelli». È l’ultimo saluto del figlio ad Adel, arrivato dall’Egitto 34 anni fa. Alla periferia d’Italia, appena prima del confine svizzero, in un cortile tra due file di garage, si celebra un funerale insolito: il figlio Nur, che ha abbracciato la fede cattolica fino a farsi prete, tiene l’orazione funebre per il padre, musulmano osservante e fiero delle sue origini.
Mentre una trentina di arabi invocano «Allah Akbar», Allah è grande, attorno le famiglie  del posto si mescolano alla comunità islamica, e tra loro una decina di sacerdoti cattolici e due suore giunte da tutta la diocesi. «Vale più una giornata come questa che mille convegni sull’integrazione» osserva don Renato Sacco, di Pax Christi, animatore in provincia del dialogo tra le religioni. È stato lui a suggerire di tenere la cerimonia funebre all’aperto, perché il piccolo appartamento che ospita il centro culturale islamico avrebbe contenuto a malapena una decina di persone. Adel Nassar, il padre di don Nur, quando seppe che suo figlio avrebbe indossato l’abito talare non la prese bene. Ma subito dopo lo incoraggiò e lo aiutò. E sicuramente oggi sarebbe contento di vedere come è stato il suo addio alla vita. «Era il suo sogno vedere tutti uniti, musulmani e cattolici. Finalmente quel desiderio si è realizzato» osserva Ali Bouchbika, uno dei primi a credere nella comunità islamica in Val D’Ossola. Adesso sono più di 1.500, soprattutto marocchini, come lui, ma anche tunisini ed egiziani. Un po’ di diffidenza, qualche tensione, alcune battute di politici difficili da digerire, ma in fondo una convivenza pacifica, meglio che altrove.
del posto si mescolano alla comunità islamica, e tra loro una decina di sacerdoti cattolici e due suore giunte da tutta la diocesi. «Vale più una giornata come questa che mille convegni sull’integrazione» osserva don Renato Sacco, di Pax Christi, animatore in provincia del dialogo tra le religioni. È stato lui a suggerire di tenere la cerimonia funebre all’aperto, perché il piccolo appartamento che ospita il centro culturale islamico avrebbe contenuto a malapena una decina di persone. Adel Nassar, il padre di don Nur, quando seppe che suo figlio avrebbe indossato l’abito talare non la prese bene. Ma subito dopo lo incoraggiò e lo aiutò. E sicuramente oggi sarebbe contento di vedere come è stato il suo addio alla vita. «Era il suo sogno vedere tutti uniti, musulmani e cattolici. Finalmente quel desiderio si è realizzato» osserva Ali Bouchbika, uno dei primi a credere nella comunità islamica in Val D’Ossola. Adesso sono più di 1.500, soprattutto marocchini, come lui, ma anche tunisini ed egiziani. Un po’ di diffidenza, qualche tensione, alcune battute di politici difficili da digerire, ma in fondo una convivenza pacifica, meglio che altrove.
Il futuro don Nur è cresciuto in questi cortili, sentendo i racconti del padre e dei parenti immigrati, e correndo nell’oratorio che frequentava la madre Ines, infermiera e impegnata nell’associazionismo cattolico. Una famiglia dalla fede profonda, anche se coniugata in due modi diversi. Sempre nel rispetto reciproco. Il frutto di tutto questo è lì, in quella immagine di un giovane prete che a stento trattiene le lacrime per il dolore del padre morto e che prima di tutto si preoccupa di ringraziare «il fratello Said e il fratello Mohammed, che ieri lo hanno lavato e profumato».
Il vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla, manda un messaggio che la comunità islamica apprezza: «La singolare esperienza del padre di don Nur, l’aver voluto bene alla moglie, di diversa religione, non solo gli ha permesso grande attenzione alla coscienza e al cammino degli altri, ma ha ricevuto altresì ammirazione per la rettitudine della sua fede e l’impegno nella sua comunità». Alle quattro della sera, la bara di mogano viene calata dentro la fossa, nel campo del cimitero che è stato da poco riservato ai non cattolici. Adel Nassir è il primo ad essere sepolto lì. Gli addetti del cimitero avanzano con il piccolo trattore per coprire di terra il feretro. Ma gli uomini della comunità islamica li fermano e afferrano le pale, preferiscono fare da soli. Quelli de posto li guardano, sorpresi. Ma presto, anche loro si uniscono.”
Cercavo taumaturghi erranti
Un articolo di quelli che raccontano di umanità altre, così distanti dalla nostra quotidianità. E’ di Monika Bulaj, l’originale è qui.
Ho incontrato la donna kamikaze un giorno di sole e di polvere, in un piccolo santuario, oltre una piccola porta di legno, in una strada che non saprei ritrovare nel labirinto della vecchia Kabul. Mi si è avvicinata tra una folla di donne, accanto al sarcofago di un santo, una tomba di marmo coperta di tessuti con scritture dorate. Da quel momento non ho avuto pace, lei mi segue ancora nel pensiero. Non so se sia viva o morta. Le sfuggo e la cerco, mi spaventa e mi attrae. La ritrovo negli sguardi di tante donne in Afghanistan. Immagino la sua ombra magra, allucinata, sgomitare nelle strade intasate, infilarsi tra i carretti e il filo spinato, saltare sugli autobus in partenza infilandosi tra le porte appena socchiuse. È successo dopo mesi di viaggio dal confine dell’Iran a quello cinese sulle nevi del Pamir, un viaggio compiuto da sola, affidandomi al buon senso della gente del posto ed evitando con cura i luoghi pattugliati dai militari. Cercavo luoghi sacri, taumaturghi erranti, nomadi e storie di donne, e in quella porticina che dà sulla strada della vecchia Kabul vedo entrare donne, fagotti plissettati che vanno sotto il nome di burqa. La soglia è piccola, devo chinarmi, l’ambiente è soffocante ma si riempie di altri corpi ancora. Dentro è penombra ma fuori il sole è allo zenith, i muezzin chiamano alla preghiera di mezzogiorno. L’ora in cui Kabul respira di sollievo. L’incubo quotidiano è finito. Qui i kamikaze si fanno esplodere al mattino. Lo fanno per arrivare in paradiso all’ora di pranzo, in tempo per banchettare col Profeta. Sono vestita all’afgana, ho una veste lunga e nera, col velo che copre i capelli ma lascia libero l’ovale della faccia. Sotto ho il mio taccuino e la mia Leica. Non oso toccarli. Le donne mormorano preghiere, scoprono i volti bruciati dal sole d’alta quota, si tolgono il burqa, mostrano bellezza e sofferenza, si cercano, si toccano, liberano tra loro una complicità sensuale. Poi, dopo qualche minuto, una bambina col velo bianco, la divisa della scuola, mi nota, tocca il mio viso e si mette a piangere. «Perché piangi?» le chiedo in lingua dari. «Perché sei straniera e porti il velo, come noi». È allora che la diga si rompe, la voce corre, sono una cristiana che ama l’Islam, e tra le altre donne si innesca una reazione a catena fuori misura. Il mio corpo è già reliquia, vi strisciano contro, lo baciano, vi depongono caramelle e banconote per santificare qualcosa di loro e poi infilarsela nelle tasche o nei reggiseni. Cercano barakà, la benedizione, perché sono un’ospite e mi sono fidata. Piangono, asciugano le lacrime, si soffiano il naso nei burqa, mi infilano le dita inanellate nei capelli, mi sfiorano la guancia col dorso delle mani. Una di loro esige da me la grazia speciale di avere figli. Come in un sogno. Sono in ostaggio, ma non mi oppongo, mi affido. Sono in imbarazzo, ma sorrido. Tutto quello che ho cercato in mesi di lavoro mi piomba addosso all’improvviso. Dal ruolo di testimone invisibile a quello, non voluto, di protagonista al centro di un culto. “Volevi gli uomini di Dio? Guaritori erranti? Donne in estasi?” chiedo a me stessa quasi ad alta voce. “Eccoti accontentata…”. Credendo che io stia pregando le donne alzano le mani al cielo. Tra le tante che mi stanno addosso ce n’è una che non sorride né piange. Il suo velo è buttato senza cura sopra i capelli maltinti di hennè. Un corpo magro, le sopracciglia accentuate da un segno maldestro di kajal. Cerco di sottrarmi al suo contatto fisico. Ma lei mi stringe verso il muro, come per isolarmi dalle altre e si sbottona il vestito per mostrarmi qualcosa. Mi aspetto una ferita, e invece vedo il suo corpo magro impacchettato in una maglia di cilindri verticali legati da fili elettrici. Non capisco, forse non voglio capire. Penso alle armi di un agente segreto, all’autodifesa di una donna più emancipata. Ma le cose che ha intorno alla pancia non sono pistole, è dinamite. Sembra un’insegnante delle elementari invecchiata troppo presto. Quanti anni avrà: trenta? Cinquanta? Da dove viene? Dove sta andando? Perché mostra proprio a me la sua macchina di morte? Fingo di non aver capito. Le chiedo: «Dove sono i tuoi figli?». Il modo con cui volta la testa mi gela. Vuol dire che non ne ha più. Forse sono morti. Smetto di chiedere. Le domande si fermano sulle labbra. Ho paura, guardo altrove. Dico a mia volta:«Man se farzand daram », ho tre figli maschi. È la frase che meglio mi protegge in questo Paese. Il mio mantra, il mio lasciapassare, il mio elmetto in kevlar, la mia personale guardia del corpo. La donna che fa figli maschi qui è una donna vera, rispettata. Nella valle di Khost, durante un matrimonio, mi hanno quasi festeggiata per questo. Ora la pelle della donna è sudata, pallida, gli occhi sono folli, stanchi, freddi, asciutti. Sento il suo gomito ossuto, i muscoli duri delle cosce. La guerra ha portato a questo. La morte è un affare fiorente in Afghanistan. La carne umana è in vendita, diventa arma che si fa esplodere. Stragi a opera di kamikaze. Rapimenti di bambini e di adulti sospettati di avere risparmi. Omicidi su richiesta. «Duemila dollari – mi hanno detto amici afgani – sono la tariffa per uccidere qualcuno, e tutti sanno come trovare un sicario». Anche i kamikaze fanno lo stesso, per comprare la casa alla famiglia o saldare un debito. Economia di guerra, non martirio. Sento ogni fibra del mio corpo e ho la certezza incosciente che non accadrà nulla. Eppure temo che le parole possano svegliare qualcosa, far tremare la corda di un nervo, spezzare il filo della sua follia. Così cerco di esprimere uno sguardo indifferente per sorvolare la sua faccia piatta piena di rughe, le mezzelune nere delle unghie, la cintura sfatta della borsetta, l’odore del sapone e l’acido del suo respiro. Intorno le altre donne non si sono accorte di nulla. Continuano a ignorare il santo per guardare me, affascinate, piangendo. Esco a fatica. Lei mi segue, mi aderisce come un’ombra. Fuori, una barriera di burqa in nylon con macchie di respiro all’altezza delle labbra. Anche queste mi stringono. «Guardatela- dice una di loro – una issawì che ama l’Islam! Una haredzì che ama l’Afghanistan!». Issawi vuol dire “seguace di Issa”, il Cristo. Haredzi significa straniero. Ecco, io sono questo per loro. Infedele e straniera, eppure ho una faccia, odore, occhi, voce. Sono occidentale, eppure non sono chiusa in un blindato, non sto dietro il mirino di un mitra. Mi allontano senza salutare, come per dire “non c’ entro”, “non c’ero”. Non dico nemmeno “Khoda Hafez”, che Dio si ricordi di te, l’arrivederci degli afgani. Ma lei mi segue. Cammino lentamente per comunicare una tranquillità che non ho, lo faccio con passi lunghi, per seminarla. Ne esce una camminata abnorme. Scherzo con venditori ambulanti, mi infilo nella folla senza voltarmi e senza fretta apparente, per non far vedere che la mia è una fuga. Passo davanti agli ultimi Sikh della città che, con dadi e conchiglie, predicono il futuro alle musulmane al riparo di grandi ombrelli. Stavolta mi giro, lei non c’è. E Kabul ridiventa reale, con la sua puzza di fogna, le grida dei bambini di strada che danno manate sui blindati che passano come sul culo degli asini, il ronzio degli elicotteri d’assalto che volano così bassi che il soffio delle loro eliche spaventa i pappagalli verdi sugli eucalipti. Kabul, con i carillon dei gelatai ambulanti che strillano Per Elisa e Jingle Bells, vittoria sui divieti talebani contro la musica. Cerco di mimetizzarmi nel passo disinvolto delle donne afgane, un linguaggio mimetico del corpo che ho imparato ad assumere in fretta, anche per la mia incolumità. Ma stavolta la paura si è insinuata in me senza che me ne rendessi conto, è già diventata riflesso fisiologico. Bagnerò il mio letto quella notte, e da allora non riuscirò a dormire che a brevi intervalli. Ora riconosco i luoghi. Torno d’ istinto nel quartiere dei musicisti, dove ho il mio dentista privato. Un santuario con chiodi magici piantati sullo stipite della porta, ogni chiodo guarisce un dente. Poi trovo un barbiere con una foresta di capelli abramitica che mi invita a bere un tè e mi svela allegramente di avere interpretato Osama Bin Laden in un film. L’Afghanistanè così, dalla tragedia alla farsa nel giro di un’ora. Non so più dove ho fatto quel terribile incontro. Il mio sentimento per quella donna è un grumo fatto di pietà, condanna e paura. So che se la denunciassi non mi crederebbero, oppure partirebbe una rappresaglia di sangue. Sparisce l’ultimo raggio porpora sulle cime immacolate dell’Hindukush. Le luci tenui nelle case d’argilla si accendono sui colli che ora paiono il presepe di Betlemme. Un asino porta in salita una donna incinta con un’ombra accanto. Pare quella di Giuseppe, il falegname. E intanto la donna imbottita d’esplosivo, da qualche parte, si toglie la “cintura del martirio”, come la chiamano gli estremisti dell’Islam, e srotola per terra la trapunta colorata nella sua casa senza figli. Ma non dorme.
oltre una piccola porta di legno, in una strada che non saprei ritrovare nel labirinto della vecchia Kabul. Mi si è avvicinata tra una folla di donne, accanto al sarcofago di un santo, una tomba di marmo coperta di tessuti con scritture dorate. Da quel momento non ho avuto pace, lei mi segue ancora nel pensiero. Non so se sia viva o morta. Le sfuggo e la cerco, mi spaventa e mi attrae. La ritrovo negli sguardi di tante donne in Afghanistan. Immagino la sua ombra magra, allucinata, sgomitare nelle strade intasate, infilarsi tra i carretti e il filo spinato, saltare sugli autobus in partenza infilandosi tra le porte appena socchiuse. È successo dopo mesi di viaggio dal confine dell’Iran a quello cinese sulle nevi del Pamir, un viaggio compiuto da sola, affidandomi al buon senso della gente del posto ed evitando con cura i luoghi pattugliati dai militari. Cercavo luoghi sacri, taumaturghi erranti, nomadi e storie di donne, e in quella porticina che dà sulla strada della vecchia Kabul vedo entrare donne, fagotti plissettati che vanno sotto il nome di burqa. La soglia è piccola, devo chinarmi, l’ambiente è soffocante ma si riempie di altri corpi ancora. Dentro è penombra ma fuori il sole è allo zenith, i muezzin chiamano alla preghiera di mezzogiorno. L’ora in cui Kabul respira di sollievo. L’incubo quotidiano è finito. Qui i kamikaze si fanno esplodere al mattino. Lo fanno per arrivare in paradiso all’ora di pranzo, in tempo per banchettare col Profeta. Sono vestita all’afgana, ho una veste lunga e nera, col velo che copre i capelli ma lascia libero l’ovale della faccia. Sotto ho il mio taccuino e la mia Leica. Non oso toccarli. Le donne mormorano preghiere, scoprono i volti bruciati dal sole d’alta quota, si tolgono il burqa, mostrano bellezza e sofferenza, si cercano, si toccano, liberano tra loro una complicità sensuale. Poi, dopo qualche minuto, una bambina col velo bianco, la divisa della scuola, mi nota, tocca il mio viso e si mette a piangere. «Perché piangi?» le chiedo in lingua dari. «Perché sei straniera e porti il velo, come noi». È allora che la diga si rompe, la voce corre, sono una cristiana che ama l’Islam, e tra le altre donne si innesca una reazione a catena fuori misura. Il mio corpo è già reliquia, vi strisciano contro, lo baciano, vi depongono caramelle e banconote per santificare qualcosa di loro e poi infilarsela nelle tasche o nei reggiseni. Cercano barakà, la benedizione, perché sono un’ospite e mi sono fidata. Piangono, asciugano le lacrime, si soffiano il naso nei burqa, mi infilano le dita inanellate nei capelli, mi sfiorano la guancia col dorso delle mani. Una di loro esige da me la grazia speciale di avere figli. Come in un sogno. Sono in ostaggio, ma non mi oppongo, mi affido. Sono in imbarazzo, ma sorrido. Tutto quello che ho cercato in mesi di lavoro mi piomba addosso all’improvviso. Dal ruolo di testimone invisibile a quello, non voluto, di protagonista al centro di un culto. “Volevi gli uomini di Dio? Guaritori erranti? Donne in estasi?” chiedo a me stessa quasi ad alta voce. “Eccoti accontentata…”. Credendo che io stia pregando le donne alzano le mani al cielo. Tra le tante che mi stanno addosso ce n’è una che non sorride né piange. Il suo velo è buttato senza cura sopra i capelli maltinti di hennè. Un corpo magro, le sopracciglia accentuate da un segno maldestro di kajal. Cerco di sottrarmi al suo contatto fisico. Ma lei mi stringe verso il muro, come per isolarmi dalle altre e si sbottona il vestito per mostrarmi qualcosa. Mi aspetto una ferita, e invece vedo il suo corpo magro impacchettato in una maglia di cilindri verticali legati da fili elettrici. Non capisco, forse non voglio capire. Penso alle armi di un agente segreto, all’autodifesa di una donna più emancipata. Ma le cose che ha intorno alla pancia non sono pistole, è dinamite. Sembra un’insegnante delle elementari invecchiata troppo presto. Quanti anni avrà: trenta? Cinquanta? Da dove viene? Dove sta andando? Perché mostra proprio a me la sua macchina di morte? Fingo di non aver capito. Le chiedo: «Dove sono i tuoi figli?». Il modo con cui volta la testa mi gela. Vuol dire che non ne ha più. Forse sono morti. Smetto di chiedere. Le domande si fermano sulle labbra. Ho paura, guardo altrove. Dico a mia volta:«Man se farzand daram », ho tre figli maschi. È la frase che meglio mi protegge in questo Paese. Il mio mantra, il mio lasciapassare, il mio elmetto in kevlar, la mia personale guardia del corpo. La donna che fa figli maschi qui è una donna vera, rispettata. Nella valle di Khost, durante un matrimonio, mi hanno quasi festeggiata per questo. Ora la pelle della donna è sudata, pallida, gli occhi sono folli, stanchi, freddi, asciutti. Sento il suo gomito ossuto, i muscoli duri delle cosce. La guerra ha portato a questo. La morte è un affare fiorente in Afghanistan. La carne umana è in vendita, diventa arma che si fa esplodere. Stragi a opera di kamikaze. Rapimenti di bambini e di adulti sospettati di avere risparmi. Omicidi su richiesta. «Duemila dollari – mi hanno detto amici afgani – sono la tariffa per uccidere qualcuno, e tutti sanno come trovare un sicario». Anche i kamikaze fanno lo stesso, per comprare la casa alla famiglia o saldare un debito. Economia di guerra, non martirio. Sento ogni fibra del mio corpo e ho la certezza incosciente che non accadrà nulla. Eppure temo che le parole possano svegliare qualcosa, far tremare la corda di un nervo, spezzare il filo della sua follia. Così cerco di esprimere uno sguardo indifferente per sorvolare la sua faccia piatta piena di rughe, le mezzelune nere delle unghie, la cintura sfatta della borsetta, l’odore del sapone e l’acido del suo respiro. Intorno le altre donne non si sono accorte di nulla. Continuano a ignorare il santo per guardare me, affascinate, piangendo. Esco a fatica. Lei mi segue, mi aderisce come un’ombra. Fuori, una barriera di burqa in nylon con macchie di respiro all’altezza delle labbra. Anche queste mi stringono. «Guardatela- dice una di loro – una issawì che ama l’Islam! Una haredzì che ama l’Afghanistan!». Issawi vuol dire “seguace di Issa”, il Cristo. Haredzi significa straniero. Ecco, io sono questo per loro. Infedele e straniera, eppure ho una faccia, odore, occhi, voce. Sono occidentale, eppure non sono chiusa in un blindato, non sto dietro il mirino di un mitra. Mi allontano senza salutare, come per dire “non c’ entro”, “non c’ero”. Non dico nemmeno “Khoda Hafez”, che Dio si ricordi di te, l’arrivederci degli afgani. Ma lei mi segue. Cammino lentamente per comunicare una tranquillità che non ho, lo faccio con passi lunghi, per seminarla. Ne esce una camminata abnorme. Scherzo con venditori ambulanti, mi infilo nella folla senza voltarmi e senza fretta apparente, per non far vedere che la mia è una fuga. Passo davanti agli ultimi Sikh della città che, con dadi e conchiglie, predicono il futuro alle musulmane al riparo di grandi ombrelli. Stavolta mi giro, lei non c’è. E Kabul ridiventa reale, con la sua puzza di fogna, le grida dei bambini di strada che danno manate sui blindati che passano come sul culo degli asini, il ronzio degli elicotteri d’assalto che volano così bassi che il soffio delle loro eliche spaventa i pappagalli verdi sugli eucalipti. Kabul, con i carillon dei gelatai ambulanti che strillano Per Elisa e Jingle Bells, vittoria sui divieti talebani contro la musica. Cerco di mimetizzarmi nel passo disinvolto delle donne afgane, un linguaggio mimetico del corpo che ho imparato ad assumere in fretta, anche per la mia incolumità. Ma stavolta la paura si è insinuata in me senza che me ne rendessi conto, è già diventata riflesso fisiologico. Bagnerò il mio letto quella notte, e da allora non riuscirò a dormire che a brevi intervalli. Ora riconosco i luoghi. Torno d’ istinto nel quartiere dei musicisti, dove ho il mio dentista privato. Un santuario con chiodi magici piantati sullo stipite della porta, ogni chiodo guarisce un dente. Poi trovo un barbiere con una foresta di capelli abramitica che mi invita a bere un tè e mi svela allegramente di avere interpretato Osama Bin Laden in un film. L’Afghanistanè così, dalla tragedia alla farsa nel giro di un’ora. Non so più dove ho fatto quel terribile incontro. Il mio sentimento per quella donna è un grumo fatto di pietà, condanna e paura. So che se la denunciassi non mi crederebbero, oppure partirebbe una rappresaglia di sangue. Sparisce l’ultimo raggio porpora sulle cime immacolate dell’Hindukush. Le luci tenui nelle case d’argilla si accendono sui colli che ora paiono il presepe di Betlemme. Un asino porta in salita una donna incinta con un’ombra accanto. Pare quella di Giuseppe, il falegname. E intanto la donna imbottita d’esplosivo, da qualche parte, si toglie la “cintura del martirio”, come la chiamano gli estremisti dell’Islam, e srotola per terra la trapunta colorata nella sua casa senza figli. Ma non dorme.
Ciao
 Leggo, in realtà con poco stupore, sul Corriere della Sera che Magdi Cristiano Allam ha deciso di abbandonare la Chiesa, ritenuta troppo morbida nei confronti dell’Islam. Su di lui avevo già scritto nel 2008 citando la Nostra Aetate. Con questo post desidero semplicemente avvisarlo di non avvicinarsi al “pericoloso” Buddhismo, in quanto il Dalai Lama afferma: “A coloro che affermano che il Dalai Lama sta perdendo il contatto con la realtà nel predicare questo ideale di amore incondizionato, rispondo di cominciare a sperimentarlo. Scopriranno che quando si varcano i confini di un ristretto interesse personale i nostri cuori si riempiono di forza. La pace e la gioia diventano i nostri compagni. Ogni barriera si rompe”. Resto tuttavia poco speranzoso, visto che Magdi Allam afferma: “Continuerò a credere nel Gesù che ho sempre amato e a identificarmi orgogliosamente con il cristianesimo come la civiltà che più di altre avvicina l’uomo al Dio che ha scelto di diventare uomo”. Visti i presupposti mi chiedo chissà quale Tenzin Gyatso sarebbe in grado di conoscere!
Leggo, in realtà con poco stupore, sul Corriere della Sera che Magdi Cristiano Allam ha deciso di abbandonare la Chiesa, ritenuta troppo morbida nei confronti dell’Islam. Su di lui avevo già scritto nel 2008 citando la Nostra Aetate. Con questo post desidero semplicemente avvisarlo di non avvicinarsi al “pericoloso” Buddhismo, in quanto il Dalai Lama afferma: “A coloro che affermano che il Dalai Lama sta perdendo il contatto con la realtà nel predicare questo ideale di amore incondizionato, rispondo di cominciare a sperimentarlo. Scopriranno che quando si varcano i confini di un ristretto interesse personale i nostri cuori si riempiono di forza. La pace e la gioia diventano i nostri compagni. Ogni barriera si rompe”. Resto tuttavia poco speranzoso, visto che Magdi Allam afferma: “Continuerò a credere nel Gesù che ho sempre amato e a identificarmi orgogliosamente con il cristianesimo come la civiltà che più di altre avvicina l’uomo al Dio che ha scelto di diventare uomo”. Visti i presupposti mi chiedo chissà quale Tenzin Gyatso sarebbe in grado di conoscere!
Islam: oltre il femminismo
Chi segue il blog in modo regolare sa che pubblico articoli lunghi solo se ritengo che ne valga la pena (in ogni caso parere personalissimo). Oggi, mentre navigavo su Sconfinare, il sito del giornale creato dagli studenti del SID (Scienze Internazionali e Diplomatiche) di Gorizia, mi sono imbattuto in questo bell’articolo di Elena Tuan sul ruolo moderno della donna nell’Islam.
 “C’è il femminismo, c’è l’Islam e c’è anche il femminismo islamico. Un movimento germogliato e influenzato sì dal pensiero di molti intellettuali e teorici, ma concretizzatosi spesso più semplicemente come manifestazione spontanea di protesta in seno alle disuguaglianze che ancora caratterizzano molte, sebbene diverse, realtà del mondo islamico. Tra le istanze che le femministe islamiche richiedono vi è l’uguaglianza di genere, la possibilità di partecipare alla riflessione teorica sui Libri Sacri della religione per dar vita a una vera e propria riforma di fondo del fiqh, la giurisprudenza islamica, metterne quindi in luce le interpretazioni maschiliste che hanno costretto per secoli la donna ad essere sottomessa all’uomo, all’interno della famiglia e della società. Dunque una discriminazione di genere che secondo molte attiviste, tra cui Fatima Mernissi, può essere ricondotta all’Islam, ma non al Corano.
“C’è il femminismo, c’è l’Islam e c’è anche il femminismo islamico. Un movimento germogliato e influenzato sì dal pensiero di molti intellettuali e teorici, ma concretizzatosi spesso più semplicemente come manifestazione spontanea di protesta in seno alle disuguaglianze che ancora caratterizzano molte, sebbene diverse, realtà del mondo islamico. Tra le istanze che le femministe islamiche richiedono vi è l’uguaglianza di genere, la possibilità di partecipare alla riflessione teorica sui Libri Sacri della religione per dar vita a una vera e propria riforma di fondo del fiqh, la giurisprudenza islamica, metterne quindi in luce le interpretazioni maschiliste che hanno costretto per secoli la donna ad essere sottomessa all’uomo, all’interno della famiglia e della società. Dunque una discriminazione di genere che secondo molte attiviste, tra cui Fatima Mernissi, può essere ricondotta all’Islam, ma non al Corano.
Nella formulazione di tali rivendicazioni confluiscono componenti sia esterne che interne: esterne, come l’ispirazione che hanno fornito i movimenti europei ed occidentali in genere, che si sono battuti per ottenere maggiore giustizia, libertà, democrazia; interne, come la maggiore consapevolezza acquisita dalle donne e l’esigenza, proveniente per lo più dal ceto medio e più istruito, di rivendicare i propri diritti, tra cui anche quello di occupare un ruolo attivo all’interno della società. Spesso infatti la società islamica si propone come patriarcale e maschilista, conseguenza di una netta divisione sessuale del lavoro, secondo cui alla donna apparterrebbe il ruolo di moglie e madre, quindi il dovere di occuparsi della casa e della crescita dei propri figli; mentre all’uomo, responsabile invece del sostentamento economico della famiglia, spetterebbe la sfera della società, dell’azione e della parola. Interessante è il fatto che nella maggior parte dei casi sono le stesse femministe islamiche a rifiutare la definizione di “femministe”, sia perché forte è la volontà di mantenere e affermare con orgoglio la propria identità culturale e religiosa (si intende rispetto a quella occidentale), sia perché identificarsi come “femministe” può essere causa di fraintendimenti in ambienti in cui queste tematiche talvolta vengono ancora percepite come tentativi di soverchiare l’ordine e i valori della tradizione. Anche per questo motivo, diversi intellettuali e docenti, tra cui anche donne come Haideh Moghissi o Shahrzad Mojab, considerano l’espressione “femminismo islamico” un ossimoro e guardano con freddo disincanto a tale movimento, ai loro occhi una contraddizione che tenta di indossare una maschera che non gli appartiene né per cultura né per tradizione. Un modo, quello di definirsi islamico, per evitare la censura o, nei casi in cui l’Islam politico non ammetta pluralismo culturale, la soppressione.
Nonostante ciò, la determinazione e il coraggio con cui tali donne lottano per ottenere maggiore uguaglianza non perde vigore. La forza del femminismo islamico sembra essere scaturita in particolar modo nella seconda metà dello scorso secolo, quando il progetto islamista di tornare alla piena implementazione della shari’a, la legge sacra islamica, ha spinto molte donne all’attivismo. L’avvento dell’Islam politico, a partire dalla rivoluzione del 1979 in Iran, è stato il “casus belli” per le aspirazioni femministe, perché da un lato ha reso evidente la discrepanza tra i valori coranici e le politiche patriarcali effettuate in nome della religione islamica, dall’altro ha donato alle stesse donne il linguaggio e la legittimità di cui avevano bisogno per formulare domanda per maggiore uguaglianza attraverso un uso appropriato delle fonti.
E’ così che le donne hanno iniziato a sostenere la sostanziale differenza tra shari’a, legge divina e non soggetta ad alcun cambiamento, e fiqh, legge determinata storicamente dall’uomo, che non deve essere santificabile, ma passabile di correzioni e modifiche. Ad aggiungersi a ciò un’interpretazione/traduzione maschilista e patriarcale dei Testi Sacri, che spesso ha portato l’uomo a formulare ex novo certi hadith (detti e usanze che la tradizione riconduce al Profeta Muhammad), che avrebbero favorito il mantenimento dell’egemonia maschile e la subordinazione del genere femminile. Per l’anima teologica del femminismo islamico è quindi necessaria una reinterpretazione dei Testi Sacri per ottenere la definitiva separazione degli stessi dal patriarcato che per secoli ne ha mantenuto il monopolio.
Il femminismo islamico ha anche una seconda anima, quella movimentista, che spesso si concreta nell’adesione a ONG, associazioni, siti Internet che operano a diversi livelli per l’affermazione dei diritti femminili. Per citarne alcune:
-
Sisters in Islam, un’ organizzazione malese che opera a livello internazionale e che ha esordito ufficialmente nel 1990 con una campagna contro la poligamia, seguita da una contro la flagellazione, l’ottenimento di maggiore protezione e diritti per combattere la violenza esercitata sulle donne;
-
Musawah, Movimento globale per l’uguaglianza e la giustizia nella famiglia musulmana, punto di riferimento per le operatrici di settore a livello internazionale e interlocutore dell’ONU nel programma di accertamenti periodici volti a controllare che i Paesi firmatari del CEDAW, Convenzione per l’Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le donne, adottata dal Consiglio delle Nazioni Unite nel 1979, rispettino la convenzione;
-
Kamarah, Donne musulmane avvocato per i diritti umani, che punta soprattutto alla necessità di informare in materia di diritto islamico le donne, garantendo loro la capacità di sviluppare con efficacia il loro discorso giuridico in seno alle comunità da cui provengono;
-
Akder, Organizzazione per i Diritti delle Donne contro la Discriminazione, nata nel 1999 per iniziativa di un gruppo di professioniste e studentesse turche cacciate rispettivamente dai propri posti di lavoro ed università perché avevano rifiutato di togliersi il velo, che opera facendo pressioni sui parlamentari per migliori condizioni legislative e riforme, assiste legalmente le vittime di violenza e preme sui consigli comunali per l’assegnazione di case protette per le donne vittime di abusi e per i loro figli. Secondo recenti statistiche infatti almeno una donna su tre in Turchia ha subito molestie sessuali o forme di violenza nel corso della propria vita.
Il fenomeno della globalizzazione e l’intensificazione dell’uso delle comunicazioni di massa ha contribuito all’aumento della cooperazione e del livello di coordinamento sia a livello locale che a livello internazionale tra le varie associazioni, che non raramente organizzano meeting e riunioni per eventuali aggiornamenti o ratifiche, o più semplicemente per valorizzare la diffusione e riaffermare quegli stessi valori di cui si fanno portatrici. Purtroppo, uno tra i più rilevanti problemi delle organizzazioni femministe islamiche sono i finanziamenti, che raramente provengono dagli Stati in cui tali movimenti hanno origine, ma piuttosto da organizzazioni, gruppi e privati di Stati occidentali. La Fondazione Studio e Ricerca delle Donne, una delle ONG più affermate in Iran, è ad esempio finanziata in parte dal Ministero dell’Istruzione ed è stata tra le prime a sponsorizzare la pubblicazione di uno studio del Corano in prospettiva femminile redatto da una donna; la sopra citata Kamarah può contare su invidiabili risorse umane e finanziarie, in minima parte riconducibili al mondo musulmano e per lo più appartenenti invece al mondo occidentale. Basti pensare che nella schiera dei suoi finanziatori si trova anche Bill Gates.
Grazie a una maggiore consapevolezza, un grado migliore d’istruzione, una conoscenza più approfondita dei Testi Sacri e grazie anche al proprio carisma, oggi sempre più donne islamiche si stanno conquistando il tanto agognato ruolo attivo all’interno della società. In ambito religioso possono essere istruttrici all’interno di moschee e madrasa, interpreti della parola islamica, lettrici di preghiere, capi di moschee femminili; in ambito sociale possono operare in centri e reti associative, reti televisive, giornali e riviste, svolgere le professioni di medico, avvocato, autista di taxi ed autobus, membro del Parlamento. Oggi il 30% delle cariche parlamentari in Iran è riservato alle donne, purtroppo non tutti i seggi vengono occupati perché vi è ancora diffidenza, anche da parte delle donne stesse, a votare le proprie compagne sia per il timore delle autorità al potere sia perché non è ancora considerato “normale” pensare alle donne in termini di rappresentanza politica ed istituzionale. Anche nell’ambito dello Sport molte donne hanno lottato per ottenere maggiori libertà e diritti, tra queste spicca maggiormente l’attivista Faezeh Hashemi Rafsanjani, che ha fondato nel 1991 la Federazione dei Paesi Islamici per la solidarietà femminile nello Sport. Tale associazione ha dotato le donne di maggiori libertà e ha permesso successivamente l’organizzazione di olimpiadi speciali per le sole atlete, un traguardo notevole se si considera che con l’affermarsi del fondamentalismo islamico alle donne fu vietato anche il semplice andare in bicicletta. Alcune attiviste però sostengono che i risultati raggiunti, anche se notevoli, non siano sufficienti, poiché se da una parte le donne stanno conquistando sempre più spazio e garanzie in ambito lavorativo, sociale e politico, dall’altra le leggi in tema di diritto di famiglia sono ancora troppo deboli e ciò che non cambia è la situazione di oppressione e sfavore che esse vivono all’interno della propria casa, dove a volte subiscono violenza fisica, stupro coniugale, o nel peggiore dei casi sono vittime del delitto d’onore, ancora molto diffuso. Vi sono Paesi come la Turchia, che già da un decennio ha provveduto a varare leggi in cui si afferma l’equiparazione tra i coniugi, l’uguaglianza di genere in termini legislativi, la criminalizzazione dello stupro coniugale e vi sono Paesi come l’Arabia Saudita o gli Emirati Arabi, in cui il codice di famiglia e la stessa shari’a continuano a essere interpretati alla lettera e in questo modo la discriminazione e la disuguaglianza di genere riaffermate e consolidate all’interno della società.
Come afferma German Martin Munoz, docente all’Università di Madrid, il mondo occidentale risulta riguardo queste tematiche particolarmente influenzabile ed influenzato dai massmedia, che hanno il ruolo non solo di fornire l’informazione su determinati fenomeni, fatti ed eventi, ma anche di perpetuare gli schemi culturali e gli stereotipi con cui questi vengono rappresentati. E’ così che ai nostri occhi spesso, o meglio, a prescindere, la società e la cultura araba vengono definite come immobili e conservatrici, determinate più dalla religione che dai cambiamenti sociali, economici, politici in atto. Al contrario la nostra società e la nostra cultura vengono considerate intrinsecamente buone e giuste, per questo migliori. Un atteggiamento, il nostro, riconducibile allo scheletro di un passato modernista e a un presente cosmopolita non privo di venature tendenzialmente etnocentriche. Sotto molti aspetti, non lo si può negare, la nostra società è più equa ed evoluta in numerosi ambiti, a partire da quello legislativo e politico, ma ciò non significa che le nostre democrazie siano sempre efficienti, che le nostre leggi vengano sempre rispettate, o che si sia raggiunta effettivamente l’uguaglianza di genere. Agli occhi di noi occidentali, immersi in una società secolarizzata dove i valori che vengono esaltati e rispettati sono spesso l’individualismo, la competizione, il successo, l’apparenza, appare probabilmente incomprensibile e arretrata una società in cui i valori più importanti sono quelli pronunciati e dettati dalla religione. Così il velo che indossano le musulmane per noi non è e non può essere simbolo della volontà di manifestare un’integrità culturale e religiosa riconducibile a una tradizione fortemente sentita e condivisa (può darsi anche imposta), ma solamente una limitazione ingiusta e un mancato raggiungimento dei diritti fondamentali dell’individuo. La donna velata è vittima del fondamentalismo, ma è anche vittima di un’incomprensione culturale occidentale che non accetta e non riconosce di poter compiere valutazioni errate. L’Occidente vede la donna islamica come uno strumento nelle mani degli uomini e della religione, priva delle proprie libertà e ancorata a degli schemi culturali discriminanti, tanto quanto vuole far finta di non vedere la “velina occidentale” come il proprio oggetto di desiderio e bellezza, ancorata purtroppo anch’essa a degli schemi culturali analogamente discriminanti.”
Le lacrime di Timbuctu
Pubblico la prima parte di un articolo di Rainews24 pensando a quanti danni possono causare le religioni che diventano assolutismi radicali e ideologie cieche e univoche.
“Non sono valsi a nulla gli appelli agli jihadisti che occupavano Timbuctu affinché non  scatenassero la loro rabbia per l’imminente sconfitta contro il patrimonio culturale e storico della ‘porta del Sahara’: prima di lasciare la città – leggenda – da oggi ormai completamente controllata da francesi e maliani – hanno bruciato un edificio che custodiva migliaia di rari manoscritti, andati irrimediabilmente distrutti.
scatenassero la loro rabbia per l’imminente sconfitta contro il patrimonio culturale e storico della ‘porta del Sahara’: prima di lasciare la città – leggenda – da oggi ormai completamente controllata da francesi e maliani – hanno bruciato un edificio che custodiva migliaia di rari manoscritti, andati irrimediabilmente distrutti.
Un atto di violenza gratuita che era però era temuto, perché proprio a Timbuctu gli jihadisti hanno dato prova di volere cancellare quello che per loro è un modo errato di onorare Allah e le parole del Profeta. Da quando conquistarono la città, hanno fatto a pezzi le molte statue di Alfarouk, il mitico angelo protettore della città, e poi gran parte dei mausolei di sabbia e legno che ornavano, come pietre preziose, la città per ricordare i suoi “333 santi”, come vengono chiamati religiosi e studiosi musulmani che scelsero per i loro ultimi giorni questo avamposto della cultura e dell’Islam più tollerante.
Timbuctu è stata da sempre una città votata alla cultura (nel Sedicesimo secolo ospitava 2500 studenti che oggi potremmo definire universitari, su una popolazione di 100 mila persone) e la raccolta e la cura dei manoscritti antichi è stato il tratto comune alle famiglie più abbienti, che per generazioni li hanno acquistati e custoditi gelosamente. Ed il paradosso è che ad andare bruciati, nell’incendio appiccato dagli jihadisti, sono stati quei manoscritti ceduti da alcune delle famiglie al centro Ahmed-Baba per essere esposti e studiati. Manoscritti non solo di carattere religioso, ma anche scientifico (molti i trattati di astronomia) in lingua araba, ma anche songhai e tamasheq…”
Quanti Islam?
Riporto due notizie che sembrano provenire da pianeti lontanissimi.
Da La Stampa
“Dopo diciannove ore consecutive di seduta, iniziata ieri a mezzogiorno e protrattasi per l’intera notte, l’Assemblea Costituente egiziana dominata dai Fratelli Musulmani e dai salafiti ha adottato la bozza della nuova Costituzione, che dovrebbe rimodellare le istituzioni del Paese in modo che riflettano i cambiamenti intervenuti nell’era post-Hosni Mubarak, grazie all’avvento anche nel Paese nord-africano della Primavera Araba: nell’annunciare l’approvazione dei 234 articoli del provvedimento il presidente dell’organismo, Hossam el-Ghiriani, ha precisato che è avvenuta all’unanimità, malgrado i lavori fossero stati boicottati dalle forze di opposizione laiche e liberali, oltre che dalla minoranza copta, soprattutto a causa del mantenimento della contestata norma in base alla quale la sharia, la legge coranica, costituisce la principale fonte giuridica.
 Ora il testo sarà trasmesso al neo-presidente della Repubblica, l’islamista Mohamed Morsi, affinché lo ratifichi entro domani. Il documento sarà poi sottoposto a referendum popolare confermativo nel giro di due settimane, vale a dire per la metà di dicembre. In proposito Morsi, intervenendo a tarda sera alla televisione nazionale, ha puntualizzato che i poteri quasi illimitati che lui stesso si era attribuito il 22 novembre con un contestatissimo decreto, non a caso definito ufficialmente “Dichiarazione Costituzionale”, sono legati esclusivamente a una «fase eccezionale», e che cesseranno di essere validi «non appena il popolo avrà votato sulla Costituzione», perché nell’Egitto contemporaneo «non c’è alcuno spazio per la dittatura»: con buona pace dei tanti che vedono invece nella mossa del capo dello Stato un ritorno all’autoritarismo di Mubarak. Quest’ultimo peraltro rimase al potere per quasi tre decenni, mentre la Costituzione testé approvata prevede un massimo di due mandati presidenziali ciascuno, per un totale di otto anni, oltre a imporre una serie di meccanismi di controllo sulle prerogative delle Forze Armate; sebbene, anche in tal caso, per i contestatori si tratti di misure più che altro di mera facciata.”
Ora il testo sarà trasmesso al neo-presidente della Repubblica, l’islamista Mohamed Morsi, affinché lo ratifichi entro domani. Il documento sarà poi sottoposto a referendum popolare confermativo nel giro di due settimane, vale a dire per la metà di dicembre. In proposito Morsi, intervenendo a tarda sera alla televisione nazionale, ha puntualizzato che i poteri quasi illimitati che lui stesso si era attribuito il 22 novembre con un contestatissimo decreto, non a caso definito ufficialmente “Dichiarazione Costituzionale”, sono legati esclusivamente a una «fase eccezionale», e che cesseranno di essere validi «non appena il popolo avrà votato sulla Costituzione», perché nell’Egitto contemporaneo «non c’è alcuno spazio per la dittatura»: con buona pace dei tanti che vedono invece nella mossa del capo dello Stato un ritorno all’autoritarismo di Mubarak. Quest’ultimo peraltro rimase al potere per quasi tre decenni, mentre la Costituzione testé approvata prevede un massimo di due mandati presidenziali ciascuno, per un totale di otto anni, oltre a imporre una serie di meccanismi di controllo sulle prerogative delle Forze Armate; sebbene, anche in tal caso, per i contestatori si tratti di misure più che altro di mera facciata.”
“«Le Coran ne fait aucune référence explicite à l’homosexualité» : c’est fort de cet argument que Ludovic-Mohamed Zahed, a décidé d’ouvrir, vendredi 30 novembre, une mosquée dite «inclusive» : les femmes, voilées ou non, ne seront pas séparées des hommes; des couples homosexuels pourront se marier religieusement… «Il s’agit d’ouvrir un lieu de culte où tou-tes seraient accueilli-es comme des frères et des sœurs humains avant tout, quels que soient leur sexe, leur identité de genre ou leur ethnicité», écrit-t-il sur LeNouvelObs.com.
Selon lui, le mot arabe qui désigne l’époux ou l’épouse dans le Coran, «zawjan», est n’est ni féminin ni masculin, deux hommes ou deux femmes pourraient donc se marier. D’ailleurs, les musulmans ne considèreraient pas le mariage comme un sacrement, comme les catholique, mais simplement «un contrat social entre deux individus consentants, devant deux témoins au moins, célébré en communauté», celles et ceux qui les reconnaissent en tant que couple. Enfin, tranche le jeune homme, «l’interprétation univoque et dogmatique de certains versets du Coran [qui légitimeraient l’homophobie et la misogynie] ne fait plus l’unanimité.»
Cette argumentation peut sembler partiale voire inexacte: de nombreux hadiths — des paroles attribuées au prophète Mahomet — paraissent condamner l’homosexualité; le Coran comporte un récit analogue au mythe de Sodome et Gomorrhe, etc… Mais pour l’imam de Bordeaux, Tareq Oubroux, nulle interprétation ne fait autorité. «Aucun texte univoque, authentique, ne fait mention d’une quelconque sanction contre les homosexuels, affirme-t-il avant de nuancer. Éthiquement parlant, le Coran n’admet pas l’homosexualité. Mais le passage de cette condamnation morale à une condamnation juridique n’existe pas.»
Quoi qu’il en soit, l’islam sunnite ne reconnaissant aucun clergé, Ludovic-Mohamed Zahed peut tout à fait ouvrir une mosquée sans l’aval du Conseil français du culte musulman ou d’un autre autorité. Des établissements similaires existent d’ailleurs aux Etats-Unis ou au Canada. La semaine dernière, selon le quotidien Métro, une imam de la mosquée de Los Angeles, Ani Zonneveld, devait à Paris pour célébrer le mariage de deux femmes — «deux Françaises de confession musulmane», précisait Ludovic-Mohamed Zahed. Cette union était organisée à l’initiative de la Confederation of Associations LGBT, European or Muslims (Calem) qui regroupe des musulmans du monde entier.”
Bloody sunday nigeriana
Ne avevamo parlato in classe a fine settembre. Avevo detto di tenere d’occhio la situazione della Nigeria per capire se si trattasse di proteste legate al filmato contro Maometto o di una ripresa delle violenze di qualche mese fa. Mi sa che si sta andando verso la seconda ipotesi… L’articolo è di Massimo A. Alberizzi.
“Ennesima domenica di sangue in Nigeria: ieri di prima mattina un terrorista suicida ha fatto esplodere la sua auto imbottita di dinamite nella chiesa cattolica di Santa Rita in Ungwan Yero a Kaduna, nel nord del Paese. Subito dopo è scattata la vendetta dei cristiani che hanno colpito case e negozi dei musulmani, ammazzando a sangue freddo alcuni fedeli di Allah. Un funzionario del NEMA (National Emergency Management Authority) ha confermato che i morti “sono almeno 10” ma sul numero di feriti non ha voluto essere preciso: “Decine e decine, almeno un centinaio”. Tra gli altri, in condizioni critiche, il sacerdote che stava officiando la messa. Subito dopo l’attacco suicida è partita la rappresaglia dei cristiani furibondi. Armati di bastoni e machete bande di giovani hanno assalito i musulmani e i loro beni. Il guidatore di un mototaxi, creduto seguace dell’islam, è stato bloccato dalla folla inferocita: l’uomo prima è stato picchiato, poi gli è stata rovesciata addosso la sua moto con il serbatoio aperto. Una volta ben inzuppato di benzina, gli assalitori gli hanno dato fuoco. Non è stato l’unico a essere stato ucciso per vendetta, ma la polizia non ha voluto fornire altri dettagli.
Secondo padre Anthony Zaka, il vicedirettore dell’ufficio stampa dell’arcidiocesi di Kaduna, il terrorista che ha devastato la chiesa doveva conoscere molto bene il posto. Probabilmente l’aveva visitato più volte in precedenza. Aveva scelto un angolo particolare dove immolarsi, per poter causare il maggior numero di vittime. Le chiese in Africa sono spesso in spazi aperti, in grandi parchi dove viene sistemato un altare. Così è quella di Kaduna, dedicata a Santa Rita. L’attentatore suicida ha superato il muro di cinta ed è entrato del giardino. Ha poi parcheggiato in una zona che si sarebbe riempita di folla da lì a poco. E’ rimasto seduto in auto finché la gente, per seguire la messa, non ha occupato tutto lo spazio disponibile, e solo allora si è fatto saltare in aria. “Cinque persone sono morte sul colpo – ha spiegato padre Zaka – e altre cinque subito dopo in ospedale per le ferite. Temo che il bilancio potrebbe aumentare perché ci sono parecchi ricoverati in fin di vita”. Nessuno ha finora rivendicato l’attacco, ma fonti diplomatiche non hanno dubbi: “E’ da attribuire a Boko Haram”, il gruppo islamista radicale che combatte il governo centrale del presidente Goodluck Jonathan. Ma è sbagliato ridurre la violenza che sta sconvolgendo la Nigeria a una semplice guerra interreligiosa tra cristiani e musulmani. La crisi ha radici più profonde: corruzione, povertà, disoccupazione degrado anche ecologico. La Nigeria è ricchissima di petrolio (ottavo produttore al mondo e primo africano) ma i proventi restano in mano a poche famiglie di miliardari. La scoperta di nuovi giacimenti a nord, nel bacino del lago Ciad ha moltiplicato i problemi. Sono troppe le mani rapaci che vogliono impadronirsi di quella fortuna. Leader senza scrupoli vogliono destabilizzare il nord. Plagiano i giovani, cui promettono lotta alla corruzione e alla miseria, opportunità di lavoro per tutti e salvaguardia della natura e dell’ambiente, e li convincono a combattere la guerra santa.”


