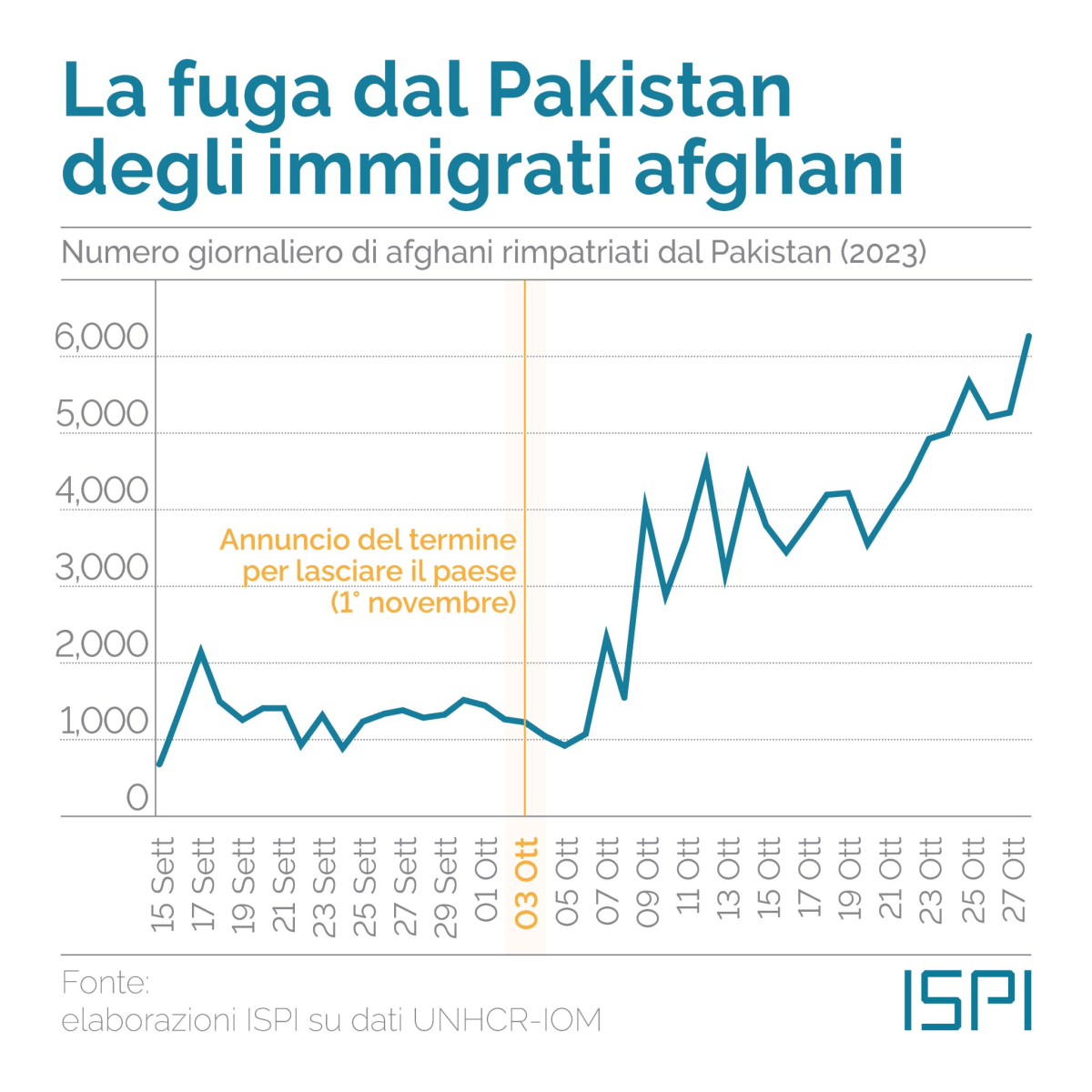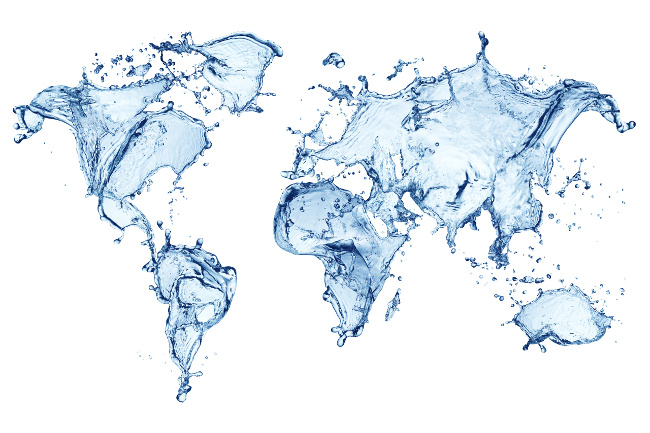Il 4 ottobre è stata firmata “Dilexi te” la prima esortazione apostolica da Robert Francis Prevost, papa Leone XIV. Prendo la notizia e un articolo di presentazione da Vatican News. Il testo integrale si può trovare qui, sul sito della Santa Sede.
“Dilexi te, “Ti ho amato”. L’amore di Cristo che si fa carne nell’amore ai poveri, inteso come cura dei malati; lotta alle schiavitù; difesa delle donne che soffrono esclusione e violenza; diritto all’istruzione; accompagnamento ai migranti; elemosina che “è giustizia ristabilita, non un gesto di paternalismo”; equità, la cui mancanza è “radice di tutti i mali sociali”. Leone XIV firma la sua prima esortazione apostolica, Dilexi te, testo in 121 punti che sgorga dal Vangelo del Figlio di Dio che si è fatto povero sin dal suo ingresso nel mondo e che rilancia il Magistero della Chiesa sui poveri negli ultimi centocinquant’anni. “Una vera miniera di insegnamenti”.
Sul solco dei predecessori
Il Pontefice agostiniano con questo documento firmato il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, il cui titolo è tratto dal Libro dell’Apocalisse (Ap 3,9), si inserisce così sul solco dei predecessori: Giovanni XXIII con l’appello ai Paesi ricchi nella Mater et Magistra a non rimanere indifferenti davanti ai Paesi oppressi da fame e miseria (83); Paolo VI, la Populorum progressio e l’intervento all’Onu “come avvocato dei popoli poveri”; Giovanni Paolo II che consolidò dottrinalmente “il rapporto preferenziale della Chiesa con i poveri”; Benedetto XVI e la Caritas in Veritate con la sua lettura “più marcatamente politica” delle crisi del terzo millennio. Infine, Francesco che della cura “per i poveri” e “con i poveri” ha fatto uno dei capisaldi del pontificato.
Un lavoro iniziato da Francesco e rilanciato da Leone
Proprio Francesco aveva iniziato nei mesi prima della morte il lavoro sull’esortazione apostolica.
Come con la Lumen Fidei di Benedetto XVI, nel 2013 raccolta da Jorge Mario Bergoglio, anche questa volta è il successore a completare l’opera che rappresenta una prosecuzione della Dilexit Nos, l’ultima enciclica del Papa argentino sul Cuore di Gesù. Perché è forte il “nesso” tra amore di Dio e amore per i poveri: tramite loro Dio “ha ancora qualcosa da dirci”, afferma Papa Leone. E richiama il tema della “opzione preferenziale” per i poveri, espressione nata in America Latina (16) non per indicare “un esclusivismo o una discriminazione verso altri gruppi”, bensì “l’agire di Dio” che si muove a compassione per la debolezza dell’umanità.
Sul volto ferito dei poveri troviamo impressa la sofferenza degli innocenti e, perciò, la stessa sofferenza del Cristo (9).
I “volti” della povertà
Numerosi gli spunti per la riflessione, numerose le spinte all’azione nella esortazione di Robert Francis Prevost, in cui vengono analizzati i “volti” della povertà. La povertà di “chi non ha mezzi di sostentamento materiale”, di “chi è emarginato socialmente e non ha strumenti per dare voce alla propria dignità e alle proprie capacità”; la povertà “morale”, “spirituale”, “culturale”; la povertà “di chi non ha diritti, non ha spazio, non ha libertà” (9).
Nuove povertà e mancanza di equità
Di fronte a questo scenario, il Papa giudica “insufficiente” l’impegno per rimuovere le cause strutturali della povertà in società segnate “da numerose disuguaglianze”, dall’emergere di nuove povertà “più sottili e pericolose” (10), da regole economiche che hanno fatto aumentare la ricchezza, “ma senza equità”.
La mancanza di equità è la radice dei mali sociali (94).
La dittatura di un’economia che uccide
“Quando si dice che il mondo moderno ha ridotto la povertà, lo si fa misurandola con criteri di altre epoche non paragonabili con la realtà attuale”, afferma Leone XIV (13). Da questo punto di vista, saluta “con favore” il fatto che “le Nazioni Unite abbiano posto la sconfitta della povertà come uno degli obiettivi del Millennio”. La strada tuttavia è lunga, specie in un’epoca in cui continua a vigere la “dittatura di un’economia che uccide”, in cui i guadagni di pochi “crescono esponenzialmente” mentre quelli della maggioranza sono “sempre più distanti dal benessere di questa minoranza felice” e in cui sono diffuse le “ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria” (92).
Cultura dello scarto, libertà del mercato, pastorale delle élite
È segno, tutto questo, che ancora persiste – “a volte ben mascherata” – una cultura dello scarto che “tollera con indifferenza che milioni di persone muoiano di fame o sopravvivano in condizioni indegne dell’essere umano” (11). Il Papa stigmatizza allora i “criteri pseudoscientifici” per cui sarà “la libertà del mercato” a portare alla “soluzione” del problema povertà, come pure quella “pastorale delle cosiddette élite”, secondo la quale “al posto di perdere tempo con i poveri, è meglio prendersi cura dei ricchi, dei potenti e dei professionisti” (114).
Di fatto, i diritti umani non sono uguali per tutti (94).
Trasformare la mentalità
Ciò che invoca il Papa è, dunque, una “trasformazione di mentalità”, affrancandosi anzitutto dalla “illusione di una felicità che deriva da una vita agiata”. Cosa che spinge molte persone a una visione dell’esistenza imperniata su ricchezza e successo “a tutti i costi”, anche a scapito degli altri e attraverso “sistemi politico-economico ingiusti” (11).
La dignità di ogni persona umana dev’essere rispettata adesso, non domani (92).
In ogni migrante respinto c’è Cristo che bussa
Ampio lo spazio che Leone XIV dedica poi al tema delle migrazioni. A corredare le sue parole, l’immagine del piccolo Alan Kurdi, il bimbo siriano di 3 anni divenuto nel 2015 simbolo della crisi europea dei migranti con la foto del corpicino senza vita su una spiaggia. “Purtroppo, a parte una qualche momentanea emozione, fatti simili stanno diventando sempre più irrilevanti come notizie marginali” (11), constata il Pontefice.
Al contempo ricorda l’opera secolare della Chiesa verso quanti sono costretti ad abbandonare le proprie terre, espressa in centri accoglienza, missioni di frontiera, sforzi di Caritas Internazionale e altre istituzioni (75).
La Chiesa, come una madre, cammina con coloro che camminano. Dove il mondo vede minacce, lei vede figli; dove si costruiscono muri, lei costruisce ponti. Sa che il suo annuncio del Vangelo è credibile solo quando si traduce in gesti di vicinanza e accoglienza. E sa che in ogni migrante respinto è Cristo stesso che bussa alle porte della comunità (75).
Sempre in tema migrazioni, Robert Prevost fa suoi i famosi “quattro verbi” di Papa Francesco: “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare”. E di Papa Francesco mutua pure la definizione dei poveri non solo oggetto della nostra compassione ma “maestri del Vangelo”.
Servire i poveri non è un gesto da fare “dall’alto verso il basso”, ma un incontro tra pari… La Chiesa, quindi, quando si china a prendersi cura dei poveri, assume la sua postura più elevata (79).
Le donne vittime di violenza ed esclusione
Il Successore di Pietro guarda poi all’attualità segnata da migliaia di persone che ogni giorno muoiono “per cause legate alla malnutrizione” (12). “Doppiamente povere”, aggiunge, sono “le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti” (12).
“I poveri non ci sono per caso…”
Papa Leone XIV traccia una approfondita riflessione sulle cause stesse della povertà: “I poveri non ci sono per caso o per un cieco e amaro destino. Tanto meno la povertà, per la maggior parte di costoro, è una scelta. Eppure, c’è ancora qualcuno che osa affermarlo, mostrando cecità e crudeltà”, sottolinea (14). “Ovviamente tra i poveri c’è pure chi non vuole lavorare”, ma ci sono anche tanti uomini e donne che magari raccolgono cartoni dalla mattina alla sera giusto per “sopravvivere” e mai per “migliorare” la vita. Insomma, si legge in uno dei punti focali di Dilexi te, non si può dire “che la maggior parte dei poveri lo sono perché non hanno acquistato dei meriti, secondo quella falsa visione della meritocrazia dove sembra che abbiano meriti solo quelli che hanno avuto successo nella vita” (14).
Ideologie e orientamenti politici
Talvolta, osserva Papa Leone, sono gli stessi cristiani a lasciarsi “contagiare da atteggiamenti segnati da ideologie mondane o da orientamenti politici ed economici che portano a ingiuste generalizzazioni e a conclusioni fuorvianti”.
C’è chi continua a dire: “Il nostro compito è di pregare e di insegnare la vera dottrina”. Ma, svincolando questo aspetto religioso dalla promozione integrale, aggiungono che solo il governo dovrebbe prendersi cura di loro, oppure che sarebbe meglio lasciarli nella miseria, insegnando loro piuttosto a lavorare (114)
L’elemosina spesso disdegnata
Sintomo di questa mentalità è il fatto che l’esercizio della carità risulti talvolta “disprezzato o ridicolizzato, come se si trattasse della fissazione di alcuni e non del nucleo incandescente della missione ecclesiale” (15). A lungo il Papa si sofferma sulla elemosina, raramente praticata e spesso disdegnata (115).
Come cristiani non rinunciamo all’elemosina. Un gesto che si può fare in diverse maniere, e che possiamo tentare di fare nel modo più efficace, ma dobbiamo farlo. E sempre sarà meglio fare qualcosa che non fare niente. In ogni caso ci toccherà il cuore. Non sarà la soluzione alla povertà nel mondo, che va cercata con intelligenza, tenacia, impegno sociale. Ma noi abbiamo bisogno di esercitarci nell’elemosina per toccare la carne sofferente dei poveri (119).
Indifferenza da parte dei cristiani
Sulla stessa scia, il Papa denota “la carenza o addirittura l’assenza dell’impegno” per la difesa e promozione dei più svantaggiati in alcuni gruppi cristiani (112). Se una comunità della Chiesa non coopera per l’inclusione di tutti, ammonisce, “correrà anche il rischio della dissoluzione, benché parli di temi sociali o critichi i governi. Facilmente finirà per essere sommersa dalla mondanità spirituale, dissimulata con pratiche religiose, con riunioni infeconde o con discorsi vuoti” (113).
Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri (36)
La testimonianza di santi, beati e ordini religiosi
A controbilanciare questo atteggiamento di indifferenza, c’è un mondo di santi, beati, missionari che, nei secoli, hanno incarnato l’immagine di “una Chiesa povera per i poveri” (35). Da Francesco d’Assisi e il suo gesto di abbracciare un lebbroso (7) a Madre Teresa, icona universale della carità dedita ai moribondi dell’India “con una tenerezza che era preghiera” (77). E ancora San Lorenzo, San Giustino, Sant’Ambrogio, San Giovanni Crisostomo, il suo Sant’Agostino che affermava: “Chi dice di amare Dio e non ha compassione per i bisognosi mente” (45).
Leone ricorda ancora l’opera dei Camilliani per i malati (49), delle congregazioni femminili in ospedali e case di cura (51). Ricorda l’accoglienza nei monasteri benedettini a vedove, bambini abbandonati, pellegrini e mendicanti (55). E ricorda pure francescani, domenicani, carmelitani, agostiniani che hanno avviato “una rivoluzione evangelica” attraverso uno “stile di vita semplice e povero” (63), insieme a trinitari e mercedari che, battendosi per la liberazione dei prigionieri, hanno espresso l’amore di “un Dio che libera non solo dalla schiavitù spirituale, ma anche dall’oppressione concreta” (60).
La tradizione di questi Ordini non si è conclusa. Al contrario, ha ispirato nuove forme di azione di fronte alle schiavitù moderne: il traffico di esseri umani, il lavoro forzato, lo sfruttamento sessuale, le diverse forme di dipendenza. La carità cristiana, quando si incarna, diventa liberatrice (61).
Il diritto all’educazione
Il Pontefice richiama inoltre l’esempio di San Giuseppe Calasanzio, che diede vita alla prima scuola popolare gratuita d’Europa (69), per rimarcare l’importanza dell’educazione dei poveri: “Non è un favore, ma un dovere”.
I piccoli hanno diritto alla conoscenza, come requisito fondamentale per il riconoscimento della dignità umana (72).
La lotta dei movimenti popolari
Nell’esortazione il Papa fa cenno pure alla lotta contro gli “effetti distruttori dell’impero del denaro” da parte dei movimenti popolari, guidati da leader “tante volte sospettati e addirittura perseguitati” (80). Essi, scrive, “invitano a superare quell’idea delle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei poveri” (81).
Una voce che svegli e denunci
Nelle ultime pagine del documento, Leone XIV fa appello all’intero Popolo di Dio a “far sentire, pur in modi diversi, una voce che svegli, che denunci, che si esponga anche a costo di sembrare degli stupidi”.
Le strutture d’ingiustizia vanno riconosciute e distrutte con la forza del bene, attraverso il cambiamento delle mentalità ma anche, con l’aiuto delle scienze e della tecnica, attraverso lo sviluppo di politiche efficaci nella trasformazione della società (97).
I poveri, non un problema sociale ma il centro della Chiesa
È necessario che “tutti ci lasciamo evangelizzare dai poveri”, esorta il Papa (102). “Il cristiano non può considerare i poveri solo come un problema sociale: essi sono una questione familiare. Sono dei nostri”. Pertanto “il rapporto con loro non può essere ridotto a un’attività o a un ufficio della Chiesa” (104).
I poveri sono nel centro stesso della Chiesa (111).”