 Pubblico un’intervista molto interessante pubblicata di Fabio Chiusi su Weird. La leggeremo in prima a proposito delle relazioni ai tempi della rete.
Pubblico un’intervista molto interessante pubblicata di Fabio Chiusi su Weird. La leggeremo in prima a proposito delle relazioni ai tempi della rete.
“È terribilmente difficile parlare della realtà sociale dei “ragazzi connessi” senza cadere in stereotipi e banalizzazioni. Con il suo volume ‘It’s Complicated. The Social Lives of Networked Teens’, come raccontato nella recensione di Wired.it, la ricercatrice danah boyd – rigorosamente minuscolo – ci è riuscita egregiamente. E tuttavia nel libro, è naturale, manca uno sguardo su come i dati e gli argomenti da lei prodotti si traducano nel contesto italiano. boyd lo spiega durante una conversazione via Skype, a partire dal nucleo centrale della sua riflessione, e dalle sue conseguenze.
boyd, perché è così complicato rendersi conto che le questioni di cui parla nel libro sono complicate?
Uno dei problemi è che le persone si abbandonano agli estremismi molto facilmente, specie quando c’è di mezzo la tecnologia: l’idea, sentita negli ultimi 30 anni, che si tratti di una cosa meravigliosa che risolverà tutti i problemi o che all’opposto li causa tutti. Il risultato è che le persone che le usano non riescono a comprendere la complessità che le nuove tecnologie hanno reso visibile. Mettiamo per un attimo da parte le questioni riguardanti gli adolescenti, e pensiamo per esempio alla retorica sulle rivoluzioni.
O sulla democrazia digitale. È lo stesso: molte petizioni di principio sugli effetti di Internet sulla partecipazione e le forme democratiche, molte meno analisi concrete su come singoli strumenti abbiano impattato sui processi democratici di singole comunità.
Esatto. Come per le vite dei giovani: questioni complicate, dove non sempre ci sono conclusioni nette. Molti ragazzi stanno bene, alcuni no. Il punto è che non ha niente a che fare con la tecnologia. Alcuni ragazzi stanno soffrendo davvero: come possiamo usare strumenti tecnologici per aiutarli? Come possiamo usarli per rendere i problemi visibili e comprenderli? Vorrei solo che ci si fermasse un attimo, e ci si pensasse.
Non sta semplicemente dicendo che la tecnologia è neutrale, quindi?
Lo si può vedere nelle tecnologie provenienti dagli Stati Uniti: molte riflettono valori, norme, aspettative statunitensi. Per questo è così difficile un dibattito su questi temi in America. E non è solo una questione che cambia da Paese a Paese: ci sono considerazioni di genere, etnia, classe sociale. I nostri valori vengono incorporati nelle tecnologie, noi le modelliamo e loro modellano noi. E dunque nel libro ho cercato di mostrare quali siano le caratteristiche, le proprietà di queste tecnologie che cambiano le cose.
Per esempio?
Gran parte delle tecnologie ‘social’ più diffuse assume la persistenza. Che quel che si dice resta. Ed è fantastico, perfino necessario per alcune conversazioni, e l’architettura di molti di questi strumenti ci si affida per il loro stesso funzionamento. Ma allo stesso tempo ciò crea nuove complicazioni quando le parole che hai scritto sei, nove, dodici mesi fa, o perfino oltre, restano in circolazione e stai cercando di contrattare il fatto che le tue idee sono cambiate. Si possono scrivere cose di cui ci pentiamo. O pensiamo alla diffusione: se dici una cosa davvero imbarazzante o stupida a scuola, il numero di persone che può averlo testimoniato è relativamente limitato; se lo fai online, e ciò che dici attira l’attenzione di altre persone, all’improvviso ti ritrovi con milioni di testimoni.
C’è un effetto delle caratteristiche dei social media sui problemi di cui parla?
C’è qualcosa di nuovo, ma cambia più il risultato che le dinamiche di fondo di quei problemi. Il punto è che siamo così ossessionati dalle nuove tecnologie che finiamo per ignorare quelle dinamiche di fondo. Invece dovremmo concentrarci su come aiutare le persone, piuttosto che sul nutrire paure e reprimere le tecnologie.
Cosa pensa dell’idea, apparsa anche in Italia, di chiudere un social network perché alcuni dei suoi utenti lo usano per compiere gesti di cyber-bullismo? Servono nuove leggi per l’hate speech in rete?
Alla politica spesso non importa risolvere i problemi, ma far sembrare che si stia facendo qualcosa per risolverli. E a me piacciono le persone che risolvono i problemi, non quelle che sembrano risolverli. Per esempio: il cyberbullismo. Si parla molto delle cattiverie. La mia prima reazione è sempre: beh, forse smettere di essere cattivi l’uno con l’altro aiuterebbe. Se si tratta di affrontare crudeltà e cattiverie tra i ragazzi, parlare di tecnologia non farà sparire il problema. Semplicemente, riapparirà in un altro luogo.
Che fare?
Bisogna comprendere le dinamiche di fondo di ciò che sta succedendo. E sono dinamiche intricate: hanno a che fare con lo status nel proprio gruppo sociale di riferimento, con i problemi a casa. Ciò che si scopre è infatti che molto spesso i bulli hanno difficoltà in famiglia, soffrono di alcolismo o dipendenze, di problemi di salute mentale, hanno subito abusi in passato. Per questo la mia prima reazione quando si parla di questi ragazzi è: cosa è successo? Cosa hanno passato? E sappiamo affrontare quelle situazioni pregresse? Molto spesso no. Per questo la reazione è di incolpare gli strumenti che le hanno rese visibili, anche se il bullismo appare molto più di frequente a scuola. E non sento la politica dire: diamo la colpa alla scuola!
Nel libro esplora anche le conseguenze nefaste in termini di policy-making derivanti dall’adottare una visione centrata su Internet del problema. E dice chiaramente che serve una maggiore educazione alla comprensione dei problemi reali sollevati a partire dall’uso delle nuove tecnologie. Può dare qualche suggerimento ai docenti e genitori che ci leggono?
C’è bisogno di alfabetizzazione all’uso dei media. Una alfabetizzazione critica. Non è una questione che riguarda solo la tecnologia, ma l’essere capaci di consumare i contenuti che produciamo da un punto di vista critico. Non si può pensare che siccome i ragazzi guardano MTV allora capiscono i media. È ridicolo, non l’avremmo mai detto negli anni 80. E allora perché lo diciamo oggi?
Per i social media, dice. La retorica dei «nativi digitali», che lei contesta.
I ragazzi possono essere abili nell’usarli a scopi di socializzazione o per divertirsi, ma non necessariamente comprendono come queste tecnologie siano costruite: un problema che sta diventando sempre più importante con l’era dei dati – e non ci stiamo equipaggiando affatto per avere a che fare coi dati. E non è solo una questione di privacy. Voglio dire: cos’è un algoritmo? Come è fatto? Come sceglie quali contenuti sarai in grado di vedere e quali non sarai in grado di vedere? Come decide se un curriculum inviato per un’offerta di lavoro verrà guardato o no? Una alfabetizzazione algoritmica di base è molto importante, e la maggioranza dei docenti non la possiede. Ecco perché è una questione che riguarda tutta la società, non solo i ragazzi. Il mio Paese, gli Stati Uniti, e il vostro sono ossessionati dall’educazione formale. Ma ci sono molte forme di apprendimento che avvengono in canali informali. Buona parte riguarda le interazioni sociali. E una delle cose che ritengo davvero importanti è comprendere quanto valore abbiano le interazioni sociali per imparare a comprendere la realtà.
Quali differenze ci sono tra il contesto in cui vivono i giovani statunitensi e quelli italiani?
C’è una grossa differenza: nel vostro Paese i giovani escono ancora di casa. Possono gironzolare liberamente. Possono fare capannello nella piazza del paese senza che nessuno li sgridi. Tutto questo non è più vero nel mio Paese. E il risultato è che ciò che si vede sui social media negli Stati Uniti è molto di più la trasposizione di quel gironzolare che voi vedete offline, nei luoghi di incontro pubblici. I nostri ragazzi non hanno il tipo di mobilità che voi date per acquisita.
Il che è congruente con il contesto più ampio del dibattito internettiano e non di questi anni: dal Datagate, all’aumento costante del numero di telecamere di videosorveglianza – accettato acriticamente o quasi anche in Italia. Il che non fa che perpetuare e alimentare la cultura del terrore di cui parla nel libro, e che ha l’effetto di radicalizzarci, farci concepire la rete come la salvezza o la condanna dell’umanità.
E dire che nel vostro Paese e nel vostro Continente la sorveglianza ha una lunga e spiacevole storia: pensiamo per un attimo agli anni 40. Sono sempre stupita quando vedo i Paesi europei imboccare questa strada. Hanno visto a cosa conduce. Per l’Italia non posso fare a meno di pensare agli scritti di Italo Calvino, a come ne avesse previsto le conseguenze logiche. Sono sorpresa gli italiani la accettino.”
Mi cala la connessione
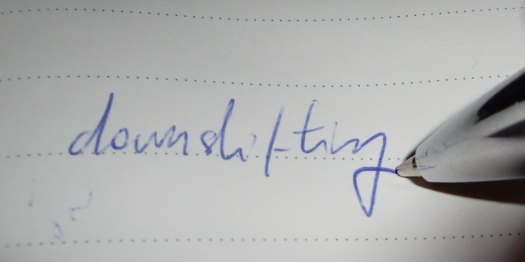 Mercoledì prossimo nella mia scuola ci sarà l’occasione di incontrare Serge Latouche. In questi giorni, nelle mie classi che vi parteciperanno ho provato a spiegare il suo pensiero, punti di forza e di debolezza. Oggi ho trovato un articolo molto interessante che, a suo modo, tratta di decrescita (dalla connessione internet). E’ preso dalla curiosa rivista Wired. La penna (anche se ormai si dovrà dire “la tastiera”) è quella di Carola Frediani.
Mercoledì prossimo nella mia scuola ci sarà l’occasione di incontrare Serge Latouche. In questi giorni, nelle mie classi che vi parteciperanno ho provato a spiegare il suo pensiero, punti di forza e di debolezza. Oggi ho trovato un articolo molto interessante che, a suo modo, tratta di decrescita (dalla connessione internet). E’ preso dalla curiosa rivista Wired. La penna (anche se ormai si dovrà dire “la tastiera”) è quella di Carola Frediani.
«“Entro 48 Ore”: sembra la locandina di un film al cardiopalma, in cui il protagonista deve eseguire un’impresa difficilissima in un lasso di tempo risicato. E invece è il titolo del primo libro italiano interamente dedicato al downshifting tecnologico, cioè alla riduzione del sovraccarico informativo ed emotivo prodotto dal nostro essere sempre connessi. Uno stato sempre più diffuso per cui riuscire a non rispondere a una mail per ben 48 ore può sembrare davvero una mission impossible, oltre a provocare uno strascico di sterili messaggi e richieste d’attenzione, di funzioni fatiche, direbbe un linguista: “Ricevuta la mail?”; “Tutto ok?”; faccina. Spesso con anche un interscambio dei canali di comunicazione: l’sms per verificare la ricezione della posta elettronica ad esempio è un classico, o il messaggio su Facebook per rafforzare il contenuto girato via Whatsapp (entrambi diabolici nel mostrare pure se l’interlocutore ha già visualizzato un messaggio), e chi più ne ha più ne metta.
La via dei ping e delle notifiche a strati è infinita, ma non la nostra pazienza e di sicuro non il nostro tempo. Giovanni Ziccardi, che è professore di informatica giuridica  all’università di Milano, nonché autore di libri sugli hacker, quindi tutto meno che un luddista, ha provato a sottrarsi a questo gioco al massacro dell’attenzione – in cui in genere siamo un po’ tutti ora vittime ora carnefici – e per sei mesi ha radicalmente modificato e ridotto il suo approccio al digitale.
all’università di Milano, nonché autore di libri sugli hacker, quindi tutto meno che un luddista, ha provato a sottrarsi a questo gioco al massacro dell’attenzione – in cui in genere siamo un po’ tutti ora vittime ora carnefici – e per sei mesi ha radicalmente modificato e ridotto il suo approccio al digitale.
In passato non sono mancati esempi del genere, anche se la scelta era sempre del tipo unplugged: mi stacco da tutto per un po’ di tempo, annunciavano gli intrepidi con un certo pathos, manco partissero per un’avventura Into The Wild. Lo ha fatto nel 2012 il reporter americano Paul Miller, che è stato pagato per stare un anno senza internet, e poi ci ha fatto un articolo: “Sono ancora qui”, in cui spiega come la sua esistenza lontano dalla Rete, che avrebbe dovuto illuminarlo in qualche modo, sia stata invece abbastanza infelice e non molto produttiva. Anche il giornalista italiano Beppe Severgnini nel 2012 si privò per una settimana di internet, riportando la dolorosa esperienza in un articolo in forma diaristica, dove confessò di essere ricorso perfino al televideo pur di sopperire a quella mancanza.
Ziccardi non fa nulla di così tragico: il suo approccio è pragmatico e a lungo termine. Come migliorare il rapporto con le tecnologie ed evitare di esserne dominati? Il risultato è un libro – Entro 48 Ore. Un’esperienza di downshfting tecnologico uscito oggi per Marsilio – che si configura come un percorso a tappe verso una rivisitazione delle proprie esigenze e modalità lavorative e comunicative. Abbiamo chiesto all’autore come è andata e cosa ha imparato.
Hai scritto il libro mentre stavi all’Istituto Max Planck di Friburgo, in Brisgovia, un’oasi nella Foresta Nera. Dalla tua finestra vedevi abeti secolari e corvi imperiali. Facile staccare in un simile contesto, no?
“Sì, in effetti, ci ho lavorato fra la Foresta Nera, Matera e l’Emilia… Diciamo che rispetto a Milano cambi proprio aria. Però volevo evitare quegli approcci negativi, in stile disintossicazione, usati sempre di più nelle cliniche americane (ma anche in quelle cinesi, di cui abbiamo parlato qui, ndr), per cui stai scollegato per un periodo e poi rientri nel tuo contesto abituale. L’ideale per me era poter ragionare, in luoghi meno caotici, su come rimettere la tecnologia al suo posto, eliminando il superfluo. Ovviamente amo la tecnologia, sono trent’anni che uso un computer, anche per lavoro, per quanto mai come negli ultimi tempi si sia avvertita una simile pressione sociale a causa del livello di connessioni. E penso che prima o poi si arriverà a una fase di rigetto.”
Dunque come ti sei organizzato? E qual è stato il passaggio più difficile in un percorso di progressiva presa di coscienza?
“Nella prima parte dell’esperimento ho analizzato il mio ritmo tecnologico, valutando quando e dove non avevo abbastanza controllo dei miei comportamenti, quindi correggendoli. Successivamente ho cercato di usare al meglio il tempo che avevo così liberato, sfruttandolo per aumentare la qualità di quello che facevo, che si trattasse di rileggere più volte e senza interruzioni un articolo o di gustare un pranzo a un ristorante stellato. La cosa più difficile è far cambiare le abitudini alle persone vicine, che si aspettano delle risposte da te.”
Tu lo definisci: “dominare l’ansia tecnologica altrui”, e rispondi sostanzialmente in due modi: accorpando le comunicazioni, e rendendole più brevi (fai l’elogio degli smarpthone che ti permettono la scusa della brevità, il famoso “Sent from my BlackBerry. Excuse brevity”) e… diventando un po’ antipatico.
“Negli Stati Uniti c’è un dibattito sul fatto se si debba sempre dare una risposta alle mail. Secondo me se uno ti scrive “ci vediamo domani alle 12” non serve replicare. Il problema è che magari le persone non sono abituate e se non ricevono una conferma si agitano. In altri casi certe mail non necessitano proprio di una risposta. Alla fine l’unico modo è rendersi un po’ antipatici, ma al fine di ridurre il sovraccarico reciproco. In generale bisogna capire che, fatte salve alcune eccezioni legate a lavori particolari, se si risponde a una mail in 48 ore non succede nulla di irreparabile.”
Nel libro riscopri anche i pregi della monoattenzione, cioè di poter concentrarsi solo su una cosa, senza distrazioni, contro il multitasking.
“In base a questa esperienza, ho notato che la monoattenzione – potersi dedicare in esclusiva a un compito, che si tratti di vedere un film, leggere un libro, avere una conversazione faccia a faccia – porta a una maggiore qualità di quello che facciamo. Inoltre rafforza la memoria. Un altro dei dibattiti in corso negli Usa è proprio se possiamo fare a meno delle nostre capacità mnemoniche visto che confidiamo sempre di più su supporti esterni, come Google, per ricordare. Secondo me la risposta è no, anche perché la memoria fonda il processo creativo.”
Dunque che regole consigli, soprattutto a dei lavoratori della conoscenza sempre connessi?
“Separare i tempi in base alla singola cosa che va fatta: dunque monoattenzione in slot temporali definiti; prendere atto che non muore nessuno se si ritarda fino a 48 ore nelle proprie attività telematiche ed educare di conseguenza i propri contatti; accorpare i momenti di controllo delle mail e dei social network, e disattivare se possibile le notifiche; crearsi un ambiente tecnologico efficiente, facile da usare, e senza distrazioni; investire il tempo recuperato prediligendo un doppio (o triplo) controllo su quello che facciamo, perché ne migliorerà la qualità; selezionare la qualità e l’autorevolezza delle fonti che leggiamo, senza lasciarsi trascinare a caso; e soprattutto darsi delle regole valide per il lungo periodo, sapendo che siamo in un mondo che da questo punto di vista rema contro.”»
Poco nitido
E’ un articolo molto interessante quello pubblicato da Roberto Cotroneo su “Sette” il 31 ottobre. Lo riporto qui e lo commento sotto.
 “Prima o poi dovremo fare i conti con quello che ci è rimasto dell’assenza. E prima o poi capiremo quali danni possono fare i social e il web 2.0 sulla nostra vita. L’essere sempre connessi infatti non è soltanto un modo di stare nel mondo, non è solo la meravigliosa sensazione di raggiungere chi vogliamo, sempre e comunque, ma è la cancellazione dei tempi verbali della nostra vita: tutti, eccetto il presente. Voglio dire che ormai non viviamo più con i passati remoti o con i futuri anteriori. Non c’è un luogo della memoria da riempire con immaginazione e verità, non c’è un presente che sfuma verso un passato lentamente fino quasi a lasciare solo piccoli puntini lontani. E non c’è neppure l’attesa del futuro, perché il futuro o si fa presente oppure non esiste. Cosa voglio dire. Voglio dire che i nativi social, che sono una categoria ancora diversa dai nativi digitali, quelli che sono cresciuti usando facebook sin da bambini, quelli abituati a esserci sempre e comunque, hanno un problema con il distacco dalle cose. Hanno un problema con il tempo. Tutto quello che è accaduto nella loro vita, dalle grandi alle piccole cose, non smette di essere, come non si smette di esistere nelle bacheche e nelle timeline. Sta tutto lì. Hai voglia a cancellare, a togliere, a limare. Il passato viene di continuo rovesciato sul presente come fossero detriti e calcinacci che occupano lo spazio della nostra vita, e con cui si deve fare i conti. C’è una vecchia storia, di quando i social non esistevano, che Umberto Eco racconta nel suo Secondo Diario Minimo: «Salvatore lascia all’età di vent’anni il paese natio per emigrare in Australia, dove vive in esilio per quarant’anni. Poi, sessantenne, raccolti i suoi risparmi, torna a casa. E mentre il treno si avvicina alla stazione, Salvatore fantastica: ritroverà i compagni, gli amici di un tempo, nel bar della sua gioventù? Lo riconosceranno? Gli faranno delle feste, gli chiederanno di raccontare le sue avventure tra i canguri e aborigeni, avidi di curiosità? E quella ragazza che…? E il droghiere dell’angolo? E cosi via… Il treno entra nella stazione deserta, Salvatore scende sul marciapiede battuto dal gran sole meridiano. Lontano, ecco un omino curvo, inserviente delle ferrovie. Salvatore lo guarda meglio, riconosce quella figura malgrado le spalle ingobbite, il viso segnato da quarant’anni di rughe: ma certo, è Giovanni, l’antico compagno di scuola! Gli fa un segno, si avvicina trepidante, indica con la mano tremante il proprio volto come per dire: “Sono io”. Giovanni lo guarda, sembra non riconoscerlo, poi alza il mento in un gesto di saluto: “Ehi, Salvatore! Che fai, parti?”». Salvatore era partito, scomparso, e nessuno si era accorto della sua assenza. Forse Salvatore non era un tipo capace di farsi notare. Ma oggi queste considerazioni, l’idea di partire e tornare, la speranza di essere riconosciuti ma in modo nuovo, con il tempo che ci ha attraversato, con il passato che racconta di noi, è impossibile. Oggi Salvatore sarebbe là, come sempre, dall’Australia come dall’Italia. Sarebbe là a twittare o a postare fotografie, a scrivere sui social o a raccontarsi. Come sempre, con le foto che aggiornano il suo volto, che lo mostrano visibile e sempre uguale. Se oggi tornasse ritroverebbe Giovanni, vecchio compagno di scuola, con una battuta, tipo: belle le foto dei canguri. Oppure: ma quanto sono cresciuti i tuoi figli! E se il tempo e la memoria non contano, non conta neppure la nostalgia: non esiste il prima e il dopo, e non esiste il passato, il passato è soltanto un presente rinnovato, riciclato in un certo senso. Niente si chiude, niente si compie in modo definitivo. Tutto resta per tornare. Ex mariti ed ex mogli, fidanzate dimenticate, amici di un tempo, colleghi, e poi compagni di scuola, commilitoni, parenti lontani. Restano tutti lì, aggiornati all’oggi, nitidi, come se non fossero mai usciti da un orizzonte ingombrante di cui non si sente il bisogno. Un tempo lo slogan era: cerca su facebook le persone della tua vita. Ma senza l’assenza il tempo non passa. Senza perdere qualcosa il ritrovare è un concetto vuoto.”
“Prima o poi dovremo fare i conti con quello che ci è rimasto dell’assenza. E prima o poi capiremo quali danni possono fare i social e il web 2.0 sulla nostra vita. L’essere sempre connessi infatti non è soltanto un modo di stare nel mondo, non è solo la meravigliosa sensazione di raggiungere chi vogliamo, sempre e comunque, ma è la cancellazione dei tempi verbali della nostra vita: tutti, eccetto il presente. Voglio dire che ormai non viviamo più con i passati remoti o con i futuri anteriori. Non c’è un luogo della memoria da riempire con immaginazione e verità, non c’è un presente che sfuma verso un passato lentamente fino quasi a lasciare solo piccoli puntini lontani. E non c’è neppure l’attesa del futuro, perché il futuro o si fa presente oppure non esiste. Cosa voglio dire. Voglio dire che i nativi social, che sono una categoria ancora diversa dai nativi digitali, quelli che sono cresciuti usando facebook sin da bambini, quelli abituati a esserci sempre e comunque, hanno un problema con il distacco dalle cose. Hanno un problema con il tempo. Tutto quello che è accaduto nella loro vita, dalle grandi alle piccole cose, non smette di essere, come non si smette di esistere nelle bacheche e nelle timeline. Sta tutto lì. Hai voglia a cancellare, a togliere, a limare. Il passato viene di continuo rovesciato sul presente come fossero detriti e calcinacci che occupano lo spazio della nostra vita, e con cui si deve fare i conti. C’è una vecchia storia, di quando i social non esistevano, che Umberto Eco racconta nel suo Secondo Diario Minimo: «Salvatore lascia all’età di vent’anni il paese natio per emigrare in Australia, dove vive in esilio per quarant’anni. Poi, sessantenne, raccolti i suoi risparmi, torna a casa. E mentre il treno si avvicina alla stazione, Salvatore fantastica: ritroverà i compagni, gli amici di un tempo, nel bar della sua gioventù? Lo riconosceranno? Gli faranno delle feste, gli chiederanno di raccontare le sue avventure tra i canguri e aborigeni, avidi di curiosità? E quella ragazza che…? E il droghiere dell’angolo? E cosi via… Il treno entra nella stazione deserta, Salvatore scende sul marciapiede battuto dal gran sole meridiano. Lontano, ecco un omino curvo, inserviente delle ferrovie. Salvatore lo guarda meglio, riconosce quella figura malgrado le spalle ingobbite, il viso segnato da quarant’anni di rughe: ma certo, è Giovanni, l’antico compagno di scuola! Gli fa un segno, si avvicina trepidante, indica con la mano tremante il proprio volto come per dire: “Sono io”. Giovanni lo guarda, sembra non riconoscerlo, poi alza il mento in un gesto di saluto: “Ehi, Salvatore! Che fai, parti?”». Salvatore era partito, scomparso, e nessuno si era accorto della sua assenza. Forse Salvatore non era un tipo capace di farsi notare. Ma oggi queste considerazioni, l’idea di partire e tornare, la speranza di essere riconosciuti ma in modo nuovo, con il tempo che ci ha attraversato, con il passato che racconta di noi, è impossibile. Oggi Salvatore sarebbe là, come sempre, dall’Australia come dall’Italia. Sarebbe là a twittare o a postare fotografie, a scrivere sui social o a raccontarsi. Come sempre, con le foto che aggiornano il suo volto, che lo mostrano visibile e sempre uguale. Se oggi tornasse ritroverebbe Giovanni, vecchio compagno di scuola, con una battuta, tipo: belle le foto dei canguri. Oppure: ma quanto sono cresciuti i tuoi figli! E se il tempo e la memoria non contano, non conta neppure la nostalgia: non esiste il prima e il dopo, e non esiste il passato, il passato è soltanto un presente rinnovato, riciclato in un certo senso. Niente si chiude, niente si compie in modo definitivo. Tutto resta per tornare. Ex mariti ed ex mogli, fidanzate dimenticate, amici di un tempo, colleghi, e poi compagni di scuola, commilitoni, parenti lontani. Restano tutti lì, aggiornati all’oggi, nitidi, come se non fossero mai usciti da un orizzonte ingombrante di cui non si sente il bisogno. Un tempo lo slogan era: cerca su facebook le persone della tua vita. Ma senza l’assenza il tempo non passa. Senza perdere qualcosa il ritrovare è un concetto vuoto.”
Ho letto queste parole in treno, più di 15 giorni fa, mentre andavo a Torino con Sara; lungo il viaggio tempo e spazio passavano accanto a me e dentro di me, in piena sintonia con le parole del pezzo. Eppure sentivo in me qualcosa di dissonante. L’esperienza diretta dei social mi porta a pensare che le parole di Cotroneo possano valere per una persona totalmente assorbita da essi, una sorta di isolato sociale che abbia solo quella possibilità di socializzazione. Un po’ come quando mi succede di leggere delle nuove generazioni che vivono rapporti falsi, fittizi ed esclusivamente virtuali a causa dei social. Quel che mi capita di vedere e ascoltare in classe è che la maggior parte dei ragazzi coltivano e approfondiscono su internet rapporti già esistenti nella realtà e che le due cose si integrino tra loro. La nitidezza di questo mondo che si sta costruendo è, a mio avviso, molto meno chiara di quanto si possa pensare, ed è in continua evoluzione, come se ci fosse un velo di foschia a non rendere chiari i contorni delle cose. Sarà stato forse per questo, quasi per reazione, che il 7 novembre scrivevo le parole di Pasolini: “Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’aver amato, non l’aver conosciuto”. E sono uno che il passato lo pensa, lo rievoca, lo elabora, lo ama per meglio cogliere il futuro (a esemplificazione di ciò il prossimo post…).
