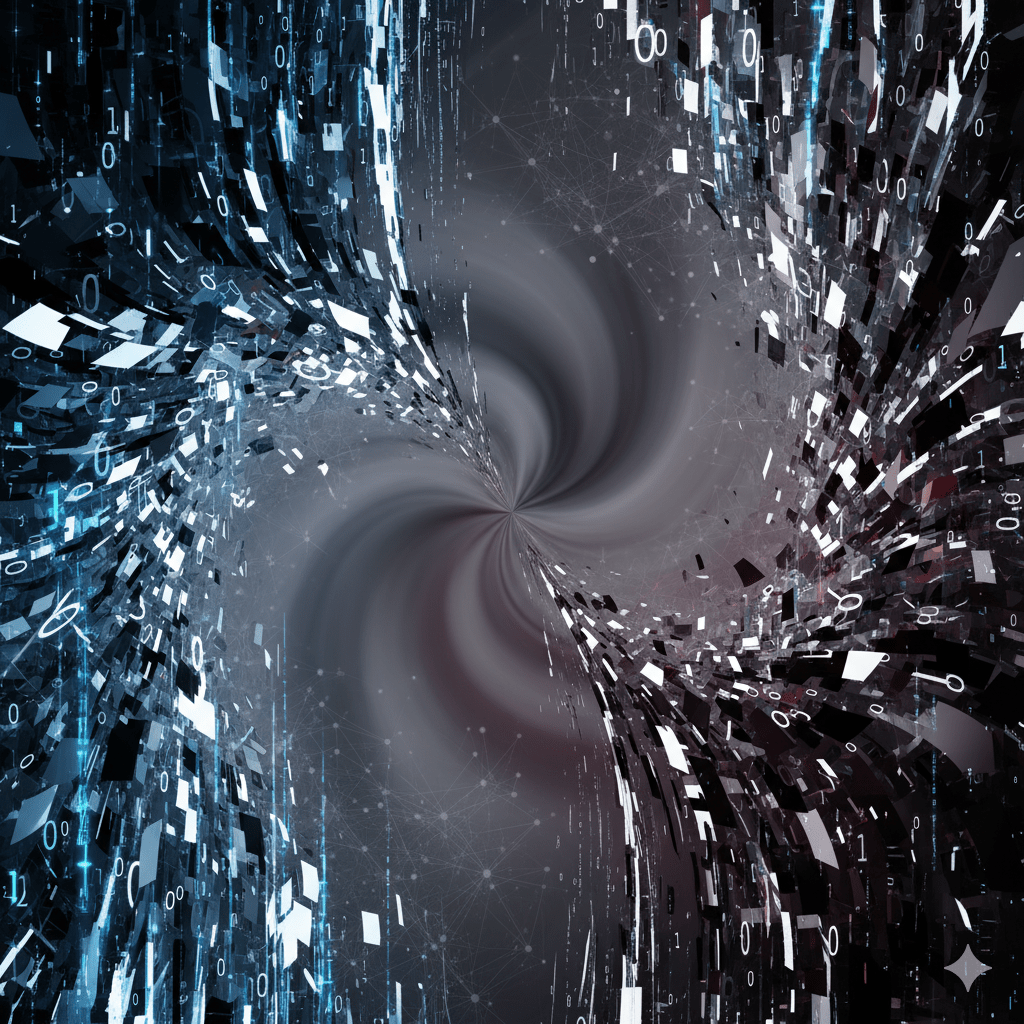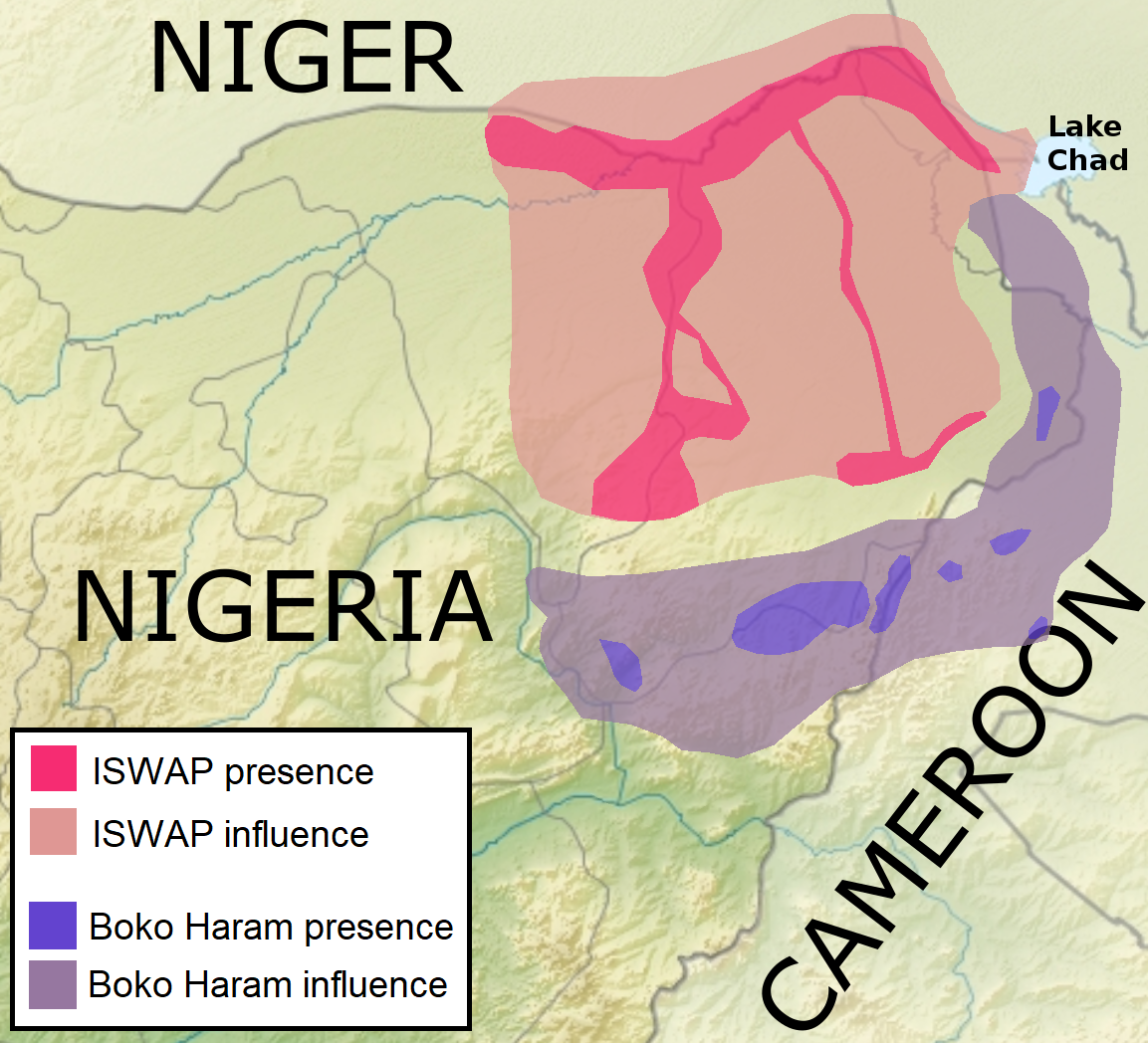Negli ultimi anni si è parlato molto dell’utilizzo di simboli religiosi all’interno del linguaggio politico. Ovviamente si tratta di un uso spesso opportunistico, ma non mi aspetto molto di diverso da un personaggio politico di questo periodo storico. Ma se provassimo a dare un’occhiata ai simboli religiosi in ambito religioso? In particolare a quelli, gesti simbolici compresi, utilizzati dagli ultimi pontefici? Un approfondito articolo di Martina Marradi, pubblicato su Pandora Rivista, affronta proprio questo aspetto. Buona lettura.
“Tutte le religioni si esprimono attraverso un repertorio simbolico composto da gesti, immagini e oggetti capaci di evocare significati profondi e condivisi all’interno di una comunità (cfr. Clifford Geertz, Interpretation Of Cultures, Basic Books, New York 1973, pp. 99, 104, 112-11). In ambito sacro, il simbolo non è mai neutro: come sottolineato da Jung, esso racchiude un contenuto che trascende la parola, rivelando un senso che rinvia all’invisibile e all’inconscio collettivo (cfr. Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles: Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Robert Laffont, Parigi 1982, pp. XVII-XVIII). I simboli religiosi operano su un doppio registro: da un lato sono profondamente evocativi, dall’altro lato sono intrinsecamente arbitrari. La loro capacità di trasmettere significati spirituali e valori condivisi non risiede in una qualità oggettiva delle forme o dei materiali che li compongono, ma nel significato culturale che viene attribuito loro. Un esempio emblematico è la croce: due semplici pezzi di legno disposti in forma perpendicolare non assumono un valore simbolico universale, ma acquisiscono significato solo per chi riconosce in quella forma il riferimento alla crocifissione del Cristo. Ne consegue che la sacralità di un oggetto può risultare del tutto irrilevante, o persino impercettibile, per chi non condivide lo stesso orizzonte simbolico.
Tuttavia, questa arbitrarietà non nega il valore esperienziale dei simboli, che è legato indissolubilmente alla loro materialità. I simboli religiosi sono sempre incarnati in oggetti, gesti, immagini o spazi che coinvolgono i sensi e il corpo. È attraverso la loro tangibilità che riescono a suscitare emozioni, a radicarsi nella memoria collettiva e a favorire un senso di appartenenza. L’icona della Vergine Maria venerata in una chiesa ortodossa, la statua del Cristo portata in processione in una città mediterranea o il rosario che scorre tra le dita di un fedele sono tutti esempi di come la religione si esprima e si trasmetta attraverso forme materiali. La fede stessa, pur riferendosi a una realtà trascendente e invisibile, trova nella concretezza dei simboli un mezzo privilegiato per essere vissuta, comunicata e interiorizzata. Il segno della croce, tracciato sul proprio corpo, non è solo un gesto identitario: è una forma di preghiera che richiama la Passione di Cristo. Analogamente, la mano del sacerdote che si posa sul capo dei cresimandi non è soltanto un gesto rituale, ma un veicolo di riconoscimento comunitario. In questo senso, la religione ha bisogno di oggetti, immagini e azioni per rendere visibile l’invisibile, per mediare la relazione tra l’umano e il divino, tra la carne e lo spirito (cfr. Ugo Fabietti, Materia sacra. Corpi, oggetti, immagini, feticci nella pratica religiosa, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015).
In questo contesto, il modo in cui il Papa, in quanto massima autorità religiosa riconosciuta nella Chiesa cattolica, utilizza i simboli diventa un indicatore significativo del suo orientamento spirituale, teologico e pastorale. E proprio analizzando i pontificati di Benedetto XVI e di Francesco emergono due visioni profondamente diverse ma altrettanto efficaci del potere simbolico della Chiesa; mentre segnali ancora diversi provengono dalle prime scelte compiute da Leone XIV.

Rinnovamento nella tradizione: la performatività dei gesti e delle scelte di Benedetto XVI
Durante il suo pontificato, Benedetto XVI intraprende un’opera di rinnovamento ecclesiale radicata nella tradizione, facendo leva sul potere evocativo della simbologia: unendo la spiritualità con la fisicità cerca di rivitalizzare il cattolicesimo attraverso il recupero dei riti e dei simboli ormai in disuso (cfr. Giacomo Galeazzi, Ratzinger. Il Papa sceso dal trono, Rubbettino, Soveria Mannelli 2023). Tale orientamento, pur mosso da una profonda motivazione spirituale, «La cosa importante è che la fede duri oggi. Io vedo questo come il compito centrale» (Benedetto XVI, Last testament in his own words in Peter Seewald (a cura di), Bloomsbury Continuum, Londra 2017), riflette un’oculata strategia. Nella società dell’immagine anche la Chiesa è consapevole di quanto siano rilevanti i simboli, poiché è da essi che un credo può rinascere, e se la scelta benedettina viene etichettata come conservatrice, il Pontefice ritiene che la Chiesa non debba adattarsi ai costumi del tempo, poiché essa «può essere moderna proprio essendo antimoderna», non allineandosi con l’opinione dominante (Cfr. Joseph Ratzinger, Salt of the Earth. Christianity and the Catholic Church at the End of the Millennium, in Peter Seewald (a cura di), traduzione di Adrian Walker, Ignatius Press, San Francisco 1997).
La strategia adottata si inserisce in un quadro analitico coerente con le osservazioni del sociologo Berger, secondo cui i movimenti religiosi caratterizzati da un’impostazione conservatrice e soprannaturalista sono quelli che mostrano maggiore vitalità di fronte alla secolarizzazione: il successo di tali gruppi risiederebbe proprio nella loro capacità di offrire certezze simboliche in un mondo frammentato e relativista, soddisfacendo un bisogno crescente di identità e radicamento spirituale. Benedetto è consapevole della percezione di anacronismo che grava sulla Chiesa, ma è convinto che solo difendendo la propria identità senza scendere a compromessi sarà possibile riportare in auge il cattolicesimo (Cfr. Peter Seewald, Benedetto XVI. Una vita, Garzanti, Milano 2020). In questa prospettiva, nella roccaforte europea il cattolicesimo necessiterà di riaffermare la propria alterità dottrinale, entrando in dialogo, anche conflittuale, con le nuove identità religiose che si affermano nel continente. Tale riaffermazione richiede, a suo avviso, una rinnovata unità del cristianesimo, condizione necessaria per rendere la fede cristiana la possibile «religione civile dell’Europa» (Silvio Ferrari, Europa cristiana? L’eredità di Giovanni Paolo II, fra luci e ombre, «Limes», 20 maggio 2005).
Dal giorno della sua elezione, Benedetto indossa paramenti di tipo tradizionale con l’obiettivo di rivitalizzare la Chiesa, preservare la sacralità del culto ed evitare l’erosione dei valori cristiani in Occidente: «È chiaro […] che la scristianizzazione dell’Europa progredisce, che l’elemento cristiano scompare sempre più dal tessuto della società. Di conseguenza la Chiesa deve trovare una nuova forma di presenza, deve cambiare il suo modo di presentarsi» (Benedetto XVI, a cura di Peter Seewald, Ultime conversazioni, Garzanti, Milano 2016). Il significato simbolico delle sue scelte è duplice. Da un lato, egli vuole dare valore a ogni elemento della liturgia, nel senso spirituale del termine: «Il fatto che stiamo all’altare, vestiti con i paramenti liturgici, deve rendere chiaramente visibile ai presenti e a noi stessi che stiamo lì “in persona di un Altro”. […] [Ciò significa] “rivestirsi di Cristo”, parlare ed agire in persona Christi» (Benedetto XVI, Santa Messa del crisma. Omelia di Sua Santità Benedetto XVI, Vatican.va, 5 aprile 2007). Dall’altro lato, il richiamo alla tradizione favorisce un’identificazione ecumenica, poiché il recupero di forme rituali condivise, come l’abbigliamento liturgico, crea continuità simbolica con altre Chiese cristiane, in particolare quella ortodossa.
Coerentemente con tale logica, il Pontefice promuove anche il recupero del latino come lingua liturgica. Per esprimere l’unità della Chiesa, ne raccomanda l’utilizzo durante le grandi celebrazioni, nella recita delle preghiere più comuni e nel canto gregoriano, esortando i seminaristi a conoscerlo, a celebrarne l’uso e a trasmetterne il significato ai fedeli. Per recuperare il senso della liturgia ripristina la somministrazione della Comunione in bocca e in ginocchio nella liturgia papale e per motivazioni di carattere pastorale e teologico invita i sacerdoti a celebrare la liturgia ad orientem, ossia dinanzi all’altare, rivolti nella stessa direzione dei fedeli. Anche l’altare e il trono papale vengono ricollocati al centro della scena liturgica, al fine di sottolinearne la centralità simbolica.

Missione ad gentes: la performatività dei gesti e delle scelte di Francesco
Il pontificato di Francesco, al contrario, si distingue per una forte carica simbolica che riflette uno stile pastorale ostinatamente sobrio. Per ciò che concerne l’abbigliamento, nonostante erediti l’intero guardaroba papale dei predecessori, egli sceglie quasi sempre di indossare una semplice talare bianca e le sue scarpe ortopediche nere, evidenziando così la sua volontà di presentarsi come servus servorum Dei. Dopo l’elezione utilizza il pulmino dei Cardinali per tornare in albergo, paga di persona il conto lasciato in sospeso lì dove ha alloggiato durante il Conclave, si rifiuta di sedersi sul trono per ricevere l’obbedienza dei Cardinali e decide di risiedere a Santa Marta, piuttosto che nella residenza papale a lui dedicata. Gesti come il rifiuto di avere un assistente personale o un portaborse incaricato di aprirgli lo sportello dell’automobile costituiscono segnali performativi di un preciso stile pontificale, veicolando il messaggio secondo cui il potere non si esprime nel dominio, bensì nel servizio agli altri (cfr. Dario Edoardo Viganò, La predicazione di papa Francesco, in Andrea Riccardi (a cura di), Il cristianesimo al tempo di papa Francesco, Laterza, Roma-Bari 2022).
È anche estremamente simbolica la scelta di celebrare la messa in luoghi non convenzionali per evidenziare come la Chiesa sia protesa verso gli emarginati. Nel primo viaggio al di fuori dei confini vaticani, Francesco si reca a Lampedusa e lì celebra la messa dinanzi a un altare ricavato da un’imbarcazione impiegata da alcuni migranti per raggiungere l’isola. Nel 2016, invece, officia la messa a Ciudad Juárez, una città di frontiera messicana al confine con gli Stati Uniti nota per la sua violenza e per la concentrazione di migliaia di migranti latinoamericani.
Nel ravvivare i momenti di fede attraverso l’introduzione o il potenziamento di rituali, Bergoglio non privilegia l’aspetto dottrinale, ma orienta la spiritualità cristiana verso le sfide contemporanee: così facendo cerca di trascendere la comunità dei cristiani per rivolgersi anche ai non credenti e mostra come la Chiesa sia capace di adattarsi ai problemi del nostro secolo (cfr. Marco Politi, Francesco tra i lupi. Il segreto di una rivoluzione, Laterza, Roma-Bari 2014). Emblematiche sono in tal senso le Giornate mondiali istituite durante il suo pontificato: nel 2014 istituisce la Giornata mondiale dei movimenti popolari e la Giornata mondiale dei poveri, nel 2015 la Giornata mondiale della preghiera per la cura del Creato e la Giornata internazionale di preghiera e sensibilizzazione contro la tratta di esseri umani, nel 2021 la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani e nel 2024 la Giornata mondiale dei bambini. Questi eventi non hanno solo lo scopo di coinvolgere i fedeli, ma anche quello di mobilitarli. In genere, le Giornate mondiali della Chiesa cattolica includono iniziative di sensibilizzazione e di beneficenza – per esempio, durante la Giornata mondiale dei poveri molte parrocchie organizzano raccolte di cibo e denaro da destinare ai senza dimora – e ottengono un’importante copertura mediatica: usualmente le agenzie di stampa come Associated Press e Reuters coprono il discorso del Pontefice, mentre altri media evidenziano le citazioni che affrontano questioni sociali o politiche di rilevanza e le integrano con analisi approfondite.
Particolarmente significativa è la benedizione Urbi et Orbi del 2020 e la Via Crucis al Colosseo del 2022: anche in queste occasioni il Pontefice unisce un tradizionale rito cristiano con un momento di riflessione sulle questioni contemporanee. Il 27 marzo 2020, egli decide di tenere una benedizione apostolica in una Piazza San Pietro completamente vuota a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Le fotografie che lo ritraggono da solo durante questa cerimonia religiosa diventano celebri in tutto il mondo e l’evento, trasmesso sia in diretta televisiva sia in diretta streaming, è seguito solo in Italia da oltre undici milioni di persone. Simboliche sono anche le scelte che vengono fatte durante la celebrazione: il Pontefice non raggiunge il leggio da dentro San Pietro, ma dall’esterno, come un normale visitatore, e non si protegge dalla pioggia durante il suo percorso. La vasta copertura mediatica è attribuibile non solo alla straordinarietà dell’evento, ma anche alla forza simbolica con cui il Papa riafferma la leadership morale della Chiesa nei momenti di crisi. Il 15 aprile 2022, invece, egli ripristina la Via Crucis dopo la pandemia. Per l’occasione modifica una parte del testo della cerimonia per adattarlo agli eventi della contemporaneità, fa portare la croce a una donna ucraina e a una russa e si fa accompagnare dalle famiglie, discutendo ad ogni stazione della processione i problemi che esse devono affrontare nella vita di tutti i giorni.

Tra sobrietà e tradizione: i primi gesti simbolici di Papa Leone XIV
Nonostante il pontificato di Papa Leone XIV sia iniziato da poco tempo, si possono già cogliere alcuni segnali simbolici significativi nel suo stile pontificale, che suggeriscono la direzione che intende imprimere alla Chiesa. Per esempio, la scelta del nome pontificale richiama immediatamente la figura di Papa Leone XIII, Pontefice noto per il suo impegno sociale, di cui l’enciclica Rerum Novarum, da lui emanata, è l’emblema principale. In tal senso, il nome scelto da Prevost potrebbe indicare l’intenzione di proseguire lungo la linea del dialogo tra Chiesa e società, con particolare attenzione alle questioni sociali e ai diritti dei lavoratori.
Sin dalle sue prime apparizioni pubbliche, inoltre, l’attuale Papa opta per un abbigliamento sobrio, ma tradizionale: la scelta di indossare la mozzetta rossa, assente nel pontificato francescano, ma presente in quello benedettino, potrebbero segnalare un desiderio di equilibrio tra semplicità e solennità. L’uso di una croce pettorale non eccessivamente elaborata, seppur ricca nei dettagli, sembra voler indicare una Chiesa che mantiene la sua dignità istituzionale senza rinunciare alla prossimità al popolo. In definitiva, i primi gesti simbolici di Papa Leone XIV sembrano voler inaugurare un pontificato all’insegna del dialogo, della sobrietà e della continuità con alcune delle grandi eredità del passato, in particolare nel campo dell’impegno sociale. Ma saranno i prossimi passi a confermare se questo equilibrio tra tradizione e rinnovamento diventerà il tratto distintivo del suo magistero petrino.
Tornando a Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, entrambi attraverso scelte simboliche profondamente divergenti ma ugualmente intenzionali, mostrano due vie complementari per rendere visibile l’invisibile: il primo attraverso il recupero della tradizione liturgica, il secondo mediante gesti di rottura e prossimità. In entrambi i casi, il simbolo si conferma strumento centrale di comunicazione spirituale e politica della Chiesa. Come Pontefice, Ratzinger restituisce modernità alla tradizione. Per lottare contro il relativismo dei valori e rilanciare la religione cattolica, decide di dare forza ai simboli e ai riti: l’impiego di paramenti liturgici di tipo tradizionale, la celebrazione della messa in latino, la valorizzazione del canto gregoriano sono alcuni dei fattori caratteristici del suo ministero che fanno emergere l’obiettivo di evitare che la secolarizzazione possa provocare un’emorragia inarrestabile di fedeli. Benedetto si impegna per l’unità del cristianesimo europeo nella convinzione che l’ecumenismo sia essenziale per la preservazione della fede. Francesco, invece, presenta uno stile pastorale sobrio, evidente in numerosi gesti simbolici che compie all’inizio del suo pontificato. Per lottare contro il relativismo dei valori e rilanciare la religione cattolica, egli decide di rivitalizzare i momenti di fede mediante l’introduzione o il rafforzamento di alcuni rituali, non ponendo attenzione alla dimensione dottrinale, bensì mettendo in luce i problemi mondiali e le sfide contemporanee da affrontare. Per il Pontefice l’obiettivo più urgente consiste nel ricreare un tessuto spirituale nella società che possa permettere alle religioni di riottenere un peso specifico nella vita pubblica e politica.”