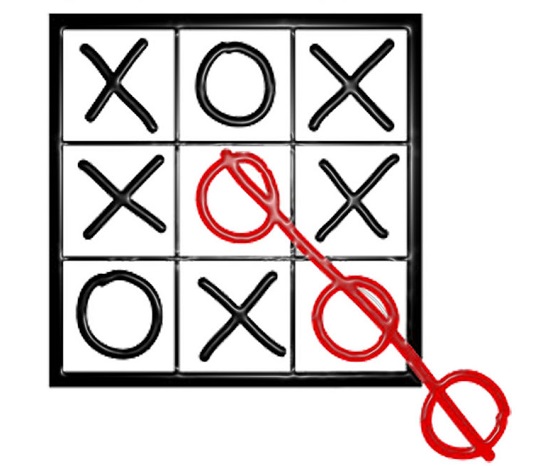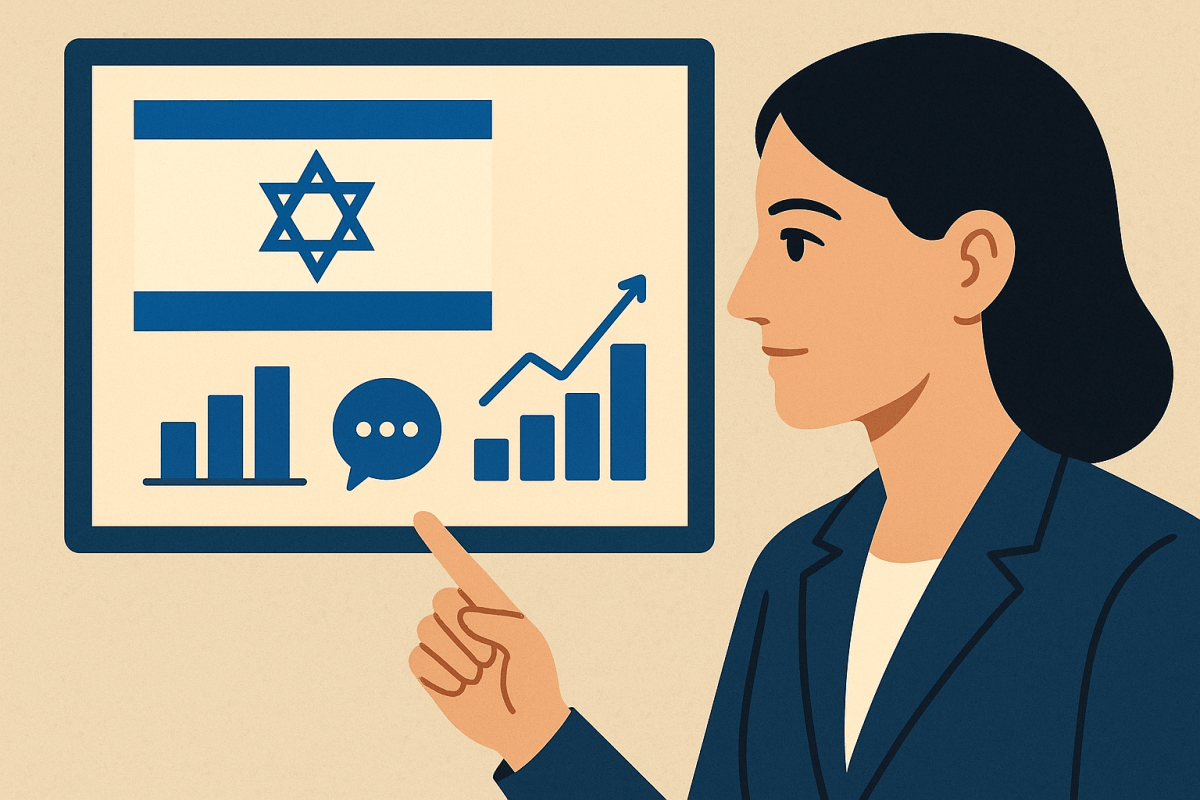
Sono lontani i tempi in cui leggevo una cinquantina di libri all’anno; per ora sono a venti e ne sono comunque molto soddisfatto, anche perché il calo è dovuto alla meravigliosa presenza di Mariasole e Francesco. Tra le letture di questi mesi, alcune hanno a che fare con uno dei temi dell’articolo che vorrei proporre oggi: il rapporto tra come le cose avvengono e come esse sono raccontate, la relazione tra verità e post-verità. Ho letto Autocrazie. Chi sono i dittatori che vogliono governare il mondo di Anne Applenbaum, L’Africa non è un paese. Istruzioni per superare luoghi comuni e ignoranza sul continente più vicino di Dipo Faloyn, 2100: Come sarà l’Asia, come saremo noi di Simone Pieranni, Trump e il fascismo liberale di Slavoj Žižek, Grazie, Occidente! di Federico Rampini e Il crollo di Babele. Che fare dopo la fine del sogno di Internet? di Paolo Benanti. Ho appena iniziato Traffic. La corsa ai clic e la trasformazione del giornalismo contemporaneo di Ben Smith. Si tratta di libri non sempre allineati sullo stesso punto di vista: ad esempio mi piacerebbe assistere ad un confronto tra Dipo Faloyn e Federico Rampini su alcuni dei temi che hanno affrontato nei loro testi. Fare letture diverse però è uno dei metodi che utilizzo per cercare di sottrarmi alle bolle di filtraggio informativo. Su temi affini è stato anche molto interessante un intervento a cui ho assistito la scorsa settimana durante un corso di aggiornamento: a parlare è stato Laris Gaiser, esperto di geopolitica e geoeconomia.
L’articolo lo prendo invece da Avvenire e spiega cosa sia la hasbara utilizzata dal governo israeliano. Inutile che premetta io di cosa si tratti, lascio spazio direttamente ad Anna Maria Brogi.
“La chiamano hasbara. La “spiegazione”, dal punto di vista del governo di Israele, dei fatti che lo riguardano. I detrattori traducono: propaganda. In tempi di guerra si sa che è un’arma. Piuttosto costosa. A Gaza non c’è la carestia. Le foto dei bambini denutriti sono manipolate o mostrano gli effetti di malattie rare. Tutti i giornalisti di Gaza (solo palestinesi, poiché Israele vieta l’ingresso alla stampa) sono al soldo di Hamas. I terroristi fanno incetta del cibo e banchettano nei tunnel. I tredicimila dipendenti dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) sono tutti membri di Hamas. Negli ospedali di Gaza si nascondono i terroristi. I medici sono terroristi. Gli infermieri sono terroristi. Il numero delle vittime civili a Gaza, in proporzione ai combattenti uccisi, è inferiore a quello di altre guerre. Se fosse facile dimostrare queste tesi, il governo di Benjamin Netanyahu non avrebbe bisogno di tenere in piedi una macchina colossale di comunicazione, che comprende: un dipartimento delle Forze armate espressamente dedicato a ricostruire il legame diretto di ogni giornalista ucciso con la Jihad islamica o con Hamas; un gruppo di influencer ai quali (e solo a loro) è stato consentito ad agosto l’ingresso ai siti di distribuzione del cibo della Gaza Humanitarian Foundation per dire che nella Striscia non c’è fame; conferenze stampa di Netanyahu ad uso esclusivo dei giornalisti stranieri per denunciare presunte “fake news”; investimenti da decine di milioni di dollari per la promozione sui social e sui motori di ricerca di contenuti sponsorizzati dall’Agenzia di pubblicità del governo (sì, in Israele esiste: si chiama Lapam e riferisce direttamente all’ufficio del premier).
La campagna digitale lanciata nei mesi scorsi per dire che a Gaza “non c’è fame” è stata vista da oltre 6 milioni di utenti su YouTube e da altrettanti via Google. Stando a documenti pubblicati dal sito indipendente di giornalismo investigativo Dropsite News, in un articolo a firma di Jack Poulson e Lee Fang, il contratto stipulato lo scorso giugno per sei mesi con Google e YouTube dalla Lapam vale 45 milioni di dollari. «I registri mostrano che il governo israeliano – scrivono Poulson e Fang – ha speso allo stesso modo 3 milioni di dollari per una campagna pubblicitaria su X. Anche la piattaforma pubblicitaria francese e israeliana Outbrain/Teads riceverà circa 2,1 milioni di dollari». Un anno fa, la rivista statunitense di tecnologia Wired aveva rivelato l’esistenza di una campagna pubblicitaria israeliana su Google per screditare l’Unrwa. Campagna confermata dal responsabile della Sensibilizzazione pubblica del ministero della Diaspora, Hadas Maimon, il 2 marzo alla Knesset. Iniziative simili vengono condotte per screditare Ong palestinesi, a partire dalla Hind Rajab Foundation (dal nome della bimba uccisa mentre chiedeva aiuto alla Mezzaluna Rossa, dall’auto in cui era chiusa con i cadaveri di sei familiari), descritte come filo-terroristiche. E non c’è solo Gaza: una fase particolarmente frenetica di hasbara si è avuta a giugno in concomitanza con i dodici giorni di guerra contro l’Iran, presentata come essenziale per la sopravvivenza di Israele.
A conti fatti, il risultato è pari alle attese? Il presidente americano Donald Trump ritiene di no: «Israele ha perso la guerra delle pubbliche relazioni». La stampa israeliana è sempre più critica nei confronti del governo, allineandosi con buona parte della società. Ma la “spiegazione” è diretta all’opinione pubblica internazionale e in particolare a quella statunitense filo-israeliana, che oggi tentenna. L’importante è non perdere il sostegno militare degli alleati, che dovranno pur rispondere alle loro piazze reali e virtuali. Fattore essenziale, in tutto questo, sono i giornalisti. Da tenere rigorosamente fuori da Gaza. Capita poi che qualcuno riesca a procurarsi i documenti e sappia leggere i numeri. Facendo, anche in tempi di post-verità, informazione giornalistica”.
Mi piace concludere con una citazione dal libro di Paolo Benanti che ho concluso proprio ieri sera. Dopo un’interessante distinzione tra persuasione e manipolazione, il teologo francescano scrive: “Non si tratta di rincorrere l’utopico desiderio di rimuovere la manipolazione, un fenomeno molto più antico delle piattaforme digitali, ma di riconoscere l’esistenza di diritti cognitivi degli utenti che vanno riservati: le persone hanno diritto a una loro autonomia, nello spazio analogico come in quello digitale. Se si rimuove l’autonomia lo spazio democratico diviene autocratico. Uno spazio digitale non democratico di fatto minaccia anche la democrazia” (Il crollo di Babele, pag. 239).


 questo i miei fratelli mi prendono un po’ in giro. Ho trovato diversi articoli su società che funzionano senza denaro; tali società non favoriscono il consumismo e lo spreco. Penso anche che alcune idee socialiste abbiano radici nel cristianesimo, certo non tutte. Ho letto dell’esperienza dei kibbutz, di quella di Nomadelfia e poi di quella spagnola di Marinaleda sulla quale voglio leggere insieme alla classe un
questo i miei fratelli mi prendono un po’ in giro. Ho trovato diversi articoli su società che funzionano senza denaro; tali società non favoriscono il consumismo e lo spreco. Penso anche che alcune idee socialiste abbiano radici nel cristianesimo, certo non tutte. Ho letto dell’esperienza dei kibbutz, di quella di Nomadelfia e poi di quella spagnola di Marinaleda sulla quale voglio leggere insieme alla classe un