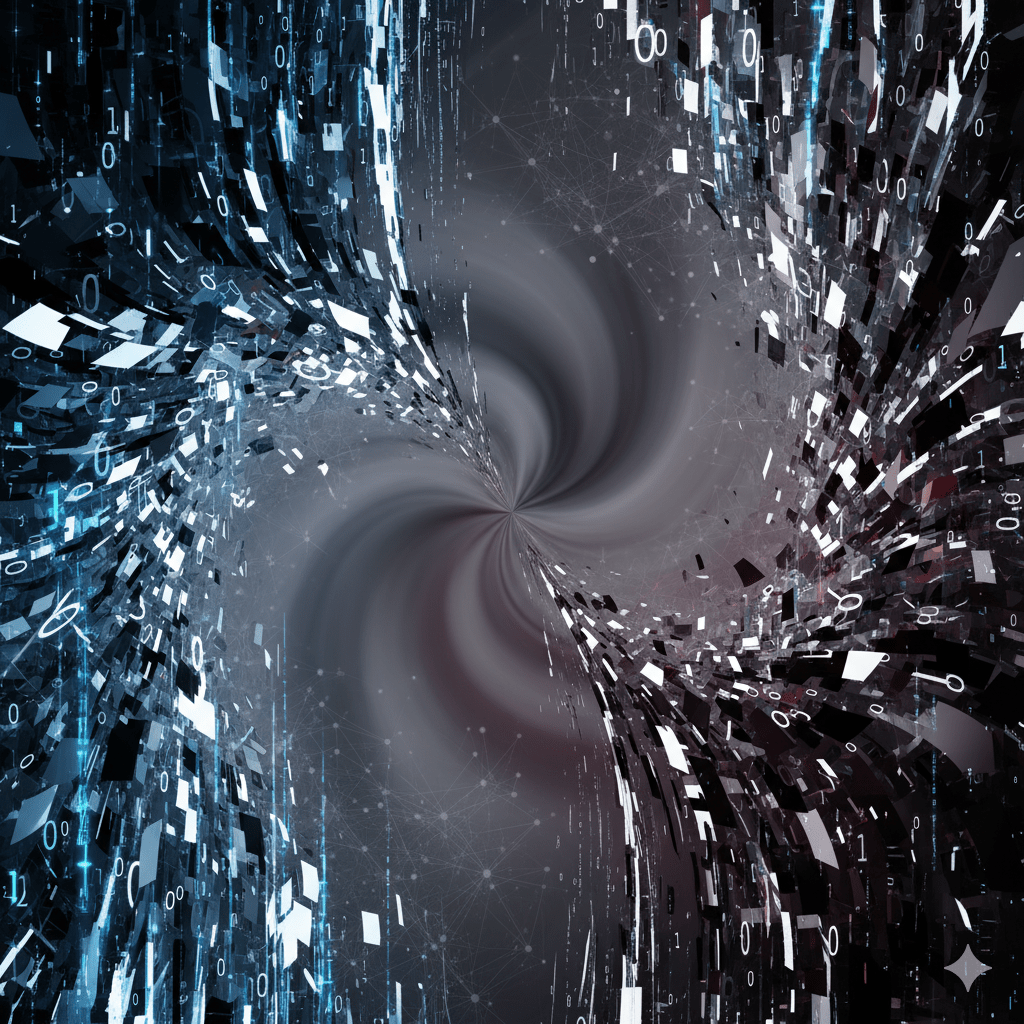I colloqui con i genitori di allieve e allievi di quinta si concentrano spesso sul dopo-liceo, sulle prospettive future: frequentemente raccolgo la preoccupazione di chi non ha ancora deciso, di chi è perplesso, di chi teme la scelta di una strada “sbagliata”. Allora mi capita di raccontare il mio anno e mezzo di scienze geologiche prima di comprendere quale fosse il mio cammino; racconto anche quanto in realtà la strada “giusta” fosse ben delineata dentro di me, nascosta però da mille rovi e arbusti che, nel tempo, l’avevano coperta. Forse sarebbe stato comodo incontrare quel personaggio di cui Alessandro D’Avenia parla spesso quando affronta l’Odissea: un Mentore che mi sapesse consigliare, che mi aiutasse a leggere meglio dentro di me quella risposta di cui andavo cercando. D’altra parte riconosco che quello che talvolta io stesso ho considerato un anno e mezzo buttato via, è stato forse uno dei periodi più fecondi della mia esistenza, perché mi ha aiutato a vedere tutto ciò che non volevo diventare. Intuire chi si vuole diventare, ascoltare una vocazione, accogliere la risposta che noi stessi ci diamo, dare una direzione all’imprevedibile che si palesa: sono tutti verbi declinati all’infinito che richiedono però un risposta che trovi una concretezza finita nell’esistenza.
Lascio allora spazio a un articolo della pedagogista Paola Bignardi, scritto la scorsa settimana su Avvenire.
“Una riflessione dedicata al rapporto dei giovani con il tempo potrebbe avere per titolo semplicemente “I giovani e il futuro”; questa è infatti l’unica dimensione temporale che essi percepiscono: il tempo che hanno davanti a sé. D’altra parte, quello che hanno alle loro spalle è troppo breve per poter costituire una memoria significativa. E il presente? In esso sono immersi, e lo vivono – forse al pari di molti adulti – come una realtà così scontata da non rendersi conto di essa. Se ne rendono conto quando è troppo disordinato, arruffato; in quelle situazioni allora appare che la libertà di occupare il tempo secondo il desiderio del momento o i propri capricci non è per niente appagante. Anche l’istante nel quale sono immersi ha bisogno di ordine, di ritmo, per diventare veramente esperienza di serenità e di crescita. La necessità di una disciplina per la propria vita è difficile da proporre alle nuove generazioni, al di fuori di un contesto che mostri di essa l’utilità e il valore come stile di vita che può restituire tranquillità e armonia alle proprie giornate.
Il tempo verso cui la tensione dei giovani è protesa è il futuro; questa è la dimensione attesa, desiderata. Il futuro è la vita in cui ha inizio l’autonomia, la realizzazione dei propri progetti, dei propri desideri. Non ci sono ancora delusioni e quindi ci si può orientare verso il domani caricandolo di aspettative e di idealità. Anche i ragazzi e le ragazze di oggi guardano al futuro con il desiderio di realizzazione personale e aspirano a una vita piena, serena, in cui poter concretizzare i propri sogni: trovare un lavoro soddisfacente, costruire relazioni autentiche e durature, e “diventare qualcuno” senza perdere la propria autenticità. Per alcuni, l’università rappresenta un passaggio decisivo, ma è anche fonte di incertezza: non sempre le idee sul percorso da intraprendere sono chiare, e prevalgono talvolta la confusione o la paura di sbagliare; ne è riprova il numero di ragazzi e ragazze che dopo il primo anno di università si accorgono di aver intrapreso una strada che non fa per loro e cambiano facoltà, oppure si trascinano lentamente in un percorso culturale che non li soddisfa. Accanto a questo slancio positivo vi è nei giovani uno sguardo preoccupato. Il tema del futuro è più facilmente comprensibile alla luce delle considerazioni svolte qualche settimana fa in queste pagine sul dolore dei giovani. In una ricerca realizzata dall’Osservatorio dell’Istituto Toniolo nel 2013 risultava un dato inquietante: il 67% dei giovani interpellati nell’ambito dell’indagine dichiarava di pensare il proprio futuro come pieno di rischi e di minacce. Si tratta di una percentuale che si è mantenuta stabile nel corso degli anni, con un peggioramento nel periodo della pandemia, quando la fiducia nel futuro si è abbassata significativamente, mostrando nella popolazione femminile la componente più fragile e più sensibile alle ragioni della paura. In una ricerca attualmente in corso sul territorio delle diocesi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto la situazione sembra essere ancor più severa. I giovani che hanno dichiarato di guardare al futuro con preoccupazione e incertezza sono il 71%, cioè quasi tre quarti degli interpellati.
La pandemia, le crisi economiche, le guerre e il cambiamento climatico incidono profondamente sulle nuove generazioni. «Ho ansia e paura per il futuro – dice un giovane diciottenne –, il mondo è a rotoli». La sottile sfiducia verso gli adulti e soprattutto verso le istituzioni accentua il senso di precarietà e l’incertezza della realizzazione dei propri progetti e obiettivi. Le cause sociali e strutturali si riflettono sul piano individuale e danno forma a un interrogativo sulla propria persona, sulla propria identità. Dice un giovane ventiduenne: «Che futuro avrò? Che persona sarò? Chi sarò tra 5-10 anni, domani? Troverò una svolta nella mia vita?». Al tempo stesso vi è nelle ragazze e nei ragazzi di oggi la consapevolezza del delicato valore della loro età e della loro condizione. Dice una giovane: «Attraverso l’adolescenza so che da una bozza di ciò che sono ora può uscire un capolavoro». È come sentirsi un prezioso vaso di cristallo che prende forma a poco a poco nelle mani di un artigiano che, per quanto esperto, corre sempre il rischio di spezzarlo. Ragioni esterne e interiori si intrecciano; per qualcuno troppo fragile questa situazione diventa una sfida insostenibile; per molti, motivo per approfondire le proprie ragioni, il proprio atteggiamento di fronte alla vita, per rendere più mature le proprie scelte. Dietro la paura del futuro c’è spesso una domanda spirituale implicita: «Perché vale la pena vivere, impegnarsi, sperare?». Anche nell’inquietudine rispetto al futuro molti giovani esprimono la loro domanda di senso, la loro inquietudine spirituale, che spesso non approda alle forme religiose tradizionali ma che rivela tratti di una nuova ricerca: di relazioni autentiche, di cura del sé, di connessione con la natura, di armonia interiore, di giustizia sociale. Pensare a un futuro pieno di rischi e di incognite non significa restare di fronte a esso passivi e rassegnati, ma piuttosto consapevoli. I giovani oggi sanno che il futuro non verrà loro incontro in maniera scontata, ma richiederà loro impegno, intelligenza, determinazione. La complessità del futuro spaventa meno quei giovani che possono far conto su una famiglia accogliente, presente, capace di dialogo; questi si sentono meno soli davanti all’ignoto e alla loro paura di fallimento. In contesti familiari fragili, soprattutto dal punto di vista relazionale, l’incertezza del futuro rischia di essere vissuta come minaccia concreta, più che come sfida potenziale.
Accanto alla famiglia, il sostegno per guardare al futuro con fiducia sono gli amici. Nella ricerca citata, che riguarda un migliaio di adolescenti, gli amici vengono continuamente riferiti come la principale fonte di sostegno emotivo, più della famiglia e spesso più delle istituzioni scolastiche o religiose. Il futuro smette di essere un nemico quando lo si affronta “insieme”. I rapporti amicali 1possono aiutare perché costituiscono la grande risorsa del mondo giovanile. L’amicizia è una delle forme principali di spiritualità vissuta: è un luogo di fiducia, di presenza, di dono reciproco. Molti giovani che si dichiarano “non religiosi” trovano proprio nell’amicizia quell’esperienza del bene gratuito che un tempo veniva mediata da contesti religiosi o comunitari. L’amicizia diventa così un luogo del bene gratuito, una via relazionale alla fiducia, in cui il futuro non appare più come una minaccia ma come un cammino condiviso. Anche attraverso l’amicizia l’inquietudine verso il domani rappresenta la porta che apre a un’esperienza spirituale. «La serenità in famiglia e il sostegno dei miei amici – dice un ragazzo – costituiscono l’aiuto più concreto per affrontare il futuro». In una società dove le istituzioni tradizionali – famiglia, scuola, religione – faticano a offrire orizzonti stabili, gli amici diventano il luogo in cui si impara che il futuro non si affronta da soli, ma si può affrontare insieme. L’orizzonte di senso dei giovani non è individualista ma relazionale. L’incertezza del futuro non è eliminabile, ma è abitabile se è possibile viverla nel sostegno reciproco. In questa prospettiva, ciò che potrebbe aiutare i giovani ad affrontare il futuro in modo più positivo non è tanto una – improbabile – promessa di stabilità, quanto la possibilità di radicarsi in legami significativi e in una visione di sé che dia direzione e valore all’imprevedibile e ne trasformi il potenziale distruttivo in una risorsa per crescere.”