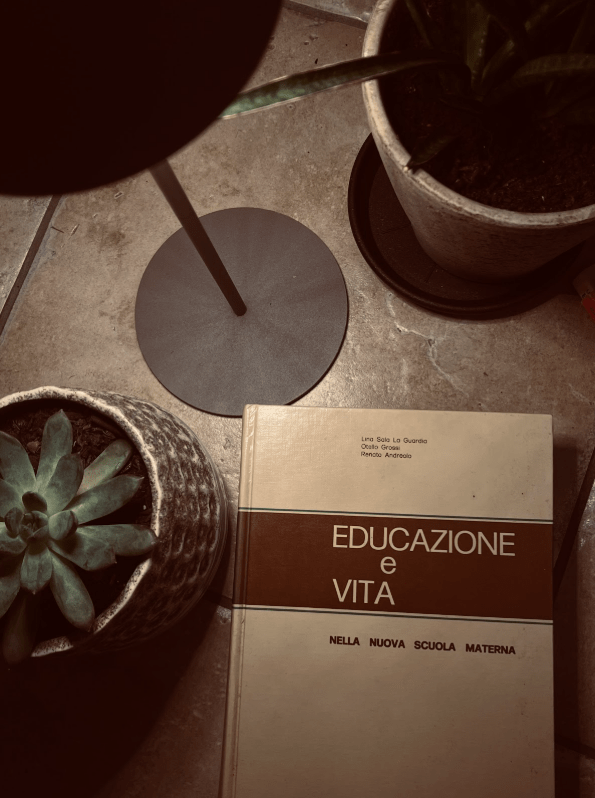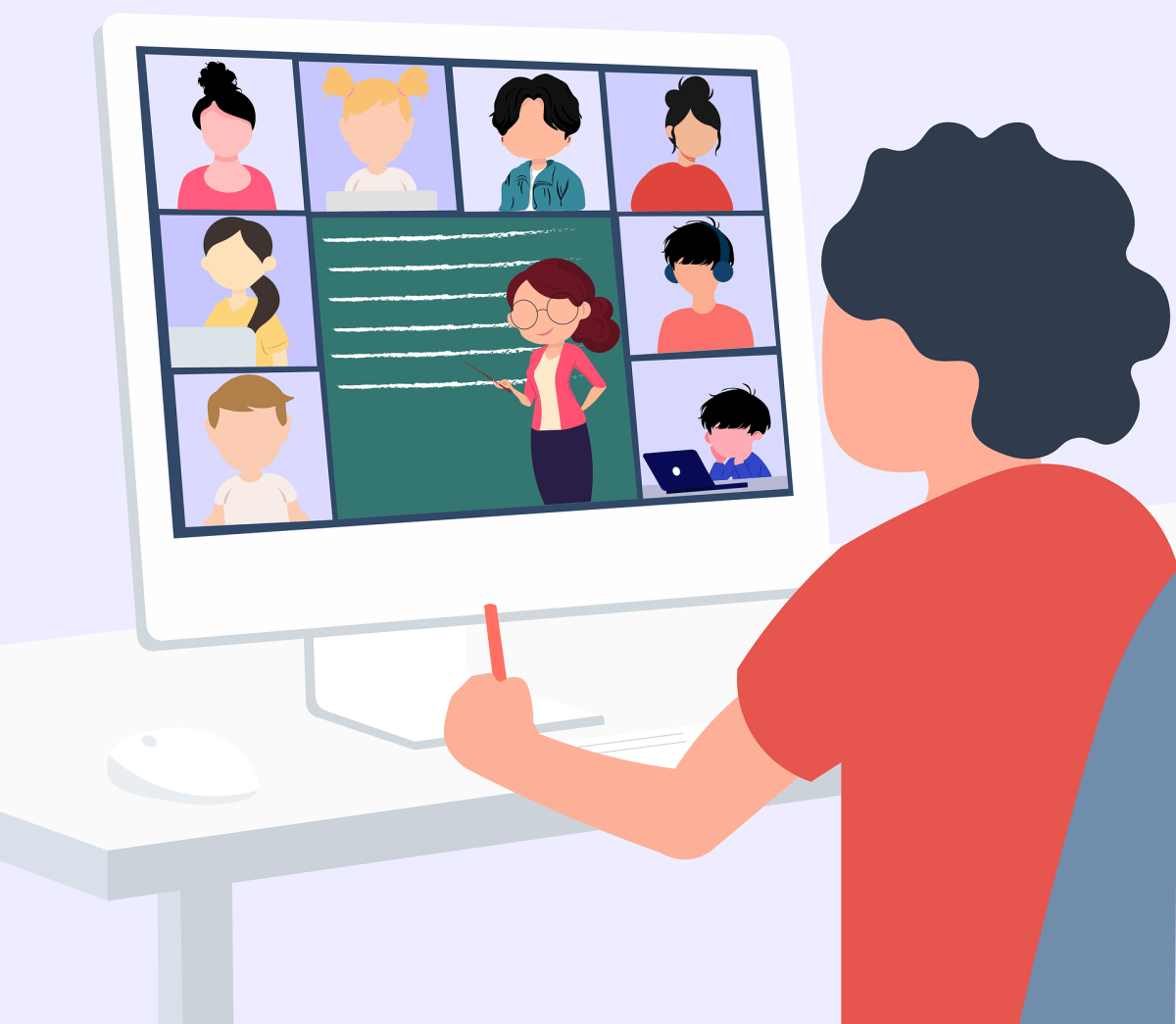Questo post è rivolto non tanto agli studenti quanto a colleghi e a chiunque si occupi di istruzione e cultura. Durante una piccola discussione su twitter, il professor Piero Dominici, che gestisce la rubrica “Fuori dal prisma” su Il Sole24ore, mi ha segnalato questo suo bellissimo articolo, molto interessante (i grassetti sono miei). Penso che non sarebbe male se, almeno ogni tanto, i Collegi Docenti si confrontassero su questi argomenti. Sì, mi piace sognare…
“Ripartiamo, e articoliamo, una nostra riflessione sviluppata a partire da un post di Luca De Biase (che ringrazio ancora per lo spunto) su questioni che ritengo, a dir poco, cruciali e strategiche per il tentativo di rilanciare questo Paese; questioni a “parole” considerate importanti ma, nel momento dei “fatti” e delle scelte politiche, (spesso) non riconosciute, fino in fondo, come tali. Tanto da far pensare “altro che società della conoscenza…” (si veda p.e. l’ultimo Rapporto OCSE sull’istruzione). E allora, abbiamo provato a ragionare, in quel caso, e Fuori dal Prisma intende riproporre quella riflessione (aggiornata), sulla ben nota “questione culturale” – spesso evocata ma non argomentata – e sulle relative implicazioni. A cosa intendiamo riferirci quando affermiamo che “la questione è culturale”? Proveremo a riflettere e ad evidenziare come, non solo tale questione riguardi da vicino l’ipercomplessità sociale, ma costituisca di fatto un indicatore da non sottovalutare nell’analisi dei sistemi sociali e della loro resilienza al mutamento. Una complessità sociale che sfugge ai tradizionali dispositivi di controllo e sorveglianza e che richiederebbe, come in passato ho avuto modo di argomentare più volte, una riformulazione del pensiero ed una ridefinizione dei saperi che dovrebbero contribuire proprio a ridurre tale complessità, definendo, quanto meno, condizioni di prevedibilità dei comportamenti all’interno ed all’esterno delle organizzazioni e dei sistemi: in tal senso, Edgar Morin parla di “riforma del pensiero”: «La riforma del pensiero esigerebbe una riforma dell’insegnamento (primario, secondario, universitario), che a sua volta richiederebbe la riforma di pensiero. Beninteso, la democratizzazione del diritto a pensare esigerebbe una rivoluzione paradigmatica che permettesse a un pensiero complesso di riorganizzare il sapere e collegare le conoscenze oggi confinate nelle discipline. […] La riforma del pensiero è un problema antropologico e storico chiave. Ciò implica una rivoluzione mentale ancora piú importante della rivoluzione copernicana. Mai nella storia dell’umanità le responsabilità del pensiero sono state così enormi. Il cuore della tragedia è anche nel pensiero». Perché scuola e istruzione non di qualità (concetto che andrebbe sciolto) creano le condizioni strutturali per una società diseguale, non in grado di garantire neanche le condizioni di eguaglianza delle opportunità di partenza. L’argomento è estremamente delicato e difficile da sciogliere per le tante implicazioni. Certamente possiamo partire da un assunto: esiste una stretta correlazione tra scuola/istruzione e una cittadinanza realmente attiva e partecipata (ne abbiamo parlato anche in un altro post), a maggior ragione in sistemi sociali, come il nostro, caratterizzati da scarsa (per non dire inesistente) mobilità sociale verticale e da un familismo (im)morale diffuso che rendono ancora questa società fortemente corporativa e resiliente al (vero e profondo) cambiamento e all’innovazione sociale. Nelle società avanzate (non solo), scuole, istruzione e formazione rappresentano da sempre le uniche possibilità di riscatto sociale e di miglioramento della propria condizione sociale di partenza; ancora di più lo potrebbero/dovrebbero essere in una società rigidamente strutturata…insomma gli unici “ascensori sociali”, ormai (purtroppo) quasi del tutto bloccati da tempo: la crisi dei sistemi di welfare completa un quadro estremamente problematico che, nel rendere la precarietà condizione esistenziale, ha determinato un indebolimento dei meccanismi di solidarietà, mettendo in discussione anche il diritto alla conoscenza delle persone (cittadini). «C’è un’inadeguatezza sempre più ampia, profonda e grave tra i nostri saperi disgiunti, frazionati, suddivisi in discipline da una parte, e realtà o problemi sempre più polidisciplinari, trasversali, multidimensionali, transnazionali, globali, planetari dall’altra. In questa situazione, diventano invisibili: gli insiemi complessi; le interazioni e le retroazioni fra le parti e il tutto; le entità multidimensionali; i problemi essenziali» (Edgar Morin).
Sinteticamente, propongo alcune considerazioni per sottolineare l’assoluta rilevanza delle questioni, scusandomi in anticipo, per la semplificazione di alcune di queste che meriterebbero ben altro approfondimento…Procedo per punti.
1) Il nostro è un Paese dal quadro normativo e legislativo complesso e articolato: esistono molte leggi (forse, troppe), codici professionali, carte deontologiche, linee guida, sistemi di regole formali, sistemi di orientamento valoriale e conoscitivo. Eppure questi “strumenti” si sono rivelati condizione necessaria ma non sufficiente, perché esiste una dimensione, cruciale e fondante allo stesso tempo, che è quella della responsabilità; una dimensione che sfugge a qualsiasi tipo di “gabbia” e/o sistema di controllo, perché attiene proprio alla libertà delle persone (altro discorso da approfondire, legato al tema dell’emancipazione nella modernità: interessante il concetto di “libertà generativa”). E da questo punto di vista, come non essere d’accordo con chi afferma che viviamo in una “società degli individui”, che sentono di non dover rispondere a nessuno dei loro atti, tanto meno ad una “comunità” i cui legami si sono fortemente indeboliti (e c’è chi parla di fine del legame sociale). Qualche anno fa, intitolai un mio libro “La società dell’irresponsabilità” proprio per connotare questa condizione critica, ricollegabile solo in parte alla crisi economica (o ad indicatori di tipo economico): la “questione culturale” mette in luce, ancora una volta, non solo la crisi delle istituzioni formative, ma anche la debolezza dei vecchi apparati e delle vecchie logiche di controllo e repressione che non risolvono mai i problemi alla base; che sono sempre strategie di “breve periodo” (cultura dell’emergenza vs. cultura della prevenzione, a tutti i livelli e in tutti i settori della prassi). Dobbiamo confrontarci con una “natura” intrinsecamente problematica e complessa dei sistemi sociali, non più riconducibile alle sole categorie (significative) di rischio, incertezza, vulnerabilità, liquidità etc. A ciò si aggiunga che, quasi paradossalmente, mai come in questi anni si è discusso (e si discute) di etica e di responsabilità in tutti i campi dell’azione sociale (dalla politica alla cultura, dall’informazione all’innovazione scientifica e tecnologica etc.).Si potrebbe semplificare tale paradosso con la “formula”: trionfo dell’etichetta sull’etica. Paese di paradossi e contraddizioni (non soltanto sul piano culturale): da una parte, per ogni “nuovo” problema si invocano subito nuove leggi, nuovi codici deontologici, nuove prescrizioni, nuovi divieti; dall’altra, culturalmente, consideriamo quelle stesse leggi, norme,“regole” come un ostacolo alla nostra autoaffermazione ed al nostro successo/prestigio sociale. D’altra parte, ciò che spesso sembra venire a mancare è proprio la coerenza dei comportamenti che, comunicativamente parlando, risulterebbe (è!) molto più efficace delle parole e dei principi spiegati attraverso un linguaggio, più o meno, politicamente corretto. Da questo punto di vista, come peraltro sottolineato da più parti, siamo di fronte ad una vera e propria “emergenza educativa” legata ad una molteplicità di fattori e variabili, che hanno determinato una trasformazione profonda dei processi di socializzazione ed una crisi delle tradizionali agenzie/istituzioni deputate all’interiorizzazione dei valori ed alla formazione delle personalità/identità (riconoscimento-rispetto-altruismo-senso civico-cittadinanza vissuta e non subita). Mi riferisco, in tal senso, al concetto di “policentrismo formativo” e richiamo Luca quando sottolinea l’urgenza di “disegnare percorsi di apprendimento pensati per queste materie per ricucire un’evoluzione culturale che per alcuni aspetti si è interrotta con l’interruzione di alcune relazioni tradizionali…”. Questo Paese non ripartirà senza affrontare seriamente tali problematiche: credo di non dover neanche argomentare la correlazione strettissima esistente tra istruzione (accesso,condivisione) e cittadinanza. In questa sede, si discute dei “cittadini di domani” che corrono seriamente il rischio di crescere e socializzarsi ad una cultura della furbizia, dell’illegalità e/o del familismo amorale (apparentemente?) dominante.
2) La “questione culturale”, qui più volte richiamata, è legata come detto anche, e soprattutto, ad un problema di interruzione/crisi della comunicazione tra le generazioni (concetto che andrebbe sciolto e sviluppato). Tuttavia, in questa prospettiva di analisi, non possiamo non registrare come i media (vecchi e nuovi, per non parlare dei social networks) – con il famoso “gruppo dei pari” – si siano letteralmente divorati lo spazio comunicativo e del sapere (?) gestito, in passato, della tradizionali istituzioni e agenzie educative e formative.
3) Sugli attori sociali e sulle professionalità protagoniste del processo educativo e formativo sono forse radicale, ma preferisco sempre dire apertamente ciò che penso (va precisato che, in questi ultimi decenni, scuola e università sono state pesantemente penalizzate da tagli e controriforme). Ci sono lavori/professioni che andrebbero fatti/scelti anche, e soprattutto, perché si avverte una “vocazione” e non soltanto per una forma di prestigio sociale e/o perché permettono magari di esercitare forme di micropotere sugli altri. ”Prendersi cura” di una persona (concetto complesso), insegnare, formare, condividere ed elaborare non significa soltanto trasmettere e/o impartire nozioni: i figli, gli studenti e, più in generale, i giovani – come dire – ti aspettano al varco, osservano “come ti comporti”. Insomma, contano i “fatti”, non le “parole”. La “tua” (nostra) credibilità e autorevolezza si fonda sui comportamenti e sulla loro coerenza rispetto a quanto affermiamo (problema che riguarda anche la politica). Se chiedi correttezza, devi darla per primo, se pretendi rispetto e senso di responsabilità, devi prima di tutto essere rispettoso dell’Altro e responsabile etc., anche se la relazione è asimmetrica a causa del ruolo e della gerarchia. E non puoi fingere, non nel lungo periodo. Ecco perché certi “ruoli” e certe “attività” richiedono, a mio avviso, consapevolezza, partecipazione, passione, perfino empatia (oltre alla preparazione!). E’ necessario “mettersi in gioco” puntando sull’inclusione dell’ALTRO. Fondamentale, quindi, ripartire da educazione e istruzione, basandole però su una ridefinizione della “qualità” della relazione tra gli attori dell’ecosistema formativo e comunicativo – nel rispetto dei reciproci ruoli (genitore, insegnante, docente etc.) – oltre che, evidentemente, sulla preparazione e sulle competenze.
E, nel lungo periodo, per far questo abbiamo bisogno di “teste ben fatte”(Montaigne), e non di “teste ben piene”, che sappiano organizzare le conoscenze all’interno del nuovo ecosistema cognitivo (2005), altrimenti anche le opportunità della tecnologia saranno per pochi. E, come scrissi qualche anno fa, sarà la “società dell’ignoranza” e dell’incompetenza (non solo digitale…)->POTERE=CONOSCENZA”