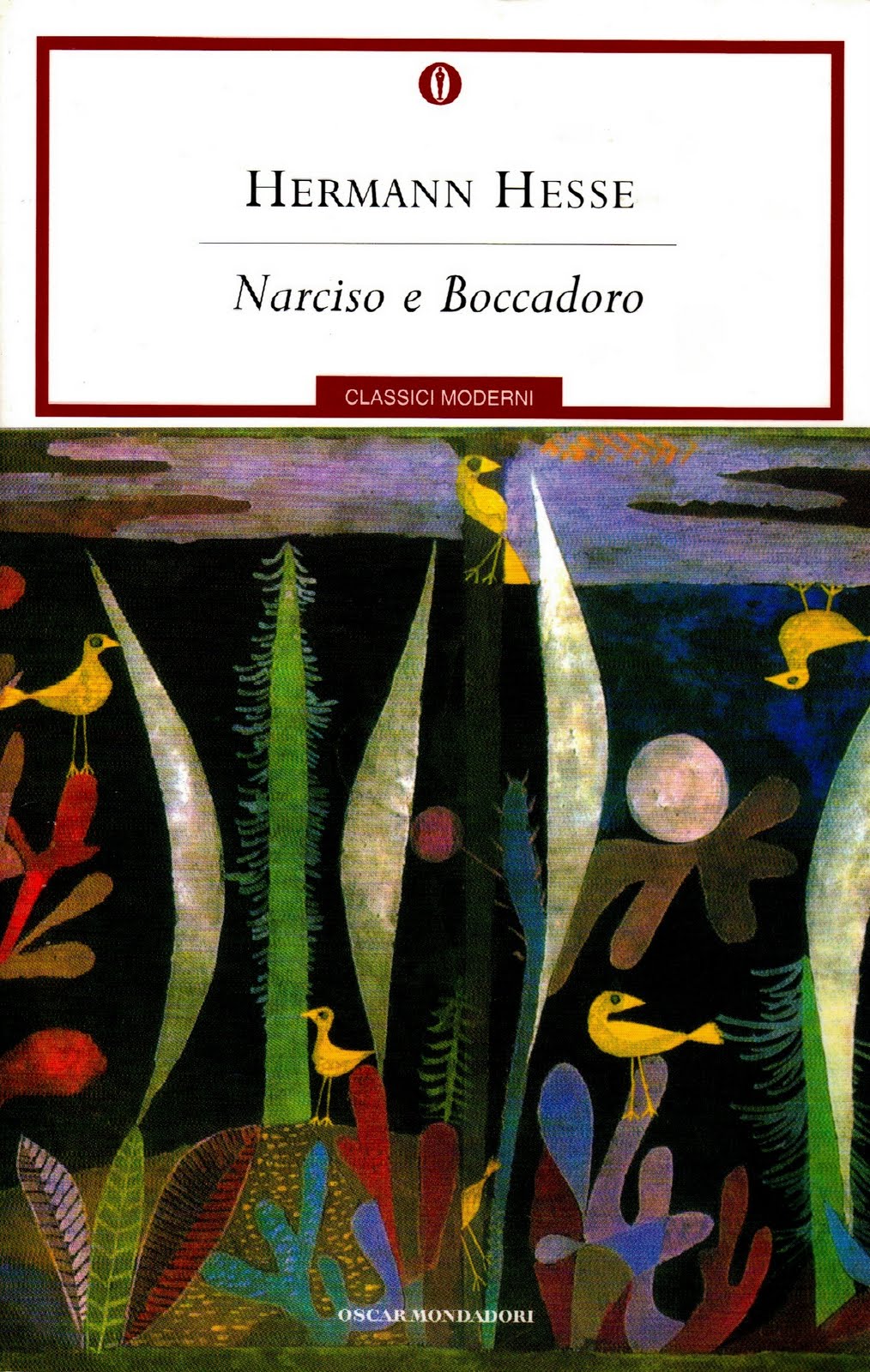Già ultimamente sto pubblicando poco sul blog, se poi, quando lo faccio, propino testi di questa lunghezza, capisco benissimo di non agire da buon blogger. Pazienza…
Già altre volte ho postato sul tema della post-verità, della verità, della libertà di opinione ed espressione; oggi mi sono imbattuto in una intervista/riflessione a più voci decisamente interessante. La pubblico interamente; la fonte è il Tascabile e la firma è del filosofo e ricercatore alla University College di Dublino Fabio Gironi.
“Uno dei fenomeni sociali che caratterizza maggiormente la scena pubblica e politica sembra essere il disinteresse per l’opinione degli esperti, e il proliferare di “teorie alternative”. In gergo filosofico, questo fenomeno si può definire deflazione dell’autorità epistemica. Questa è una forma di autorità conferita non da status sociale, lignaggio nobiliare, o investitura divina, ma dall’esperienza in un determinato campo del sapere. L’autorevolezza del biologo, dello storico, ma anche dell’ingegnere meccanico e dell’agricoltore, dipende dal livello di studio e preparazione teorica, dall’esperienza pratica diretta, e dall’essere parte di una comunità epistemica (un gruppo di persone che condividono determinati obiettivi, e dediti allo stesso tipo di attività o ricerca) capace di valutare le proprie conoscenze.
Quello che movimenti differenti come l’anti-vaccinismo, il negazionismo del cambiamento climatico antropogenico, o proposte di “medicina alternativa” hanno in comune è un tratto fondamentale: lo scetticismo sistematico verso gli esperti, visti come collusi con “poteri occulti”, che nei casi più eclatanti sfocia in un aperto anti-intellettualismo. Questo fenomeno riflette una visione del mondo diviso in una classe di “studiosi” sedicenti esperti, e una di gente dotata di senso comune – dove quest’ultimo viene considerato come un valido sostituto alla competenza specifica.
Insieme ai diffusi fenomeni di echo chamber e filter bubble (comunità virtuali chiuse all’influenza esterna che permettono la proliferazione di notizie non sostanziate dai fatti) la perdita di fiducia nell’autorità epistemica sta producendo un cambiamento nel concetto stesso di verità dei fatti. Certamente, le menzogne non sono una novità del ventunesimo secolo: già nel 2005 il filosofo Americano Harry Frankfurt apriva il suo breve saggio “Stronzate” osservando come “uno dei tratti più salienti della nostra società è che circolino così tante stronzate”, differenziando la stronzata dalla menzogna. La prima non è solamente un capovolgimento intenzionale della verità ma dipende da un sistematico svuotamento del concetto di verità, e una studiata indifferenza rispetto ai fatti.
Ma è anche vero che la propagazione di stronzate raggiunge oggi livelli altissimi: è ovvio che certe verità non siano tali, perché l’affermazione vera è meno importante di quella efficace. Questo fenomeno è esemplificato dal ben noto termine “post-verità”: parola dell’anno nel 2016 per l’Oxford Dictionaries, questo aggettivo è definito “relativo, o che denota, circostanze in cui i fatti oggettivi hanno meno influenza nel formare l’opinione pubblica rispetto ad appelli a emozioni o credenze personali”. Altrettanto famosi ormai sono sia il termine (intrinsecamente ossimorico) alternative facts, che l’espressione fake news, entrambi contributi dell’amministrazione Trump negli Stati Uniti.
Considerato come queste distinzioni (fatti vs finzioni, verità vs menzogna) così familiari ai filosofi, abbiano oggi fatto irruzione nelle nostre discussioni quotidiane, abbiamo voluto esaminare la situazione contemporanea insieme a quattro filosofi e filosofe esperti di questioni epistemologiche: Maria Baghramian, della University College Dublin; Mario De Caro dell’Università di Roma Tre; Gloria Origgi dell’Institut Nicod dell’Ecole Normale Supérieure, e Nicla Vassallo, dell’Università degli Studi di Genova.
Alcuni critici hanno tracciato la genesi della situazione presente, più o meno esplicitamente, al clima culturale del recente passato, in particolare all’eredità del post-strutturalismo e di altre posizioni filosofiche che hanno promosso un approccio critico verso le nozioni di autorità e di verità. Ogni movimento filosofico deve essere collocato nel suo contesto storico-sociale, ed è evidente che “il postmodernismo” rispondesse a delle precise preoccupazioni socio-politiche, primo tra tutti, in campo politico, lo spettro dei dispotismi autoritari che hanno dominato la metà del ventesimo secolo (il celebre, e spesso incompreso, rifiuto delle metanarrazioni). L’ironia è che ora viene accusato di aver riprodotto lo stesso problema, rendendo qualsiasi narrazione degna di fiducia. È giusto accusare questo momento intellettuale dei mali presenti?
GLORIA ORIGGI
Il post-modernismo è un aggregato di idee di avanguardia di provenienza diversa, estremamente influente nell’arte contemporanea, nella letteratura del dopo-guerra e in una serie di esperienze artistico-politiche, spesso di natura provocatoria, necessarie però per scuotere una cultura vecchiotta, incapace di auto-osservazione e tipicamente egemonica. Non demonizzerei il post-modernismo nei contenuti, almeno non più di quanto si possa fare con i tanti movimenti di avanguardia che hanno attraversato il ventesimo secolo, con successi e insuccessi. Non c’era una verità da mettere in discussione, ma un’egemonia conoscitiva che passava dai banchi di scuola, dal sapere diffuso dai musei, dal cinema e poi dalla televisione e che andava sicuramente ripensata dopo i disastri di due guerre mondiali e di più di un secolo di colonialismo. I toni assurdi, provocatori, le boutades, le trasgressioni hanno avuto effetti positivi e negativi. Sicuramente un effetto positivo è stato quello di includere nel discorso culturale “alto”, personaggi, esperienze, culture, minoranze che a questo discorso non avevano accesso. Un altro innegabile effetto positivo è stato quello di sviluppare una coscienza critica nei confronti dei propri atti culturali e svelare la dimensione spesso politica o economica di tutte le espressioni culturali. Le conseguenze negative sono state un generale impoverimento dell’esperienza culturale, uno scetticismo verso la qualità intrinseca dell’oggetto culturale che ha fatto sì che da movimento di avanguardia, il postmodernismo si allineasse con le esperienze culturali più “leggere” della nostra società, come la pubblicità o il marketing. E insieme una tendenza paranoica collettiva a leggere in termini manipolatori qualsiasi proposta conoscitiva. Movimento tendenzialmente “di sinistra”, il postmodernismo è stato purtroppo reclutato “a destra” per legittimare la decimazione degli studi umanistici nelle università di tutto il mondo, visti come ricettacolo di idee paranoiche e estremiste volte ad abbattere il canone culturale occidentale. L’accusa che rivolgo al post-modernismo è più che altro questa: che, grazie alla sua faciloneria intellettuale ha delegittimato le scienze umane, rendendosi complice di un generale impoverimento del sapere, di un “clash” tra cultura scientifica e cultura umanistica e di una tecnicizzazione della conoscenza che ci rende tutti più stupidi. Non bisogna però confondere le derive postmoderniste dall’idea di Lyotard di condizione postmoderna. Quella fu una vera intuizione. E noi oggi siamo in una condizione postmoderna, per navigare la quale il postmodernismo come movimento di idee non ci aiuta per niente, ma neanche il tentativo ingenuo (penso al nuovo realismo) di ritrovare una realtà intatta, un terreno sicuro a cui ancorarci come dei naufraghi a una zattera.
MARIA BAGHRAMIAN
Diversamente da molti miei colleghi sul fronte continentale, non ho mai apprezzato molto le virtù del postmodernismo, in particolare considerando i suoi proclami di rappresentare un momento progressivo, e politicamente sovversivo, della nostra vita intellettuale. Il mio rigetto del postmodernismo ha dei paralleli con la mia critica del relativismo, un tema chiave della mia ricerca degli ultimi trent’anni. Da una parte, mi sono sempre opposta a un troppo semplicistico rifiuto del relativismo come incoerente o contraddittorio, ma dall’altra ho sempre rifiutato con forza l’identificazione di un’attitudine relativistica con una politica progressista. Il relativismo è un framework concettuale molto sfuggente, che può condurre a quietismo e inazione, ma può anche essere adottato a fini autoritari e regressivi. Non dobbiamo dimenticarci che Mussolini era un convinto relativista, e che i Nazisti proposero una forma di relativismo razziale. I pensatori postmoderni, attraverso aforismi e metafore piuttosto che tramite argomentazioni filosofiche tradizionali, hanno messo in dubbio alcuni precetti fondamentali del discorso culturale, che si concentra sui temi della ragione, e della ricerca razionale. Facendo ciò, hanno occupato lo stesso terreno intellettuale del relativismo. Questo, secondo me, è stato il loro più grande difetto. Il postmodernismo ha “problematizzato” (come si dice in gergo) le idee di oggettività, verità, e logica, con l’obiettivo – si diceva – di liberarci dalla schiavitù della ragione, imposta dall’Illuminismo. Quest’ultimo viene presentato come un movimento monolitico e autoritario alleato con l’imperialismo occidentale e il colonialismo, mentre il postmodernismo sarebbe alleato alla lotta per l’emancipazione da ogni tipo di tirannia. Per molti postmodernisti l’Illuminismo – accompagnato dalla fiducia nella forza della ragione e della razionalità, e l’ottimismo nei confronti della possibilità di emancipare la specie umana – divenne un nemico politico e sociale. I critici postmoderni della scienza, delle sue pratiche e istituzioni hanno ragione a enfatizzare i meccanismi di esclusione presenti in essa. Le donne, le persone di colore, e altri gruppi marginalizzati sono stati sistematicamente esclusi, sottovalutati e umiliati. Ma le ragioni di queste esclusioni sono opposte a quelle proposte dal postmodernismo. Che la conoscenza è potere è un’antica ma profonda intuizione riguardo al ruolo che la conoscenza gioca all’interno della nostra vita sociale e politica. Gli uomini bianchi al potere hanno usato la scienza e le norme razionali per escludere le donne e gli “altri differenti” dai centri di conoscenza che si affidano proprio a queste norme. Il responso a queste pratiche di esclusione non deve essere quello di abbandonare i potenti proclami della conoscenza scientifica, ma di rivendicarli a sé. Ad esempio, le donne in Iran stanno riuscendo in questo intento, riempiendo i campi STEM nelle università del paese, tradizionalmente riservati agli uomini.
È possibile che l’overdose di informazioni di cui il pubblico è oggi bombardato tramite i media digitali produca un rilassamento della distinzione tra verità e finzione? È concepibile che ci siano specifici limiti cognitivi che, in quanto esseri umani, limitano la nostra capacità di filtrare ed elaborare un numero così grande di informazioni, spesso contraddittorie?
GLORIA ORIGGI
Non capisco quale sia stata l’età dell’oro in cui la gente credeva nella realtà invece che nelle finzioni. La quantità di stronzate che l’umanità è sempre stata disposta a credere non credo sia aumentata con l’avvento di Internet. È forse solo più visibile. Ma è vero che le società a forte densità informazionale come le nostre società tardo-moderne hanno effetti epistemici propri: paradossalmente, come ho cercato di mostrare nel mio lavoro, più l’informazione aumenta, più la reputazione delle fonti di informazione diventa rilevante, anzi, indispensabile per navigare un mare troppo fitto di informazioni. Un’epistemologia del presente deve dunque fornire gli strumenti per distinguere indizi reputazionali farlocchi da indizi reputazionali robusti, un lavoro ancora da cominciare che sarà sicuramente al centro della ricostruzione di un metodo sociale, condiviso e razionale di distinguere la qualità epistemica dell’informazione che ci attraversa ogni giorno.
MARIA BAGHRAMIAN
Anche io penso che la profusione di dati e informazioni odierna ha esacerbato un problema pre-esistente e perenne, quello di dover prendere una decisione riguardo a idee e fonti di informazione in contrasto tra loro. Il problema non è, o non dovrebbe essere, formulato in termini di un rilassamento della distinzione tra verità e menzogna. Questa distinzione, mi sembra che sia implicita nella nozione stessa di modi di pensare giusti e sbagliati riguardo a ciò che succede. Il problema risiede piuttosto nel nostro non avere sufficienti strumenti epistemici per distinguere le informazioni vere da quelle false, o fuorvianti. E parte del problema risiede nel minor prestigio dato oggi alla testimonianza degli esperti. La maggior parte delle cose che sappiamo deriva da ciò che abbiamo imparato dalle testimonianze ricevute da altre persone. La testimonianza degli esperti – coloro che hanno un livello di competenza e di conoscenza maggiore del nostro – è una delle fonti più importanti di conoscenza. La democratizzazione dell’informazione resa possibile da Internet, e la facile reperibilità di moltissime testimonianze di “esperti” su qualsiasi argomento, ha finito con l’indebolire il ruolo tradizionale della testimonianza come fonte di conoscenza. Con un click possiamo (o almeno ci piace pensare che possiamo) controllare e mettere in questione i consigli che ci vengono dati dai nostri dottori, i nostri avvocati, consulenti finanziari e altri tipi di esperti tradizionali. In ultima analisi, credo che l’egualitarismo epistemico nell’era dei big data sia uno sviluppo positivo, ma come tutte le rivoluzioni, questa rivoluzione informatica ha portato con sé grande insicurezza riguardo alle fonti dell’autorità, affidabili o meno.
La maggior parte delle verità scientifiche non si possono leggere direttamente guardando i fatti, ma richiedono sovrastrutture teoriche, discussioni, e interpretazione dei dati per essere stabilite con certezza, e di conseguenza non si può concepire una comunità scientifica senza un certo disaccordo interno. Come si può comunicare questo processo al pubblico senza produrre, da una parte, un ulteriore scetticismo nei confronti della scienza, o, dall’altra, la convinzione che, se il disaccordo produce conoscenza scientifica, chiunque può essere in disaccordo con il consenso scientifico?
MARIA BAGHRAMIAN
Sono d’accordo, il disagreement è essenziale alla scienza e contribuisce positivamente a essa. Le cose si complicano quando ci si affida alla scienza e agli scienziati per consigli riguardo a decisioni politiche. Ovviamente, non è possibile prendere nessuna decisione coerente sulla base di opinioni scientifiche discordanti. In più, la fiducia che di solito accordiamo a scienziati e risultati scientifici pertinenti a questioni impersonali e su larga scala viene erosa laddove questi prendono posizione su questioni che hanno un impatto diretto sulla nostra vita e sul nostro benessere. Bisogna ricordare che quello di affidarsi a scienziati per decisioni di carattere politico è un fenomeno relativamente nuovo. La maggior parte degli storici della scienza considera la Seconda Guerra Mondiale come il punto di svolta, un periodo che cambiò radicalmente il rapporto tra governi e consulenti scientifici. Le necessità portate dalla guerra moderna crearono forti legami tra scienza e legislatura, come venne dimostrato in maniera lampante dal Progetto Manhattan negli Stati Uniti, e da Bletchley Park nel Regno Unito. Le famose parole di Robert Oppenheimer “Sono diventato Morte, il distruttore di mondi”, citando la Bhagavadgita, influenzano ancora oggi la nostra percezione del rapporto tra scienza e stato. Mentre dunque il pubblico è disposto a dare fiducia agli scienziati per quanto riguarda questioni tecniche, si sente anche giustificato a sospendere questa fiducia laddove i loro risultati scientifici siano direttamente legati alle nostre vite quotidiane. La soluzione non è quella di nascondere il dissenso tra scienziati (come a volte si è provato a fare), o credere che la situazione verrà rettificata quando il pubblico riceverà una chiara e precisa educazione scientifica. Piuttosto, la soluzione risiede nell’assicurarsi che le istituzioni scientifiche e gli scienziati siano consapevoli della sensazione di vulnerabilità avvertita dal pubblico di fronte alla potenza della scienza.
GLORIA ORIGGI
Come hanno già detto molti filosofi, penso per esempio a Richard Rorty, la scienza può ispirare la gente comune come “modello” di attività epistemica ed etica: il fatto che nelle varie discipline esistano disaccordi più o meno rispettati, e che i disaccordi producano uno sforzo collettivo per andare più lontano nella comprensione, può essere un esempio di etica della conoscenza che ispira, ma certo non si può pensare realisticamente che gli esseri umani adottino in massa un metodo scientifico di disaccordo ragionato per farsi un’idea del mondo che hanno intorno. Sappiamo dalla psicologia che gestire la contraddizione è una delle cose più difficili per la mente umana: il bisogno di ridurre la “dissonanza cognitiva” è tra i meccanismi psicologici più forti che guidano il nostro pensiero. Non si può cercare di cambiare le basi cognitive del ragionamento umano: si possono però creare istituzioni, forme di incontro, metodi di dibattito, che fanno emergere il dissenso in modo costruttivo. Si può anche imparare a riconoscere e criticare i “vizi epistemici” di tanti discorsi, come l’insensibilità davanti agli argomenti contrari, l’indifferenza alle più semplici intuizioni statistiche, o l’attrazione per le teorie complottiste e paranoiche che hanno il fascino di mettere insieme fenomeni tra loro sconnessi in una specie di “narrativa” gratificante al di là di qualsiasi oggettività. Un’epistemologia politica che comprenda a quale punto la conoscenza dipenda dalle strutture istituzionali che la fanno circolare è sicuramente necessaria per creare un’epistemologia del quotidiano più virtuosa.
NICLA VASSALLO
Quanto al problema di comunicazione, mi sembra che sarebbe abbastanza semplice: basterebbe presentare il disaccordo tra scienziati come il disaccordo tra esperti. Quando ad esempio una persona soffre di una certa patologia si reca da più esperti, e se questi (come spesso accade) sono in disaccordo tra loro si presenta il problema di chi scegliere. E lo stesso accade nella comunità scientifica. Ma la differenza tra il primo e il secondo caso è che il disagreement nella comunità scientifica (come in quella filosofica) è essenziale al progresso. Se tutti fossero d’accordo vivremmo in uno stato di stasi; invece il disaccordo e la critica devono essere visti come positivi. Purtroppo il pubblico non sospende mai il giudizio, e prende parte senza cognizione di causa per l’una o per l’altra parte di un dissenso scientifico a seconda di balzane convinzioni. Penso che la possibilità di offrire al pubblico confronti diretti o dialoghi tra due o tre scienziati che la pensino in modo diverso sullo stesso tema sarebbe utile. Infatti ciò aiuterebbe il pubblico a comprendere che le divergenze effettive sono minori di quelle che ci spacciano i media, e comprendere che questa è l’unica via che porta alla risoluzione dei problemi, il processo collettivo del problem-solving.
MARIO DE CARO
Vorrei aggiungere che l’unico modo di risolvere il problema è una seria educazione scientifica. È stato scritto recentemente che molta polemica contro i vaccini è condotta da persone che hanno studiato: il problema è capire cosa e come hanno studiato. In Italia c’è una tradizione antiscientifica molto forte, che in parte deriva dalla riforma Gentile la quale, nonostante i suoi pregi, ebbe anche alcuni grandi difetti: per cui ci sono persone che non hanno la minima idea di come funzionano la statistica e la probabilità, e che quindi, di fronte al fenomeno vaccini, non sanno comprendere appieno il problema. È del tutto evidente — è provato — che i vaccini purtroppo sono mortali per alcuni soggetti. Eppure, usandoli, si salvano molte più vite di quante se ne perdano. Naturalmente se una trasmissione (generalmente ottima) come Report va a intervistare le famiglie delle persone che sono decedute per via di un vaccino, questa informazione è scorretta, perché presenta questa morte come l’unico dato rilevante. In generale, se non si conoscono un minimo di statistica, probabilità e storia della scienza diventa praticamente impossibile orientarsi rispetto a queste questioni. Bisogna migliorare la qualità dell’istruzione scientifica, ma anche la qualità – e questo è importante – delle informazioni scientifiche diffuse dai mass media. Ci sono alcuni media che – un po’ in malafede, un po’ per ignoranza – diffondono notizie assurde. Benché in proposito non si possa imporre la censura, si dovrebbe far sì che i media che sanno come si fa la divulgazione scientifica siano nella posizione di criticare gli altri, e di dimostrare come quel modo di discutere di determinati problemi non funziona. È necessario comunicare correttamente sia i risultati scientifici che il metodo della scienza.
Spesso sembra esserci confusione tra, da una parte, l’autorità conferita dalla conoscenza (il capire, e saper spiegare, i processi che producono un fenomeno) e dal rispetto di norme argomentative condivise e, dall’altra, le strutture normalizzanti e autoritarie. Di conseguenza, coloro che vogliono difendere il prestigio epistemico della competenza vengono accusati di elitismo, in nome del principio (giusto, ma soltanto se contestualizzato) che “tutti hanno diritto alla loro opinione”. Come si difende il concetto di autorità epistemica senza cadere nella dittatura delle “autorità” o nella “tecnocrazia”?
MARIA BAGHRAMIAN
Si, è molto triste che la nozione di competenza, o di “autorità epistemica” sia stata accorpata all’elitismo, o addirittura a impulsi autoritari. La divisione del lavoro, linguistico ed epistemico, e la specializzazione che la accompagna sono essenziali per il funzionamento delle comunità che condividono un linguaggio e un modo di pensare, particolarmente in società avanzate e complesse. Per fare solo un esempio, la scienza come viene praticata oggi è un’impresa collettiva la cui condotta richiede un’enorme mole di divisione del lavoro epistemico e di specializzazione. Senza fiducia nella competenza di coloro che lavorano in altre sotto-specializzazioni, la scienza non potrebbe progredire, né funzionare nella sua forma attuale. Mi sembra che queste reazioni contro l’“elitismo” della competenza siano il prodotto di pressioni economiche più che filosofiche, e devono essere spiegate di conseguenza. L’ordine economico Neoliberista ha celebrato la competenza e gli ha dato un posto di prestigio all’interno del processo decisionale sociale ed economico. L’affidamento alla conoscenza degli esperti è spesso stato accompagnato da premi economici – in particolare nel campo bancario, finanziario e legale – del tutto sproporzionati al contributo che questi esperti effettivamente apportano al benessere della società. Un secondo problema (legato al primo) è ancora una volta quello del legame tra conoscenza e potere. La conoscenza ci conferisce autorità oltre al campo epistemico, ed è spesso stata uno strumento nelle mani della volontà di potenza. Sapere, ed essere portatori di conoscenza, ci permette di influenzare gli altri, di perseguire i nostri obiettivi. Non è necessario credere (come sostiene Tim Williamson) che la conoscenza sia la norma per fare affermazioni, o che la conoscenza venga per prima, per poter apprezzare il ruolo primario che gioca in tutti i nostri scambi sociali. È un’ovvietà, ma non del tutto banale, che la conoscenza conferisce potere, ma il potere, in tutti i casi, deve rispondere dei bisogni degli altri e alle loro (e nostre) vulnerabilità. Possiamo vedere i primi segni di questa preoccupazione riguardo all’esercizio della conoscenza scientifica senza senso di responsabilità nel Dr. Frankenstein, di Mary Shelley, un romanzo quasi profetico considerando come al tempo la scienza moderna era ancora giovane. Sapere, e brandire il potere che la conoscenza ci conferisce senza responsabilità di fronte alle questioni etiche che questa conoscenza produce, è un pericolo che dobbiamo sempre tenere bene in considerazione. La connessione tra i parametri normativi della conoscenza e il mantra (a prima vista tollerante e inclusivo) “tutti hanno diritto alla loro opinione” è interessante. Molto spesso in dibattiti e conversazioni, in particolare riguardo a questioni etiche e politiche negli Stati Uniti, l’affermazione “ho diritto alla mia opinione” viene usata come carta che pone fine alla discussione. Questo è un errore. Se affermi la tua opinione sei, come minimo, responsabile per la sua plausibilità razionale, se non proprio per la sua verità. Le opinioni non sono differenti da altri tipi di credenze. Siamo tutti responsabili pubblicamente per le nostre opinioni, così come lo siamo per le nostre affermazioni di conoscenza. Gli usi odierni di questo mantra dimenticano questo componente normativo.
NICLA VASSALLO
Purtroppo sul piano fattuale si è confusa l’autorità epistemica con l’autorità politica, o l’autorità del dittatore. E tale confusione è stata particolarmente accentuata in quelle democrazie dove abbiamo avuto governi tecnici: ad esempio economisti al potere che hanno mentito, e non si sono mai pentiti delle loro menzogne (perdendo dunque la fiducia del pubblico). E il caso del nostro paese è un caso classico. Come si può ripristinare la fiducia perduta? Cercando di distinguere nettamente (nonostante le illusioni di Platone) tra il politico e l’autorità epistemica. L’autorità epistemica può solo essere un buon consigliere di un politico, ma a mio avviso non può e non deve entrare direttamente in politica: deve suggerire al meglio il politico rimanendo svincolata dal potere politico.
MARIO DE CARO
Questo è il tipico argomento in cui si discute di bianco e di nero, come se non ci fosse alcuna via di mezzo. Con questo modo di procedere non si ottiene nulla, e anzi si generano facilmente disastri. È del tutto evidente che esiste un ampio terreno intermedio tra l’imporre presunte verità con la forza e l’accettare qualunque scempiaggine come se fosse parimenti autorevole. È sempre stato così, ma oggi con internet la situazione è peggiorata: si pensi alla famigerata frase di Umberto Eco “Internet permette a qualunque cretino di dire la sua opinione”: forse è un po’ rude, ma ha una giustificazione. Su Facebook ho letto eminenti professori o studiosi di determinati campi spiegare la propria opinione informata ed essere “confutati” in due righe da qualcuno, completamente digiuno della materia del contendere. Questo è un fenomeno grave, e direi che Facebook e simili non sono i social media ideali per una discussione seria. Il problema è che le distinzioni sono difficili: è chiaro che esistono autorità autoritarie e autorità autorevoli. È una cosa in sé ovvia, ma si sta abbassando il livello dell’istruzione generale: si tagliano i fondi per l’istruzione, la gente non va a scuola, non studia bene e poi finisce per dire scempiaggini, non essendo in grado di riconoscere i ragionamenti corretti da quelli scorretti. La situazione non sarà mai perfetta, ma ci sono molti margini di miglioramento.
GLORIA ORIGGI
A me sembra che nelle grandi visioni sulla democrazia e in particolare nell’entusiasmo per il ruolo della Rete, vi è sempre stata una certa tendenza a semplificare e idealizzare sia le capacità cognitive che le dinamiche sociali dei cittadini. Se l’uguaglianza di diritti è un caposaldo della democrazia anche in un’epoca di spettacolari disuguaglianze economiche, l’uguaglianza epistemica, o l’egualitarismo epistemico, è spesso una nozione sottintesa, che vede i soggetti cognitivi come tutti uguali, intercambiabili, in linea di principio capaci di sviluppare tutti gli stessi argomenti seguendo lo stesso metodo (una tesi criticata per esempio da molta epistemologia femminista). L’egualitarismo epistemico è rivendicato come un diritto fondamentale non a chiedere ragioni o ad avere accesso alle stesse risorse epistemiche (diciamo una rivendicazione di qualche forma di “diritto aletico”, come ha sostenuto recentemente in un saggio pubblicato da Franca D’Agostini nella rivista Biblioteca della Liberta del centro Einaudi), ma una rivendicazione ad avere ragione e poter esprimere il proprio punto di vista al di là di qualsiasi standard argomentativo condiviso. Una rivendicazione resa possibile dalla straordinaria capacità del Web di dare voce a una moltitudine di individui che mai avevano avuto accesso alla parola “pubblica” prima d’ora. Avere ragione secondo i propri standard, rifiutare di farsi imporre qualsiasi standard epistemico percepito come una coercizione “dall’alto” è il tranello in cui cascano i cittadini più vulnerabili, che si sentono “empowered” cognitivamente e socialmente dal poter esprimere la loro opinione e non si rendono conto di essere vittime di nuove forme di controllo dell’opinione e di coercizione mentale. Un risultato recente mostra come coloro che sono i più scettici riguardo all’autorità delle testate di informazione tradizionali sono anche i più ricettivi a credere alle teorie del complotto e a cascare nella rete delle bufale trasmesse attraverso i social networks. Questo “corto-circuito” tra politica ed epistemologia è forse uno degli aspetti più salienti delle società iper-connesse e (spesso definite) post-democratiche attuali nelle quali la sovraesposizione dei pareri dei cittadini bypassa la rappresentanza politica con modalità che delegittimano la seconda senza legittimare la prima.”














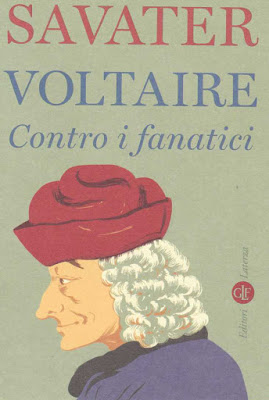 fanatici (Laterza) si chiede «che cosa ci resta veramente di Voltaire? Ci resta l’esempio della sua militanza, (…) che non mirava semplicemente a modificare la nostra comprensione del mondo o la condotta individuale del saggio nel mondo, ma a modificare il mondo stesso (…); nessuno prima di lui si era accorto con tanta chiarezza della forza rigeneratrice che le idee possono esercitare sull’opaca e logora struttura della società».
fanatici (Laterza) si chiede «che cosa ci resta veramente di Voltaire? Ci resta l’esempio della sua militanza, (…) che non mirava semplicemente a modificare la nostra comprensione del mondo o la condotta individuale del saggio nel mondo, ma a modificare il mondo stesso (…); nessuno prima di lui si era accorto con tanta chiarezza della forza rigeneratrice che le idee possono esercitare sull’opaca e logora struttura della società». Ci si chiede sempre cosa sia un classico. Leo Strauss non avrebbe avuto dubbi: è chi aiuta a capire i problemi. Come Baruch Spinoza, ad esempio. Strauss gli si era avvicinato quasi per caso, su invito dell’Accademia per le Scienze del Giudaismo. Non se ne allontanò più. La ragione della lunga frequentazione è facile da intuire: chi meglio di Spinoza, emarginato dalla sua comunità per l’empietà delle dottrine professate, il pensatore radicale per eccellenza, poteva servire come guida per indagare il grande problema della modernità, lo scontro tra religione e filosofia (e scienza)? Lo Spinoza del Trattato teologico-politico è colui che più decisamente si era scagliato contro il principio di autorità e dunque la Rivelazione. Ma neppure lui era riuscito a riportare una vittoria definitiva. Quello che rende il suo attacco così interessante agli occhi di Strauss è il fallimento: neanche Spinoza è riuscito a dimostrare la superiorità di filosofia e scienza rispetto alle verità rivelate.
Ci si chiede sempre cosa sia un classico. Leo Strauss non avrebbe avuto dubbi: è chi aiuta a capire i problemi. Come Baruch Spinoza, ad esempio. Strauss gli si era avvicinato quasi per caso, su invito dell’Accademia per le Scienze del Giudaismo. Non se ne allontanò più. La ragione della lunga frequentazione è facile da intuire: chi meglio di Spinoza, emarginato dalla sua comunità per l’empietà delle dottrine professate, il pensatore radicale per eccellenza, poteva servire come guida per indagare il grande problema della modernità, lo scontro tra religione e filosofia (e scienza)? Lo Spinoza del Trattato teologico-politico è colui che più decisamente si era scagliato contro il principio di autorità e dunque la Rivelazione. Ma neppure lui era riuscito a riportare una vittoria definitiva. Quello che rende il suo attacco così interessante agli occhi di Strauss è il fallimento: neanche Spinoza è riuscito a dimostrare la superiorità di filosofia e scienza rispetto alle verità rivelate.
 scrivendo su questo tema tra il 1924 e il 1932, a completamento dell’opera principale La critica della religione in Spinoza, uscita nel 1930, e chiarisce alcuni punti decisivi della sua interpretazione. In particolare, questi lavori aiutano a meglio comprendere l’importanza della presenza di un ospite inatteso, a cui Strauss continuamente pensa quasi mai nominandolo. Friedrich Nietzsche. Senza di lui non si può capire che cosa sia davvero in gioco.
scrivendo su questo tema tra il 1924 e il 1932, a completamento dell’opera principale La critica della religione in Spinoza, uscita nel 1930, e chiarisce alcuni punti decisivi della sua interpretazione. In particolare, questi lavori aiutano a meglio comprendere l’importanza della presenza di un ospite inatteso, a cui Strauss continuamente pensa quasi mai nominandolo. Friedrich Nietzsche. Senza di lui non si può capire che cosa sia davvero in gioco. “
“