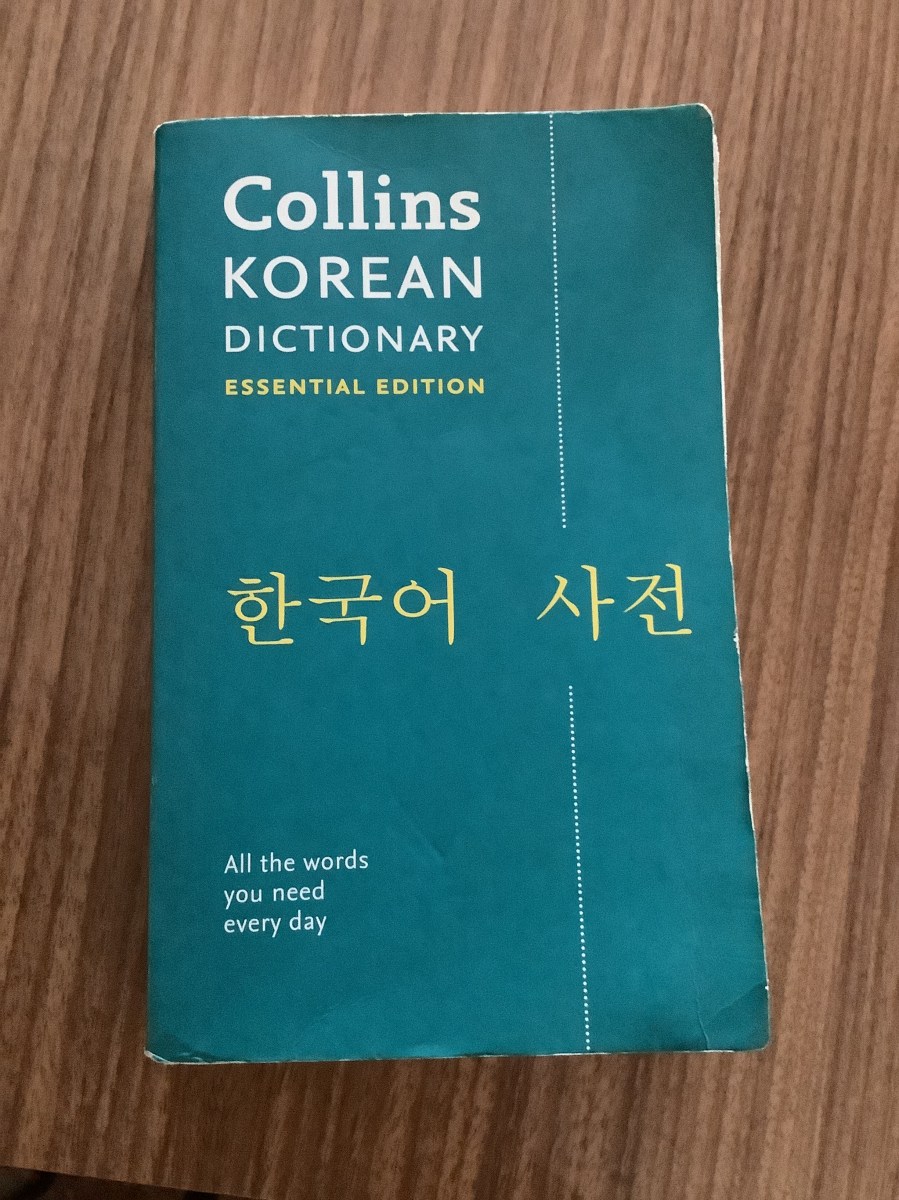Pubblico un articolo di Nadir Manna pubblicato l’altroieri su Il Post per parlare di uno dei cambiamenti più evidenti che ha investito e sta investendo il mondo della scuola: i chatbot.“Per gli studenti delle scuole superiori italiane il 2024 è stato l’anno in cui i programmi di intelligenza artificiale (AI) hanno cambiato, forse per sempre, il modo di studiare e di fare i compiti a casa. Non è stato deciso da nessuno: gli alunni hanno imparato a usare ChatGPT per conto loro, in certi casi prima degli insegnanti, molto spesso a loro insaputa, e nel giro di un anno è diventato difficile trovare delle classi in cui non venga utilizzato almeno da qualcuno.
Tra i vari software e chatbot disponibili basati sull’AI, ChatGPT è quello di gran lunga più usato, in generale nel mondo e in particolare dagli studenti. In molte materie può svolgere una funzione di consulente, grazie alla sua capacità di scrivere testi, risolvere esercizi e fornire spiegazioni in base alle istruzioni che riceve, e la conseguenza più immediata è stata che i compiti a casa sono diventati meno adatti a valutare o monitorare lo studio e l’apprendimento. Nel frattempo i docenti stanno provando ad adattare e aggiornare i loro metodi didattici, ma l’impatto delle AI varia a seconda della materia d’insegnamento, e non tutti la pensano allo stesso modo su come integrarle nelle lezioni né su quanta libertà lasciare agli studenti nel loro utilizzo.
In base alle testimonianze degli studenti con cui ha parlato il Post, ChatGPT viene usato soprattutto per scrivere i temi e per fare le versioni di greco e latino. Ma anche per farsi spiegare concetti difficili, per ripassare e per fare i riassunti. I vantaggi sono notevoli: nel caso delle versioni, ad esempio, oltre a fare le traduzioni (che si trovano facilmente anche online) ChatGPT spiega i passaggi e aiuta a capire la costruzione del periodo e l’analisi logica.
All’inizio del 2024 gli alunni hanno iniziato a utilizzare ChatGPT prima che gli insegnanti avessero il tempo di conoscerlo e prenderci confidenza. «Nessuno è mai stato scoperto», dice uno studente di quinta di un liceo scientifico di Roma parlando dell’esperienza nella sua classe. Per lui e per molti suoi compagni il chatbot ha cambiato drasticamente il metodo di approccio allo studio di alcune materie: «Quando devi fare un compito a casa la prima cosa che ti passa per la testa è di chiedere a Chat, poi sicuramente lo rielabori e ci aggiungi qualcosa di tuo, ma comunque Chat è la prima cosa a cui pensi».
Anche dai suoi compagni ChatGPT viene usato regolarmente, e per farci un sacco di cose diverse: «è molto utile, può essere usato per studiare prima di una verifica, per ripetere, per sistemare gli appunti; puoi fare una foto al paragrafo di un libro e Chat te lo riassume», dice lo studente.

Non è un caso isolato. Molti altri studenti delle scuole superiori raccontano che ormai quasi tutti i loro compagni di classe usano ChatGPT, sia per i compiti a casa che per copiare di nascosto durante le verifiche in classe (nel caso in cui i cellulari non vengano ritirati dall’insegnante, cosa che in realtà accade molto spesso). Il chatbot permette di generare risposte e spiegazioni a domande molto specifiche e spesso si rivela più versatile e molto più efficace dei motori di ricerca, specie per le materie umanistiche come storia, filosofia, italiano e latino. «Alcuni compagni di classe usano ChatGPT per farsi fare qualsiasi compito, anche quando le prove non sono valutate», racconta lo studente di Roma.
Usare le AI per studiare però non vuol dire necessariamente imbrogliare e cercare scorciatoie per studiare di meno. Una studente di un liceo delle scienze umane di Milano ha raccontato per esempio di usare spesso la modalità di interazione vocale di ChatGPT per fare conversazione in inglese e per preparare le interrogazioni. «Per qualcuno è uno strumento di supporto allo studio, utile per imparare; qualcun altro lo usa per fargli fare i compiti e per compensare il fatto che non studia», dice la studente di Milano.
Lo stesso discorso non vale per le materie scientifiche come chimica, matematica e fisica, in cui ChatGPT dà spesso delle risposte sbagliate: anche se può sembrare controintuitivo, modelli come ChatGPT infatti non fanno bene i calcoli, perché non ragionano in modo logico e matematico, ma generano le loro risposte secondo dei criteri probabilistici. In questi casi, per gli esercizi algebrici alcuni studenti si affidano ad altri software (alcuni in realtà disponibili già da tempo), come ad esempio Photomath: un’app che fa automaticamente gli esercizi di matematica a partire dalla foto di una funzione scritta sul quaderno o sulla lavagna.
In questo contesto, il modo in cui gli insegnanti assegnano e valutano i compiti a casa è inevitabilmente cambiato. Da quando si sono accorti che gli studenti usano ChatGPT, molti professori hanno deciso di smettere di valutare i compiti o di controllare se vengono fatti. Degli insegnanti raccontano di essersi accorti che alcuni studenti usavano il chatbot dal fatto che i loro scritti erano diventati poco originali e assai carenti dal punto di vista del pensiero critico. Una professoressa di un liceo di Milano racconta di essersene accorta quando, durante la correzione di un tema, ha trovato alcune citazioni di dialoghi dei Promessi Sposi di Manzoni completamente inventate (lo studente alla fine ha ammesso di avere utilizzato ChatGPT).
Molto, comunque, dipende dai metodi di insegnamento, di verifica e di valutazione, oltre che dal tipo di rapporto che gli insegnanti riescono a costruire con gli studenti. Alcuni professori raccontano di usare un metodo didattico che non prevede compiti a casa obbligatori: in questo caso le indicazioni di studio e gli esercizi assegnati servono soltanto per aiutare gli studenti a prepararsi per l’interrogazione, in cui ChatGPT è molto difficile se non impossibile da usare.
Non è semplice instaurare un dialogo tra alunni e docenti sull’uso delle AI, anche perché, a volte, la possibilità di prendere dei voti più alti dipende dal fatto che gli insegnanti non sappiano come funzionano queste tecnologie. I professori, infatti, stanno iniziando a prendere confidenza con lo strumento soltanto ultimamente. Secondo il racconto di una docente di filosofia di un liceo di Milano, quando in una delle sue classi ha provato a farsi raccontare di ChatGPT gli studenti sono diventati sospettosi, restii a parlare del modo in cui lo usavano.

Quest’anno il ministero dell’Istruzione ha reso obbligatorie per gli insegnanti 20 ore di formazione annuali, e in alcune scuole sono stati fatti dei corsi sulle intelligenze artificiali, in particolare su ChatGPT e su come usarlo come strumento di supporto alla didattica. Oltre che a capire l’uso che ne fanno gli studenti, per i professori può anche essere utile imparare a usarlo a loro volta: il chatbot può essere usato per preparare i compiti in classe, ad esempio per generare quiz e domande, oppure per organizzare e preparare le lezioni. Non tutti i docenti però hanno seguito un corso sull’AI, e anche per questo motivo ogni insegnante ha una percezione diversa dell’impatto di queste tecnologie e della diffusione di ChatGPT tra gli studenti.
Inoltre, in base ai pareri e ai racconti di alcuni docenti sentiti dal Post, ogni professore ha una sua idea su quali siano i vantaggi e gli svantaggi portati da questo cambiamento e su come andrebbe gestito. Alcuni, per esempio, si preoccupano soprattutto della possibilità che gli studenti usino ChatGPT per copiare e per aggirare lo studio, e vedono la soluzione nell’uso di software antiplagio, che in teoria permettono di scoprire quando un testo è stato scritto da un’intelligenza artificiale oppure no.
Questo approccio però presenta dei limiti. Le tecnologie su cui si basano i chatbot in grado di generare testi continuano a evolvere molto rapidamente, lasciando gli strumenti antiplagio sempre un passo indietro. Con un po’ di accorgimenti è semplice aggirarli, passando lo stesso testo per diversi chatbot e programmi di rielaborazione del testo o aggiungendo delle modifiche manuali. In più, i software antiplagio stimano la probabilità che un testo sia stato scritto con un’AI, senza dare risposte certe e con il rischio di generare dei falsi positivi, cioè di segnalare come generati dalle AI testi in realtà scritti da persone.
Altri docenti pensano che il modo migliore per evitare che gli studenti copino con ChatGPT sia quello di integrarlo nella didattica, per insegnare a usarlo in modo consapevole, come uno strumento per imparare e per assistere lo studio. «Sarebbe sciocco non utilizzarlo e non tenere in conto che gli studenti, almeno a casa, lo usano in ogni caso», dice una docente di italiano e storia di un liceo di Vimercate, in provincia di Monza.
In base ai racconti dei docenti, sono stati già pensati molti modi, anche piuttosto creativi, per usare ChatGPT durante le lezioni: la professoressa che insegna filosofia in un liceo di Milano ha raccontato di aver provato a usare il chatbot in classe per simulare una conversazione con Platone, con dei buoni risultati; mentre una docente di italiano e storia che lavora in un istituto tecnico-commerciale in provincia di Bologna ha raccontato di aver istruito i suoi studenti a usarlo per fare delle parafrasi dei testi letterari e per impostare le scalette dei temi. In alcuni libri di testo sono già stati inseriti degli esercizi che danno istruzioni agli studenti per generare un testo con un’AI e successivamente commentarlo.”