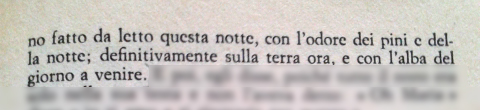Come spesso mi capita, sono solo in parte d’accordo con quello che pensa Paola Mastrocola. E pubblico queste sue parole, tratte dal sito della Laterza, subito dopo il predente post non perché vi trovo delle contraddizioni, ma per pura casualità.
Come spesso mi capita, sono solo in parte d’accordo con quello che pensa Paola Mastrocola. E pubblico queste sue parole, tratte dal sito della Laterza, subito dopo il predente post non perché vi trovo delle contraddizioni, ma per pura casualità.
“Oggi non si studia più. È da predestinati alla sconfitta. Lo studio evoca Leopardi che perde la giovinezza, si rovina la salute e rimane solo come un cane. È Pinocchio che vende i libri per andare a vedere le marionette. È la scuola, l’adolescenza coi brufoli, la fatica, la noia, il dovere. È un’ombra che oscura il mondo, è una crepa sul muro: incrina e abbuia la nostra gaudente e affollata voglia di vivere nel presente.
Lo studio è sparito dalle nostre vite. E con lui è sparito il piacere per le cose che si fanno senza pensare a cosa servono.
La cosa più incredibile è che non importa a nessuno.
Di fatto, noi non intendiamo mai lo studio nella sua accezione più profonda; non entriamo nello specifico della sua sostanza immaginando l’atto di studiare in sé, fino alle sue naturali ed estreme conseguenze. Lo dico meglio: quando diciamo che i nostri ragazzi devono studiare, non vogliamo dire che debbano passare gran parte del loro tempo chini sui libri, pomeriggio e sera, soli e concentrati. Non vogliamo dire questo perché questo non ci piace per niente, e mai augureremmo loro una vita del genere. Eppure, quando speriamo che studino e che proseguano fino all’università, noi li indirizziamo a un siffatto stile di vita, giacché è ancora vero (non so per quanto) che per avere un’istruzione bisogna stare tanto, sui libri. E cartacei o digitali che siano, nulla cambia.
Lo studio è, ancora, inevitabile. Per quanto gli insegnanti si producano in performance sempre più accattivanti; i saperi si esternalizzino; le scuole si dotino di LIM, DVD, app, wi-fi e bluetooth; per quanto limiamo asperità e livelliamo strade azzerando ogni sorta di difficoltà; per quanto puntiamo al saper fare e alle competenze e al problem solving, e non più al sapere; ebbene, c’è sempre un momento in cui lo studente deve mettersi a studiare: piazzarsi seduto, aprire un benedettissimo libro, e starci sopra parecchio, e anche parecchio concentrato e attento. Che sia una semplice verifica, un’interrogazione virtuale, un esonero all’università, un test di ammissione per la Normale di Pisa o l’assunzione presso una ditta di surgelati, a un certo punto della vita i ragazzi dovranno dimostrare di sapere qualcosa. Quindi dovranno, bene o male, poco o tanto, studiare.
Non abbiamo ancora inventato sistemi alternativi, grazie ai quali evitare lo studio, questo spiacevole disagio, questo disturbo, percorso a ostacoli, noiosissimo impiccio che intralcia, deprime, sporca leggermente il meraviglioso luna park che pensiamo debba essere la vita. A un certo punto dobbiamo scendere dalla giostra dei cavallini e studiare: intollerabile! Non ci piace per niente.
E infatti stiamo lavorando per trovarli, questi sistemi alternativi. Nell’ultimo decennio direi che non facciamo altro: ministri, funzionari, professori, burocrati, intellettuali di grido e scrittori si danno un gran da fare a smantellare l’idea di un’istruzione fondata sullo studio e sui libri, cioè sull’universo logico-verbale (il modo “simbolico-ricostruttivo” dell’apprendimento, come dicono gli psicologi). L’ultima trovata è dire che tutto ciò è vecchio, screditarlo come retaggio arcaico e dinosaurico di un mondo che non c’è più. Insomma, è la solita solfa del mondo che è cambiato, dunque perché noi ci attardiamo su macerie invece di proiettarci dritti dentro il futuro? Siamo gli ultimi in Europa, siamo decrepiti, meritiamo di morire eccetera eccetera. E, dulcis in fundo, i giovani hanno ben ragione a non studiare, questo sistema non fa più per loro e se non ci sbrigheremo a trovarne un altro li perderemo tutti.
L’abbiamo risolta in questo modo: siccome nessuno ha più voglia di studiare, noi smantelliamo l’universo dello studio. L’idea geniale è che si tratti di adeguarci al cambiamento, assecondarlo invece di arroccarci.
Personalmente, più sento dir così, più mi arrocco. Mi viene uno spasmodico amore per tutte le rocche, il più inerpicate e sole possibile. Inaccessibili e lontane, con la nuvoletta in cima. Da lassù contempleremo le magnifiche sorti e progressive. Tanto, di una cosa sola siamo molto consci: che nulla possa arrestare la marea. Quindi, tanto vale godersela dall’alto, noi arroccati.
Chiusa la parentesi rocciosa, dicevo che ci piace molto che i ragazzi vadano a scuola, ma non che studino. È un controsenso, lo so. Una specie di dissociazione, un’autocontraddizione in cui ci siamo imbrogliati come in un groviglio e di cui non sembriamo per nulla consapevoli. Magie della mente umana. Un fraintendimento. Un equivoco, gigante. Una incomprensione granitica reciproca fatta a forma di montagna. Potessi disegnarla, sarebbe la catena dell’Himalaya.
Forse potremmo dir così, che la parola “studio” ha oggi come per miracolo due significati. Si è divaricata. Spaccata. Si è creata un’ambiguità terminologica, che ha prodotto tra noi tutti una confusione. Un intrico di rami. Detto in breve, quando diciamo “studiare” intendiamo andare a scuola, avere un’istruzione, procurarsi un titolo, possibilmente una laurea (quel che oggi si chiama percorso formativo); non intendiamo invece quasi mai l’altro significato del verbo: l’atto in sé, stare sui libri, passare ore chiusi da qualche parte, isolati, concentrati, fermi.
Studio 1 e studio 2. Per quanto possa sembrare strano i due significati oggi, nella nostra testa, non vanno insieme. Fino a pochi decenni fa erano, ovviamente, inscindibili; oggi invece possono dissociarsi, andare ognuno per conto proprio. Così che si crea il seguente paradosso: da una parte siamo tutti d’accordo che si debba studiare, dall’altra non ci piace per niente studiare.
E può succedere che le famiglie tengano moltissimo allo studio 1 dei loro figli: si dedicano con grande cura alla scelta della scuola, e seguono i figli molto più di una volta. Arrivano a fare i compiti con loro, e si prodigano a offrir loro tutti i supporti possibili, libri, computer, lezioni private a iosa. E può succedere, allo stesso tempo, che queste stesse famiglie, che tengono così tanto allo studio 1 dei loro figli, non si preoccupino molto dello studio 2. Può succedere addirittura che questo studio 2 dia loro fastidio: in qualche modo peggiora la vita quotidiana di tutti, è un problema e tendono quindi a ostacolarlo, o relegarlo in qualche zona buia e ristretta della vita.
Insomma, se noi genitori tenessimo davvero allo studio 2 dei nostri figli, non faremmo le vite che facciamo e non avremmo la scuola che abbiamo. E se noi insegnanti tenessimo davvero allo studio 2 dei nostri allievi, non chiuderemmo un occhio: saremmo più esigenti, fin dalle elementari; ci preoccuperemmo meno di divertirli, distrarli, ammaliarli con effetti speciali, gite, teatri, balletti in maschera. Insegneremmo loro, molto umilmente, le materie di base, dando loro gli strumenti di base per possedere le nozioni di base. E non penseremmo, così facendo, di offrire cose troppo banali e povere né ci preoccuperemmo di annoiare i bambini: avremmo ben chiaro in mente di fare la cosa migliore per loro.
Perché è dalla base che si parte per costruire qualsiasi edificio. Se no, crolla.”






 più toccare, interagire con chi scompare. Il secondo tema è quello del tempo: “vorrei tornare indietro ma non si può”. Il tempo passa e non si ferma ad aspettarti, ho paura di essere grande e non ricordarmi quello che è stato”. Questa è stata la gemma di A. (classe seconda).
più toccare, interagire con chi scompare. Il secondo tema è quello del tempo: “vorrei tornare indietro ma non si può”. Il tempo passa e non si ferma ad aspettarti, ho paura di essere grande e non ricordarmi quello che è stato”. Questa è stata la gemma di A. (classe seconda).