Ormai un classico appuntamento del blog: quello con le Interferenze di Gabriella Greison su Avvenire. Il 14 novembre si è dedicata a Georges Lemaître.
“Georges Lemaître non indossava un camice, ma una tonaca. Non lavorava solo tra telescopi e lavagne, ma anche tra chiese e cattedrali. Era un sacerdote cattolico e, nello stesso tempo, uno dei più grandi cosmologi del Novecento. L’uomo che per primo ha osato dire una frase rivoluzionaria: “L’universo ha avuto un inizio”. Lo chiamavano “il prete che ha inventato il Big Bang”. In realtà lui preferiva parlare di “atomo primitivo”: una minuscola particella cosmica compressa oltre ogni immaginazione che, disgregandosi, avrebbe dato origine a tutto ciò che conosciamo — galassie, stelle, pianeti, persino noi. Quando Lemaître lo propose nel 1931, l’accoglienza fu tiepida se non ostile: Einstein, dopo una sua conferenza, gli disse con l’aria di chi mette un punto: i calcoli sono corretti, ma la fisica è “abominevole”. Non proprio un incoraggiamento. Eppure quel giovane prete belga non si spaventò. Continuò a fare i conti, a immaginare il cosmo come una pellicola che non si srotola solo in avanti ma può essere riavvolta: se oggi vediamo le galassie allontanarsi, allora ieri dovevano essere più vicine, e prima ancora più vicine, fino a un primo respiro, un lampo d’origine. Un universo che si espande implica un’origine, e un’origine cambia tutto. Non più un cosmo eterno e statico, ma una storia.
Molti, ancora oggi, faticano a credere che Lemaître fosse entrambe le cose: sacerdote e scienziato. Come se la fede e la ricerca fossero incompatibili per statuto. Lui non vedeva alcuna contraddizione. Celebrare la Messa e scrivere equazioni erano due modi di entrare nello stesso mistero, con due grammatiche differenti. Diceva che tra l’inizio della materia e l’atto della creazione c’è un abisso che la fisica non colma e che la teologia non misura; la fisica racconta il “come”, la fede interroga il “perché”. Due domande diverse, entrambe necessarie. Per questo non usò mai la fede per tappare i buchi della scienza, né la scienza per dimostrare l’esistenza di Dio: manteneva un equilibrio raro, una distanza di rispetto tra i linguaggi. Era convinto che la matematica potesse dire l’universo con una chiarezza che nessun’altra lingua possiede, ma che il mistero del suo perché restasse oltre ogni formula.
C’è un fotogramma che amo: Lemaître alla lavagna, gesso in mano, il colletto bianco in evidenza, e quegli occhi da alpinista dell’ignoto. Pochi sanno che prima della “teoria dell’atomo primitivo” c’è un suo articolo del 1927, quasi ignorato, in cui ricava — con naturalezza disarmante — l’idea che lo spazio si stia espandendo e collega la distanza delle galassie alla loro velocità di allontanamento. Quella che poi diventerà la “legge di Hubble” l’aveva già messa nero su bianco lui, con la serenità di chi non ha urgenza di intestarsi i meriti. Non cercava fama, cercava coerenza: se i dati dicono questo, è lì che dobbiamo andare, anche se la filosofia del tempo preferisce un universo.
La sua tenacia era quasi monastica: niente clamore, solo lavoro. E quando negli anni ’50 qualcuno provò a trasformare la sua intuizione in bandiera apologetica — “il Big Bang conferma la creazione biblica” — Lemaître fu il primo a frenare: mischiare i piani, semplificare, usare la fisica come prova di Dio, era per lui un errore concettuale e spirituale. “La scienza non ha bisogno di Dio per funzionare. E Dio non ha bisogno della scienza per esistere.” In una riga toglieva secoli di malintesi.
Il suo temperamento era così: una spiritualità silenziosa, fatta di dedizione, di studio, di ascolto del cielo. Non predicava dai pulpiti: lasciava che le equazioni diventassero finestre. E mentre il dibattito infuriava tra universi eterni e universi a nascita, tra staticità rassicuranti e dinamiche vertigini, Lemaître continuava a fare ciò che sapeva fare meglio: affinare i conti, interrogare i dati, accettare che il reale potesse essere più audace delle nostre abitudini mentali. L’idea di un “giorno senza ieri” era un terremoto non solo scientifico ma culturale: se il tempo ha una nascita, allora la storia del cosmo è davvero una storia, con un incipit, uno svolgimento, una trama che continua a dispiegarsi. Il che non “dimostra Dio” — Lemaître non lo disse mai — ma ci espone a una domanda più radicale: perché ci sono leggi così fini da permettere stelle, chimica, coscienze? Perché la musica delle costanti fisiche suona nella tonalità giusta per far emergere la vita? La scienza descrive; la spiritualità, se è onesta, non invade ma domanda.
C’è anche un’altra immagine: Lemaître seduto a un tavolo di lavoro nell’Università di Lovanio, fuori la luce grigia del Belgio, dentro una lavagna piena. Accanto, non premi e medaglie, ma libri sgualciti. Poteva pretendere riconoscimenti; scelse la discrezione. Più tardi sarebbe diventato presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, proprio perché capace di tenere i ponti aperti senza confondere le sponde. Non cercò mai d’essere protagonista: preferì aprire una strada e sparire ai margini del quadro. E proprio per questo la sua figura oggi risplende: perché ha lasciato spazio all’oggetto del suo amore — l’universo — più che al soggetto che lo raccontava.
Se dovessimo definire la sua spiritualità, potremmo chiamarla “spiritualità della ricerca”: lavoro silenzioso, fedeltà ostinata, meraviglia disciplinata. Non dogmi urlati, non scorciatoie. Un credente capace di custodire la trascendenza senza usarla come tappabuchi, uno scienziato capace di amare i limiti del proprio metodo senza trasformarli in muro. Ha accettato che la verità avesse più piani di profondità, che una formula potesse illuminare il come e una preghiera potesse sostenere il perché, senza che nessuna delle due pretenda l’ultima parola. In questo equilibrio sta la sua eredità più grande: la possibilità di abitare due mondi senza scegliere l’esilio.
E poi c’è l’epilogo che sembra scritto per il cinema: 1965–66, la scoperta della radiazione cosmica di fondo — quel fruscio termico che ci arriva da ogni direzione, eco tiepida della prima luce — che offre una conferma potente alla visione di un universo caldo e giovane che si espande. Lemaître ne viene a conoscenza poco prima di morire. Non fa proclami, non esulta: sorride con quella compostezza di chi sa che la scienza procede per indizi, mai per trionfi definitivi. È una tappa, non un arrivo. Anche la prova più elegante è sempre una soglia.
Lo confesso: quando racconto Lemaître io non sono una semplice cronista. Mi riguarda. Anche io vivo su quel crinale dove la ragione spinge e lo stupore trattiene; dove le equazioni aprono e le domande fanno aria; dove il “come” è una musica che voglio imparare e il “perché” è la vibrazione che non smette di chiamare. Non cerco dimostrazioni travestite da miracoli né miracoli travestiti da dimostrazioni. Cerco un luogo in cui ragione e poesia stiano nello stesso respiro. Per questo, quando parlo della sua teoria, non mi limito alla dinamica dello spazio-tempo che si dilata: sento, nello stesso gesto, una pedagogia del limite. La scienza non tutto può dire; la spiritualità non tutto deve dire. È nel varco tra i due che passa l’aria.
Georges Lemaître è morto nel 1966, pochi giorni dopo aver appreso che il cielo conserva ancora, ovunque, la memoria termica della sua nascita. Forse gli bastava: non l’ultima parola, ma un segno. La sua lezione, oggi, suona più necessaria che mai: il cosmo non è un problema da risolvere in fretta, è una storia da contemplare con attenzione. La fisica può dirci come procede; la spiritualità ci chiede perché ci riguarda. Tenere insieme queste due posture — senza confonderle, senza contrapporle — è l’arte sottile che lui ha praticato con una grazia che fa scuola.
E allora, la domanda inevitabile: davanti a un universo che ha avuto un inizio, davanti a un cielo che porta ancora l’eco di quel primo respiro, che cosa ne facciamo noi? Preferiamo archiviare tutto come caso, o sentiamo — anche solo per un istante — che dentro quell’inizio c’è una chiamata alla responsabilità, alla gratitudine, alla ricerca? Siamo disposti a vivere nell’apertura che Lemaître ci ha consegnato — un piede sulla lavagna, un piede sull’altare — senza chiedere all’uno di divorare l’altro, ma lasciando che insieme, finalmente, ci aiutino a guardare più lontano?”






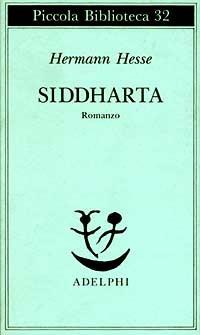



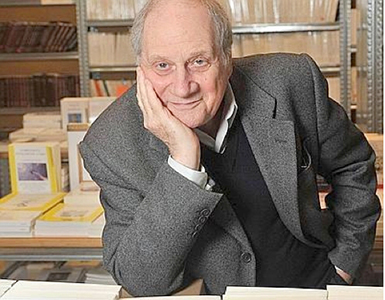 Qualche giorno fa Alessandro Zaccuri ha pubblicato sulle pagine di
Qualche giorno fa Alessandro Zaccuri ha pubblicato sulle pagine di 


 Priyamvada Natarajan è indiana, insegna a Yale e ha da poco scritto il libro “L’esplorazione dell’universo. La rivoluzione che sta svelando il cosmo”. Guido Tonelli insegna fisica all’Università di Pisa e ha scritto “Cercare mondi. Esplorazioni avventurose ai confini dell’universo”, che sarà nelle librerie dal 23 febbraio. La Lettura ha pubblicato una conversazione tra i due: molti e interessanti i temi trattati e un bellissimo ed entusiasmante invito alle giovani menti. Ho reperito in rete il brano intero su
Priyamvada Natarajan è indiana, insegna a Yale e ha da poco scritto il libro “L’esplorazione dell’universo. La rivoluzione che sta svelando il cosmo”. Guido Tonelli insegna fisica all’Università di Pisa e ha scritto “Cercare mondi. Esplorazioni avventurose ai confini dell’universo”, che sarà nelle librerie dal 23 febbraio. La Lettura ha pubblicato una conversazione tra i due: molti e interessanti i temi trattati e un bellissimo ed entusiasmante invito alle giovani menti. Ho reperito in rete il brano intero su  grande o piccola che sia, può reggersi senza porsi la grande questione: da dove veniamo e che ruolo abbiamo nel mondo. Intorno ad essa si costituisce l’impalcatura che regge i rapporti fra i vari gruppi sociali e regola quelli fra individui. Quella storia, sia essa mitica o materiale, fantastica o concreta, dona un senso alle nostre fragili esistenze, colloca in un contesto più ampio la nostra vita individuale. La ricerca scientifica più avanzata ci fornisce oggi un racconto meraviglioso delle nostre origini; ci costringe ad avventurarci in territori nei quali la mente rischia di perdersi, ma contiene visioni capaci di togliere il respiro.
grande o piccola che sia, può reggersi senza porsi la grande questione: da dove veniamo e che ruolo abbiamo nel mondo. Intorno ad essa si costituisce l’impalcatura che regge i rapporti fra i vari gruppi sociali e regola quelli fra individui. Quella storia, sia essa mitica o materiale, fantastica o concreta, dona un senso alle nostre fragili esistenze, colloca in un contesto più ampio la nostra vita individuale. La ricerca scientifica più avanzata ci fornisce oggi un racconto meraviglioso delle nostre origini; ci costringe ad avventurarci in territori nei quali la mente rischia di perdersi, ma contiene visioni capaci di togliere il respiro.

