
Due settimane fa, al Convegno Supereroi Fragili, organizzato dalla Erickson a Rimini, in molti interventi si è fatto riferimento alla serie 13, disponibile su Netflix. La sto guardando in questi giorni e proprio oggi è uscito su La Stampa un articolo di Alessandro D’Avenia con un notevole numero di spunti di riflessione, soprattutto per genitori, insegnanti e tutti gli adulti che incrociano le proprie strade con quelle degli adolescenti di oggi.
“Stavamo dialogando attorno al canto dell’Inferno dantesco dedicato al conte Ugolino, ed evidenziavo il fatto che Dante presenta un padre incapace di dare pane e parole ai suoi figli, condannati a morire da innocenti.
In un verso Dante descrive la tragedia della paternità sovvertita, quando Ugolino, guardando i volti dei quattro innocenti imprigionati con lui, dice di aver visto se stesso: sia perché vede in loro lo stesso dramma dell’inedia che li condanna a morte, sia perché vede in loro il frutto delle sue colpe. Moriranno a causa sua, e lui non se ne era reso conto, se non in quel momento, quando ormai è troppo tardi. Partendo da qui siamo arrivati a parlare di Thirteen reasons why: titolo di un fortunato libro negli Usa (Tredici in Italia), nonché di una ancora più fortunata serie televisiva che spopola tra i ragazzi e che, sollecitato da loro e interessato a capire dove cercano le parole e le immagini per raccontarsi, ho guardato nelle ultime settimane.
arrivati a parlare di Thirteen reasons why: titolo di un fortunato libro negli Usa (Tredici in Italia), nonché di una ancora più fortunata serie televisiva che spopola tra i ragazzi e che, sollecitato da loro e interessato a capire dove cercano le parole e le immagini per raccontarsi, ho guardato nelle ultime settimane.
Una ragazza si suicida, ha 17 anni, ma prima di mettere in atto il suo gesto estremo, incide 13 audiocassette, dedicate ciascuna alle tredici ragioni che l’hanno portata a togliersi di mezzo, ogni ragione corrisponde all’amico o amica, a cui è dedicato quel nastro. Così a poco a poco emerge la verità di una storia di violenza verbale e fisica, ampliata anche da chi si riteneva innocente. Sorprende scoprire che solo l’ultima cassetta è dedicata a un adulto, lo psicologo della scuola, che aveva parlato con la ragazza il giorno stesso del suo suicidio e non era stato capace di andare oltre quanto richiesto dal codice del suo lavoro.
Il ritornello che caratterizza tutta la serie è che la verità non è sempre quella che ci costruiamo per giustificare le nostre azioni e che il male che commettiamo o il bene che tralasciamo di fare hanno lo stesso peso.
Tutto ciò avviene ad una ragazza a cui non manca niente per essere felice, ma una somma di gesti malvagi o di gesti omessi da chi le vuole bene fa crollare una identità in formazione e quindi fragile. Questo il fascino esercitato sul pubblico di adolescenti: la percezione della distanza tra come ci si sente e come è la realtà, due dati che nella vita di un ragazzo sono spesso molto distanti e che portano gli adulti a non capire, liquidando le loro sofferenze ora come «paturnie dell’età», ora come «cose che un giorno capirai», ora come «la vita è fatta così, impara a starci».
Nella serie infatti l’assordante assenza è quella degli adulti, distantissimi anche se vicini, a volte incapaci di ascolto o di capire come ascoltare (la famiglia del protagonista deve formulare il proposito di fare almeno un pasto insieme dopo tre settimane…), a volte incapaci loro stessi di essere adulti.
È il protagonista della serie, un diciassettenne, a dover dire in modo chiaro allo psicologo: «Dovremmo imparare a volerci bene, in modo migliore». Ha capito che non basta il rispetto, non bastano le regole, che il consumismo relazionale è un veleno e che per volersi bene bisogna conoscere gli altri, conoscere il bene per gli altri, perché una relazione è vera solo quando si impegna a realizzare il bene dell’altro e ad accogliere l’altro come bene, non basta vivere sotto lo stesso tetto (familiare, scolastico…). È l’adolescente protagonista che impara che il bene dell’altro va fatto, a ogni costo, ed è lui a dover educare gli adulti sul tema.
Sono gli effetti di una società individualista, in cui i ragazzi non si sentono più parte di una storia, ma si riducono ad atomi incapaci di comprendere la realtà, perché nessuno gliene offre le parole adatte, ci si limita a insegnare delle regole per la vita e non cosa ci sia di buono da fare nella vita e a cosa servano quelle regole. Lo spaesamento narrato in questa serie solleva sin dal primo minuto la ferita aperta della società di oggi, quella americana sicuramente più avanti della nostra, ma neanche tanto: in un tessuto sociale disgregato e utilitarista, l’individuo è solo e non vale nulla se non si procura da solo il suo valore. La vita inserita in un sistema di performance in cui si è tanto quanto si ha, fa, appare, non c’è il tempo per costruire sull’essere, cosa che potrebbe avvenire in famiglia, unico luogo in cui essere accettati per quello che si è e non per quelle altre tre cose. Ma la famiglia non ha tempo per fare questo, oppressa anche lei da un meccanismo soffocante. Non c’è tempo per le relazioni buone, il tempo che permette di far emergere le ferite e le gioie, che va a costruire quel nucleo forte di amore da cui un bambino ed un adolescente imparano a guardare ed affrontare il mondo.
Il tempo delle relazione è spesso riempito da oggetti, silenzi, altre performance… che non lasciano lo spazio e i minuti necessari ad abbassare le difese e ad aprirsi. Persino l’assurda moda della Blue Whale – un gioco perverso che si conclude con il suicidio del partecipante – può riempire il vuoto di senso della propria esistenza, tanto da trasformarla in una performance sino alla autodistruzione: ci sarebbe da chiedersi come mai neanche la scuola sia più in grado di offrire un orizzonte di senso a questi ragazzi che vi passano per tredici anni tre quarti delle mattine. Continuiamo a produrre «educazioni a» affollando la loro testa di altre regole, impossibili da vivere perché non c’è una vita interiore, personale, unica e irripetibile, una storia in cui inserirle. Gli individui non hanno storie, le storie le hanno i ragazzi quando sono figli, nipoti, alunni… La passione per questa serie da parte dei ragazzi la tradurrei così: «Insegnateci a voler bene davvero, ridateci relazioni significative e non consumistiche, trovate il tempo da impegnare per noi come la cosa più importante che vi è capitata nella vita, guardateci, andate oltre le apparenze, consegnatemi il testimone della vita perché io cominci la mia corsa e sappia perché sto correndo».
La ragazza che si suicida dopo aver parlato con lo psicologo si ferma fuori dalla porta a vetri di lui e rimane ferma sperando che lui la insegua, andando oltre lo stretto necessario della chiacchierata appena affrontata. Lei afferma nella sua registrazione che se lui fosse uscito non si sarebbe uccisa, ma lui risponde al cellulare che aveva squillato già più volte durante il colloquio, interrompendo l’attenzione totale dovuta ad una ragazza in crisi, e dimentica quello che lei gli ha appena confidato: la mia vita non vale niente. Sceglie ciò che sembra più urgente, invece di quello che è importante (quanto tempo rubato alle relazioni dalla nostra iper-connessione). Tredici sono le ragioni per cui una ragazza si toglie la vita: e sono persone, cioè relazioni. Una è la ragione che le unifica tutte: la mancanza d’amore. L’amore è dare valore alle persone, e il valore sì dà solo quando si dona il proprio tempo a curare la relazione con l’altro, costi quel che costi. Dare tempo quando si è in tempo, altrimenti come Ugolino vedremo sul volto dei ragazzi ciò che noi stessi, senza rendercene conto, abbiamo provocato. Ma sarà troppo tardi.”






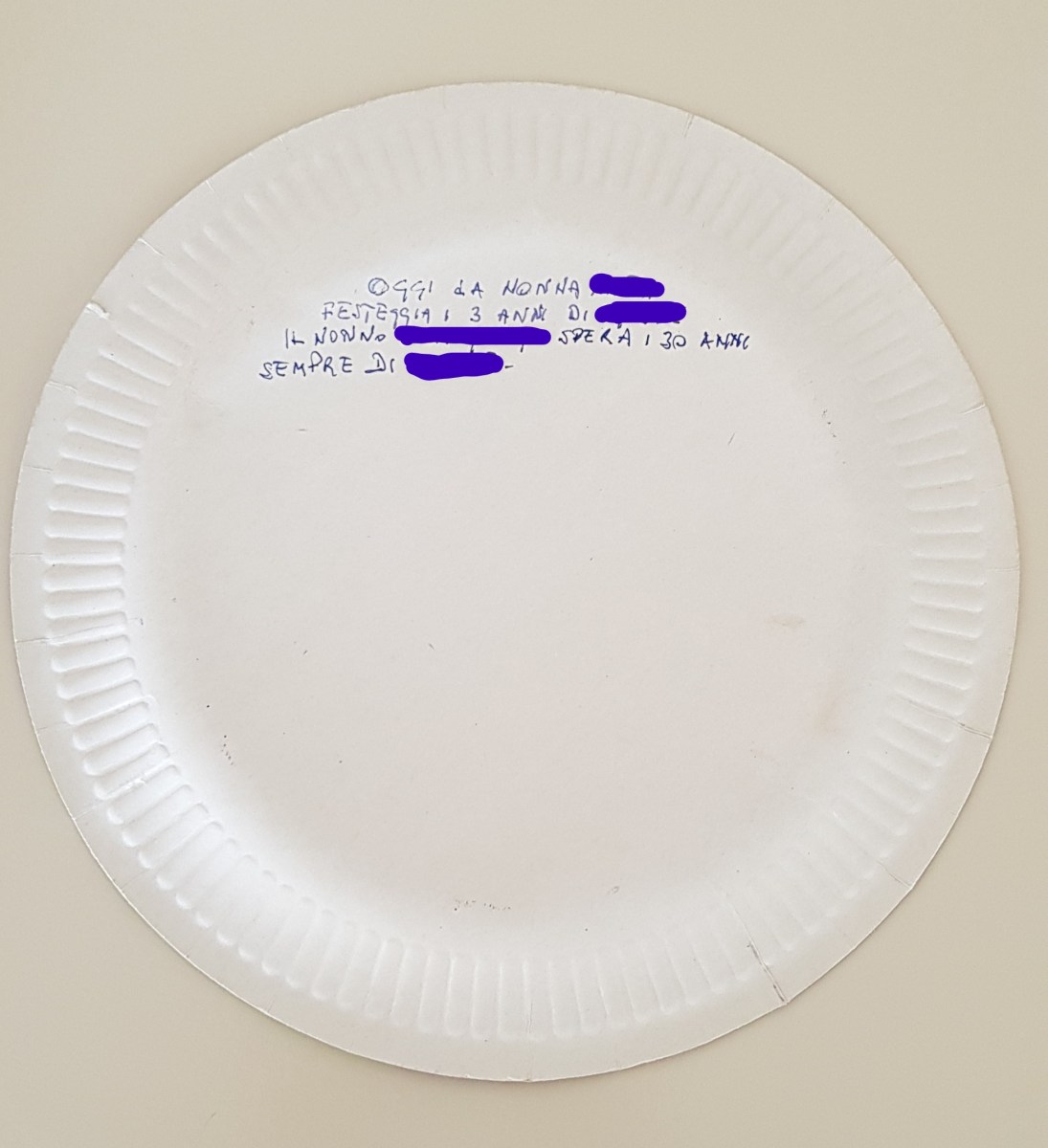





 arrivati a parlare di Thirteen reasons why: titolo di un fortunato libro negli Usa (Tredici in Italia), nonché di una ancora più fortunata serie televisiva che spopola tra i ragazzi e che, sollecitato da loro e interessato a capire dove cercano le parole e le immagini per raccontarsi, ho guardato nelle ultime settimane.
arrivati a parlare di Thirteen reasons why: titolo di un fortunato libro negli Usa (Tredici in Italia), nonché di una ancora più fortunata serie televisiva che spopola tra i ragazzi e che, sollecitato da loro e interessato a capire dove cercano le parole e le immagini per raccontarsi, ho guardato nelle ultime settimane.
