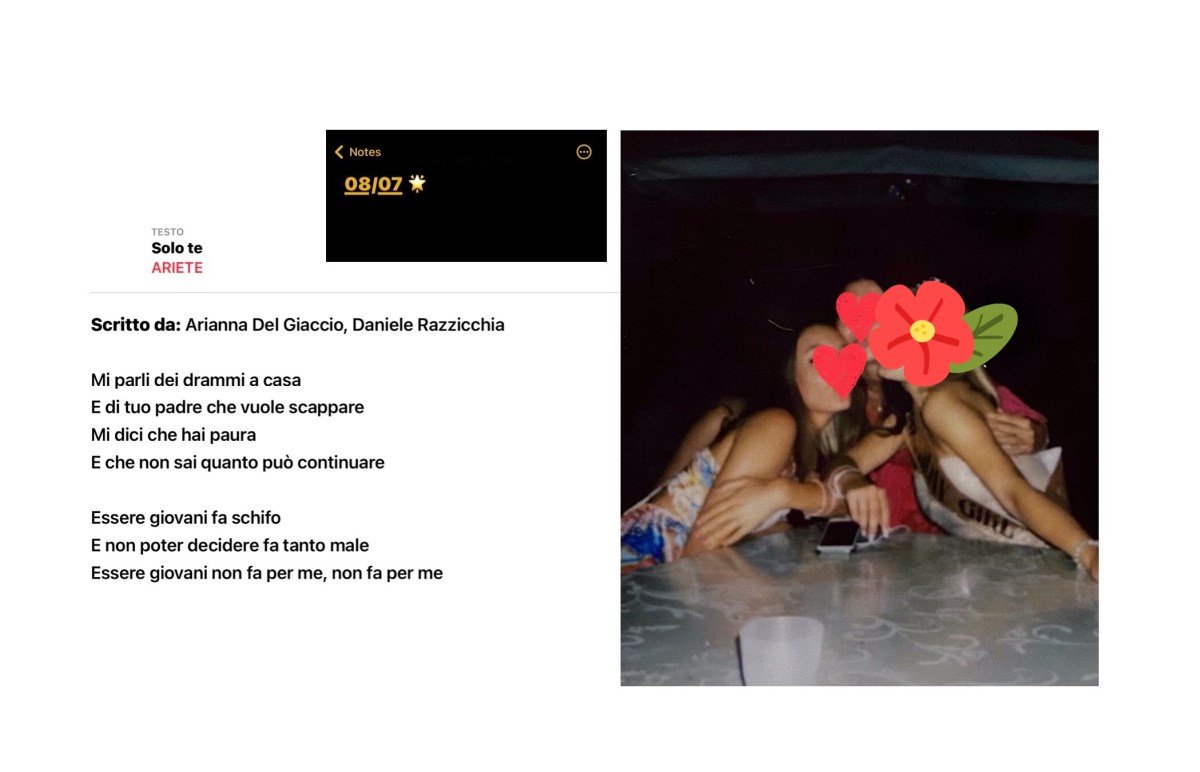“Dato che ormai siamo a fine novembre, ho pensato di portare come gemma un’immagine che possa rappresentare in qualche modo l’anno quasi giunto al termine.
Nel corso di questi mesi mi sono divertita un sacco, ho riso, mi sono emozionata, ho pianto tanto, ho conosciuto molte persone nuove, alcune delle quali sono rimaste fino a ora, altre invece se ne sono andate, ma soprattutto ho pensato. Forse troppo.
Ricordo che a febbraio ho portato come Gemma una nota scritta in un momento di debolezza in cui mi sentivo sopraffatta da tutto quello che stava succedendo, ma soprattutto che era successo e con cui non mi ero mai interfacciata, perché se c’è una cosa che ho capito, probabilmente con le cattive, è che tutto ciò che la vita ci presenta, ogni avvenimento, bello o brutto che sia, non può semplicemente essere ignorato nella speranza che passi da solo e che ce ne dimentichiamo, dato che prima o poi ritornerà, pronto a schiacciarci con il doppio, il triplo della potenza, fino a che non ci decidiamo finalmente a combatterlo una volta per tutte.
Ed è un po’ quello che è successo a me.
Io ho sempre amato passare del tempo da sola: per tutta la vita sono sempre stata abituata a gestire i miei tempi e spazi in armonia con me stessa e quando ciò è venuto a mancare, quando quell’equilibrio per qualche ragione si è spezzato, sono precipitata.
Inizialmente ho cercato di ignorare il problema nella vana speranza che se ne andasse da solo, ma quest’anno, ad un certo punto, quest’inutile fuga mi aveva talmente sfinito che ho dovuto dire basta.
Così ho iniziato a pensare, a riflettere, ad interrogarmi sul perché fossi arrivata fino a quel punto. Mi sono chiesta se avessi fatto qualche cosa di male, attribuendo inizialmente alle mie sensazione il titolo di “punizione”, per poi comprendere come stessi solamente cercando in tutti i modi di scappare da episodi che mi sono capitati e su cui non mi sono mai soffermata perché convinta che non avessero importanza o per cui non mi sentissi in diritto di stare male perché in fondo: “…tutti abbiamo i nostri demoni e chi sono io per lamentarmi dei miei quando ci sono persone che magari vivono cose più gravi della mia? Non ho assolutamente il diritto di lamentarmi!”.
Insomma, non mi sono mai presa del tempo per me stessa, per guarire ferite passate che hanno così, d’un tratto, sfondato la porta del mio cuore tutte in un colpo solo, senza nemmeno suonare il campanello e senza aspettare che io dessi loro il permesso per entrare.
Ho provato ad affrontare questa situazione da sola e ho dovuto combattere contro tutta me stessa per accettare il fatto che questo non sarebbe bastato, che non ce l’avrei fatta senza l’appoggio di qualcuno, così ho iniziato piano piano ad aprirmi con la mia migliore amica e, casualità, il destino mi ha fatto incontrare diverse persone che nel corso dei mesi ho cominciato a conoscere e con cui ho parlato come mai avevo fatto prima. Grazie a queste conoscenze ho cominciato a coltivare il rapporto più importante della mia vita, ossia quello con me stessa, andando alla scoperta di questa persona che ormai era diventata una completa estranea, a cui forse non avevo mai dato importanza, ponendola costantemente in secondo piano rispetto all’aiutare le persone che la circondavano, lasciando che la ferissero e incolpandola sempre e comunque per errori altrui.
Ebbene, penso che quello introspettivo sia il viaggio più terrificante che abbia mai fatto e che sto tuttora compiendo. Esso mi sfinisce, prosciuga tutte le tue energie, distoglie la mia concentrazione da altri ambiti della mia vita, come per esempio le amicizie, la scuola, lo sport, le relazioni, ma al momento non riesco a non essere egoista, perché per volersi bene, per capire di avere un valore, per comprendere che anche io merito di stare male e prendere del tempo per guarire dalle ferite, devo fare delle scelte e chiedermi quali siano davvero le mie priorità, a rischio di allentare la presa negli altri settori per mettermi al primo posto.
I pensieri sono qualcosa di veramente potente, che possono arrivare a schiacciarti, facendoti pensare di non potercela fare, di non essere abbastanza, ma con l’impegno e tanta forza di volontà, è possibile affrontare la tempesta, un passo dopo l’altro, senza farsi spaventare dalle aspettative o senza convincersi di dover soddisfare requisiti e obiettivi imposti da terzi, ma facendolo solo per se stessi e nessun altro, dedicandosi del tempo, tutto quello necessario, perché quando si tratta di stare bene non esistono scadenze e soprattutto non ci si può paragonare agli altri. E se un giorno lo passiamo nel letto sotto le coperte perché mancano le forze per fare qualsiasi cosa di “produttivo”, per così dire, va bene lo stesso, non dobbiamo pensare di essere una delusione per questo, perché non siano degli automi, ma proviamo delle emozioni che hanno tutto il diritto e la necessità di essere ascoltate, analizzate e interiorizzate.
Come ho già detto, quest’anno ho conosciuto un sacco di persone nuove, e non solo…sono anche entrata in contatto con dei lati di me che si sono manifestati in maniera sempre più invasiva nel corso dei mesi e con cui mi sono dovuta, e mi sto tutt’ora interfacciando, con non poca fatica.
Uno di questi tratti è sicuramente l’ansia. Tutto è iniziato con episodi sporadici in cui prima c’era un’alternarsi di emozioni, il respiro si faceva pesante e sempre più ravvicinato, la testa mi scoppiava e il cuore sembrava esplodere nel petto. Ad un certo punto però le cose hanno cominciato a cambiare, perché questi sintomi che sembravano spaventosi hanno lasciato il posto ad altri che mi hanno disorientata, mi hanno fatto completamente perdere la percezione della mia stessa esistenza, anche se devo dire che con il passare del tempo ho imparato perlomeno a riconoscerli. Al posto dell’iperventilazione e della tachicardia infatti gli occhi mi si sbarrano, ho bisogno di sedermi o di distendermi. Nella testa tuttavia questa volta non c’è un susseguirsi frettoloso e irrefrenabile di pensieri, ma essa risulta essere vuota. Provo a pensare a qualcosa, una cosa qualsiasi, anche la più stupida, ma niente, ciò mi risulta impossibile. Anche il cuore che prima batteva all’impazzata ora non lo riesco più a sentire. Metto una mano su di esso, ma inutilmente, non riesco a percepirlo, così mi tocco il polso, cerco l’arteria, ma ancora niente. NIENTE. Il nulla assoluto. Sono diventata improvvisamente un corpo che occupa un determinato spazio nel mondo, mi limito ad esistere in qualche modo.
Ho pensato molto a cosa possa innescare questi episodi che si presentano nelle maniere e nei momenti più svariati. Io non credo che le mani mi inizino a tremare a causa delle troppe cose da fare, di un compito da consegnare, di una partita da giocare, poiché sono tutti eventi che in sé non hanno nulla di particolarmente preoccupante, ma che in quel momento sembrano essere l’ostacolo più grande della mia vita. Anche adesso, ad esempio, mentre sto seguendo il flusso di pensieri che mi scorre nella mente, le mani hanno iniziato a tremare e sento crescere dentro di me quella sensazione d’ansia che oramai è diventata parte integrante delle mie giornate. Solamente l’idea, il lontano pensiero di dover guardarmi dentro mi mette una paura immensa e quello che mi terrorizza maggiormente è che non ho una vera risposta a queste reazioni, dunque non riuscendo ad individuarne chiaramente la causa profonda, non sto facendo altro che subire. Non riesco a fare niente perché tutto diventa un problema e fonte di preoccupazione, anche solo alzarmi per bere un po’ d’acqua, così preferisco restare ferma nella speranza che la sensazione passi.
Oltre agli attacchi di panico, ultimamente un’altra riflessione che mi scombussola la mente è il fatto che non riesco a pensare al futuro, a fare programmi che si spingono più in là di una settimana. Non penso che sia una problematica che concerne solamente me, anzi tutt’altro. Ritengo che sia un’incognita abbastanza diffusa tra i miei coetanei e solo il pensiero di trovarmi in una fase della mia vita in cui sono tenuta a compiere delle scelte che determineranno il mio futuro mi paralizza. Sono domande come “cosa farai all’università? Che lavoro vuoi fare?” che mi fanno impazzire a tal punto da immobilizzarmi, ma più che la mancanza di una risposta a questi quesiti, ciò che mi fa più male è la consapevolezza di non poter essere capita, perché vai tu a spiegargliela ai mie genitori questa assenza di speranza nel futuro, spiegagli tu come non conosco nemmeno il significato di tale termine che più che una speranza mi sembra un’utopia. Per loro la vita è sempre stata molto concreta, hanno sempre avuto la certezza che in qualche modo ce l’avrebbero fatta. Dopo la scuola si sarebbero trovati un lavoro, poi una moglie o un marito, avrebbero fatto una famiglia e una casa dove abitare con i bambini. Per la nostra generazione invece è tutto estremamente astratto e inafferrabile, abbiamo la testa piena di false promesse che non vengono mai seguite effettivamente dai fatti. La società oggigiorno ci impone un percorso prestabilito da seguire se vogliamo la possibilità di condurre una vita quantomeno dignitosa: asilo, elementari, medie, superiori, università, tirocinio, e poi… E poi? Poi la guerra, l’epidemia, il rintanarci sempre più in noi stessi e il trovarsi più a proprio agio a parlare tramite uno schermo perché il confronto reale genera panico e disagio. E allora che senso ha tutto questo? Ogni giorno veniamo bombardati da notizie di disordini sociali, catastrofi ambientali, conflitti imminenti, migliaia di vite spezzate perché uomini potenti fanno i capirci e giocano a farsi la guerra. È davvero questo il mondo in cui vogliamo vivere? L’essere umano fa davvero paura, ma se questo è la realtà odierna, a cosa mi serve sapere che quando è stata scoperta l’America o come si risolve un’equazione? “Ad imparare dagli errori passati ed evitare che essi vengano ripetuti”, risponde un adulto nella maggior parte dei casi, ma sono gli stessi adulti che stanno commettendo proprio in questo momento gli errori di cui hanno letto sui libri e discusso tra i banchi di scuola.
Forse sono pensieri più grandi di noi, di me, ma sono lì, nella mia testa e non posso ignorarli, anche perché spuntano continuamente facendomi perdere piano piano l’entusiasmo e la voglia di fare qualunque cosa, perché la risposta a tutto diventa: che senso ha?
Tutte queste preoccupazioni spesso mi portano a passare pomeriggi interi distesa sul divano a fissare il soffitto, incapace di fare o provare nulla perché in fondo che senso ha tutto questo? Cosa importa prendere dei bei voti se non riesco nemmeno a stare con me stessa? A cosa mi serve prendere un otto a scuola su un argomento che mi dimenticherò il giorno seguente se nella mia testa è inconcepibile anche solo pensare a cosa farò tra una settimana?
Per tanto tempo sono scappata da queste sensazioni devastanti e ora le sto affrontando tutte assieme. Non mi riconosco, non faccio nulla, “spreco” un sacco di tempo, non sono “produttiva”, ma cosa vuol dire in fondo essere produttivi? Svolgere compiti impartiti da terzi per sentirsi dire bravo o essere in pace con la propria coscienza, ma a che prezzo? A costo di perdere se stessi, di toccare il fondo e non sapere nemmeno di esserci perché c’è sempre qualcosa di più importante da fare piuttosto che curare se stessi?
Perché sì, non esiste solamente lo star male fisico, ma soprattutto quello mentale, cosa che ho impiegato tantissimo tempo anche solo ad ammettere a me stessa e che, non avendolo mai minimamente ascoltato, adesso mi ritrovo a chiedermi anche se sia reale o meno.
A volte l’unica cosa che vorrei è vomitare in faccia alle persone tutto il mio dolore, ma mi fermo sempre prima perché chi sono io per aggiungere pesantezza alla vita altrui? Tutti hanno i loro problemi, i loro demoni da gestire, non potrei mai essere così egoista, quindi in questo momento DEVO prendermi cura dell’unica persona che può salvarmi: me stessa. E se per fare questo devo rinunciare a rispettare le aspettative altrui su altri ambiti della mia vita, va bene. È arrivata l’ora di dare importanza anche a me, perché se non lo faccio io come posso solo minimamente pensare che lo facciano gli altri?” (R. classe quinta).