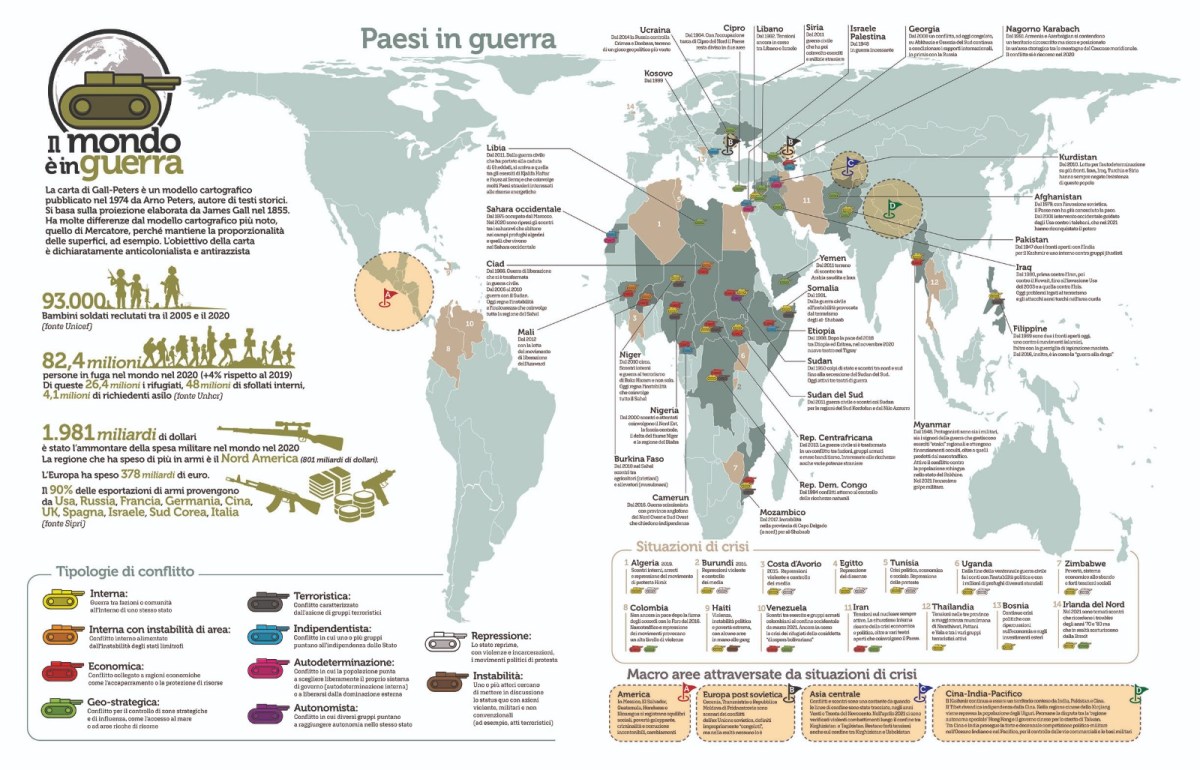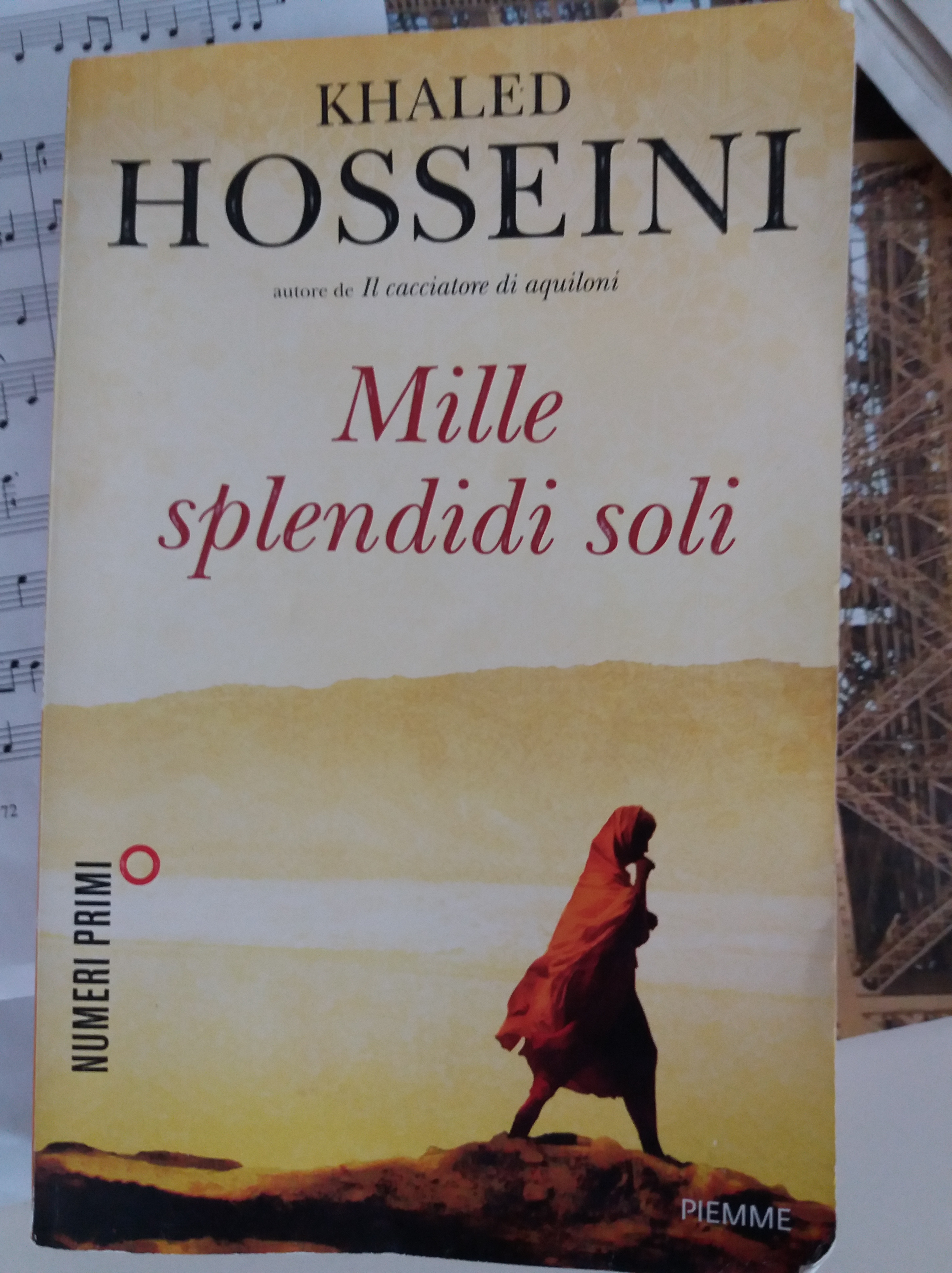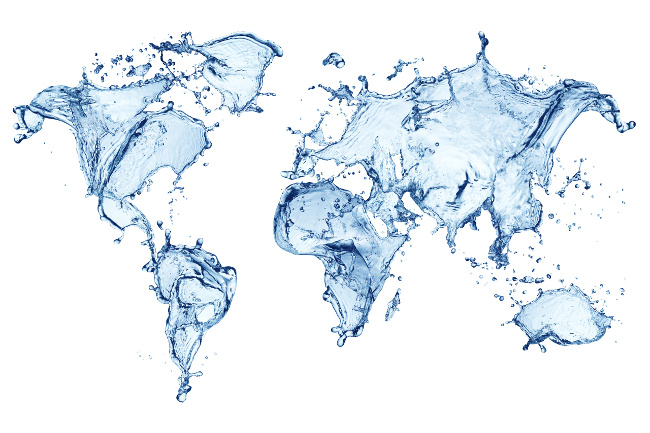Il 24 gennaio di quest’anno abbiamo ospitato a scuola il giornalista Marco Omizzolo, docente di Sociopolitologia delle migrazioni alla Sapienza di Roma, presidente di Tempi Moderni e ricercatore Eurispes; ha lavorato come bracciante infiltrato per studiare lo sfruttamento dei migranti da parte delle agromafie. In Aula Magna ci aveva a lungo parlato della situazione dell’Agro pontino e aveva spesso fatto riferimento alla morte di Satnam Singh, avvenuta nel mese di giugno del 2024. A giugno di quest’anno, su Il Post, è uscito un articolo di Angelo Mastrandea che fa un bilancio della situazione a un anno di distanza. Ecco qui.“La mattina del 12 giugno 2025 alcuni ispettori del lavoro sono entrati in un terreno agricolo nella campagna di Sermoneta, in provincia di Latina, dove 10 indiani provenienti dal Punjab stavano preparando la raccolta delle zucchine. Solo uno di loro aveva un contratto, ma con un’azienda agricola di Terracina, a 50 chilometri di distanza. Gli altri erano tutti in nero. Il proprietario del terreno si è giustificato dicendo che erano stati loro a presentarsi da lui chiedendogli di lavorare e che quello era il loro primo giorno di lavoro, e per questo non aveva ancora fatto in tempo a contrattualizzarli. Gli ispettori del lavoro sono andati avanti con il verbale e hanno chiamato la polizia per gli accertamenti sulla regolarità dei permessi di soggiorno. Nel frattempo, un lavoratore ha chiesto aiuto con un messaggio su WhatsApp a Laura Hardeep Kaur, che è la segretaria del sindacato del settore agricolo FLAI CGIL di Latina, è nata in Italia da genitori provenienti dal Punjab e parla la loro lingua.
La sindacalista è corsa a Sermoneta, dove la polizia aveva identificato tutti i lavoratori. Solo due di loro avevano un permesso di soggiorno valido. Gli altri otto invece avevano mostrato dei documenti falsi: c’erano le loro foto, ma i nomi e le impronte digitali non corrispondevano. «Tranne uno di loro che è arrivato a piedi attraverso la rotta balcanica, gli altri erano venuti in Italia con un volo regolare, chiamati da un datore di lavoro con il decreto “Flussi”, che regola l’ingresso dei lavoratori stagionali in Italia, com’è possibile che i permessi di soggiorno fossero falsi?», si chiede.
Gli agenti volevano avviare una procedura di espulsione e nel frattempo mandarli nel CPR di Brindisi, uno dei Centri di permanenza per il rimpatrio. Kaur si è opposta spiegando che a gennaio i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di Finanza, la procura di Latina, l’ASL e l’Ispettorato territoriale del lavoro avevano firmato un protocollo d’intesa che prevede, per chi viene trovato in una situazione di sfruttamento lavorativo, l’avvio di una procedura speciale per il permesso di soggiorno. In totale, in sei mesi ne sono stati rilasciati una ventina. Anche l’ospedale, se arriva una persona infortunata, può decidere di avviare un percorso di tutela. È una misura che venne presa sull’onda dell’impatto emotivo provocato dalla morte di Satnam Singh, il lavoratore indiano che venne mutilato nei campi di Borgo Santa Maria, e che morì il 19 giugno 2024. La sua morte fece impressione, a Latina ci furono scioperi e manifestazioni dei braccianti e della comunità indiana. Ma un anno dopo «tutto è tornato com’era prima», dice Kaur.
Alla fine tutti i lavoratori di Sermoneta sono stati rilasciati. L’imprenditore agricolo invece ha ricevuto una multa di 50mila euro per lo sfruttamento della manodopera e per la violazione delle norme sulla sicurezza, perché i lavoratori avevano ciabatte ai piedi e prima di essere impiegati non avevano fatto nessun corso di formazione, come prevede la legge.
Kaur è abituata a questo tipo di interventi: il suo numero di cellulare gira tra i lavoratori indiani, che quando hanno un’emergenza sul lavoro le scrivono o la chiamano. Il 17 giugno del 2024 fu la prima persona a essere avvisata di quello che era accaduto a Singh.
«Mi arrivò una foto con un braccio in una cassetta, la posizione e il messaggio “corri incidente”. Pensavo che fosse un macabro scherzo, invece arrivai prima dei carabinieri e mi trovai di fronte a una scena agghiacciante», ricorda. Singh era stato appena scaricato dal suo datore di lavoro, Antonello Lovato, davanti all’abitazione in cui alloggiava, dopo che una macchina avvolgiplastica artigianale gli aveva tranciato un braccio mentre lavorava nella sua azienda. A mandare il messaggio fu uno dei lavoratori, un indiano, che aveva assistito all’incidente. I cellulari del giovane ferito e della sua compagna Soni, che lavorava con lui, invece sparirono e non sono più stati trovati. Satnam Singh fu portato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, ma non ci fu modo di salvarlo.
Lovato è sotto processo per omicidio volontario. Finora si sono svolte due udienze, nelle quali sono stati ascoltati alcuni testimoni. Durante la prima udienza, il proprietario della casa in cui Satnam Singh viveva da un anno e mezzo, Ilario Pepe, ha raccontato che quel giorno chiese a Lovato perché lo stava abbandonando lì in quello stato, e che l’imprenditore gli rispose con tono tranquillo «perché non è in regola». Poi si allontanò in fretta con il furgone, lasciando in strada la cassetta con il braccio mozzato. All’udienza successiva Lovato ha detto di voler risarcire la famiglia della vittima.
Soni invece è stata sentita durante l’incidente probatorio, un’udienza per anticipare l’acquisizione delle prove, durante la fase delle indagini preliminari. Ha raccontato ai magistrati che Singh, già esanime, fu «buttato» giù dal furgone e batté «la testa contro un cordolo di cemento». Nei mesi scorsi ha testimoniato anche in un’altra indagine in cui sono coinvolti Antonello Lovato e suo padre Renzo: alla fine di gennaio sono stati indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per aver fatto lavorare in nero 7 braccianti, tra cui Soni. La donna ha raccontato di essere arrivata in Italia con Singh passando per la Croazia e di aver vissuto tra Trieste e Milano. Poi i due pagarono 800 euro a un caporale indiano per andare a lavorare in un allevamento di bufale a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta. Lì erano impiegati dalle 2:30 del mattino alle 12:30. Lei guadagnava 700 euro al mese, Singh invece 800. A luglio del 2022 decisero di spostarsi a Latina per cercare un lavoro un po’ meno faticoso e pagato meglio.
Nel giro di un mese furono assunti alla Agrilovato. La paga, in nero, era di 5,50 euro all’ora, che dopo un po’ furono aumentati a 6 euro. Lovato segnava le ore e il compenso su un quadernetto. Ogni mattina alle 5:30 uscivano di casa per andare al lavoro in bicicletta. Percorrevano 15 chilometri in meno di un’ora. Finivano di lavorare alle 17 e un’ora dopo erano a casa. Ora Soni vive in una struttura protetta gestita dal comune di Latina. Riceverà metà dei 365mila euro raccolti dalla CGIL dopo la morte di Singh, mentre il resto andrà alla famiglia d’origine del suo compagno, in Punjab. Il Post l’ha incontrata il giorno dell’anniversario dell’incidente.
Laura Hardeep Kaur racconta che casi come quello di Sermoneta sono «la normalità», perché i piccoli imprenditori che hanno bisogno di qualche lavoratore si rivolgono a un «fornitore di braccia», di solito un indiano che parla italiano, che glieli porta e negozia un pagamento a giornata, senza nessun contratto.
«Nei primi mesi dopo l’incidente a Satnam, le aziende hanno mandato a casa i lavoratori in nero perché temevano i controlli o li hanno assunti», aggiunge il segretario regionale della FLAI CGIL Stefano Morea. «Ma le storture del modello di produzione agricola non sono cambiate, e dopo un po’ molte hanno ricominciato a far lavorare le persone in nero». In appena un mese, dopo la morte di Singh, in provincia di Latina sono state registrate 7.368 assunzioni a tempo determinato, quasi il doppio dell’anno precedente, segno che molte aziende si sono precipitate a regolarizzare i lavoratori in nero.
Morea dice che si è modificato solo il sistema economico: non si vedono più i pulmini dei caporali davanti ai Centri di accoglienza straordinaria (CAS), dove venivano reclutati i richiedenti asilo, soprattutto africani, che erano pagati ancora meno degli indiani. Ora il caporalato guadagna dalla gestione dei flussi: arruolano le persone in Punjab, facendosi pagare in media 10mila euro per il viaggio e la richiesta di lavoro. «Si indebitano tutti e non hanno i soldi per tornare in India quando il lavoro finisce, per questo rimangono qui e finiscono nel circuito del nero». Funziona in questo modo: i datori di lavoro presentano la domanda nei cosiddetti click day, i lavoratori arrivano con un regolare visto, poi dovrebbero firmare il contratto e ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Nella realtà solo in pochi ci riescono. In provincia di Latina, appena il 7,8 per cento dei migranti arrivati con il decreto “Flussi” ottiene il permesso di soggiorno.
Nell’Agro pontino, l’ampia zona agricola a sudest di Roma, ci sono 6.500 imprese agricole di diverse dimensioni, e nonostante la prefettura abbia istituito una “task force” per i controlli, con ispettori del lavoro e forze dell’ordine, è difficile controllarle tutte e verificare che anche i contratti, quando ci sono, non siano regolari solo sulla carta. I sindacalisti lo definiscono «lavoro grigio». Il sociologo Marco Omizzolo, che ha fatto moltissime ricerche sugli indiani del Punjab che lavorano nel Lazio, sostiene che i controlli dopo la morte di Satnam Singh abbiano impoverito i braccianti mandati a casa dalle aziende. Quando il lavoro è ripreso hanno accettato di lavorare a condizioni ancora peggiori.
Alla CGIL spiegano che gli accordi tra aziende e caporali vengono fatti in base al cosiddetto salario “di piazza”, cioè a una sorta di borsa informale che cambia di zona in zona e prevede in ogni caso un pagamento inferiore a quello previsto dai contratti del settore. In questo momento in media varia tra i 4 e i 5 euro all’ora, a seconda dell’area e della capacità di contrattazione del caporale.
«Per sfuggire ai controlli, molte aziende più grandi e strutturate hanno ideato con l’aiuto di avvocati e commercialisti un sistema più sofisticato di sfruttamento: prevede un contratto di lavoro per pochi giorni regolarmente retribuito, ma in realtà i lavoratori sono impiegati a tempo pieno», dice Omizzolo.
Un lavoratore indiano residente a Roccagorga, un altro comune della provincia, mostra la sua busta paga. Il compenso netto è di 325 euro, per cinque giorni di lavoro in un mese. Di questi, 50 euro sono indicati come rimborso spese per trasferta, sui quali non si pagano tasse né contributi. Il bracciante in realtà è impiegato per almeno 10 ore al giorno, tutti i giorni, ma nel caso di un controllo risulta in regola. In molti casi, e nei periodi di lavoro più intenso, si arriva fino a 14 ore al giorno. Alla CGIL la definiscono una busta paga costruita al rovescio, partendo dal compenso pattuito e non dalle ore e dai giorni effettivi di lavoro.”